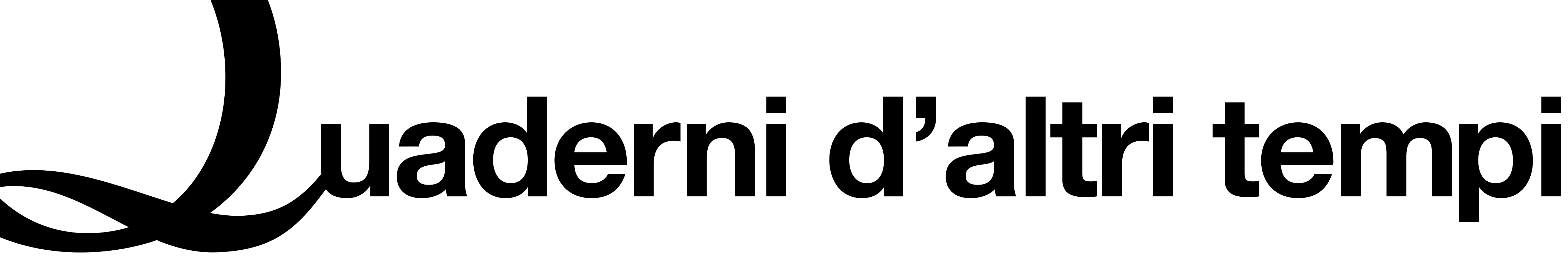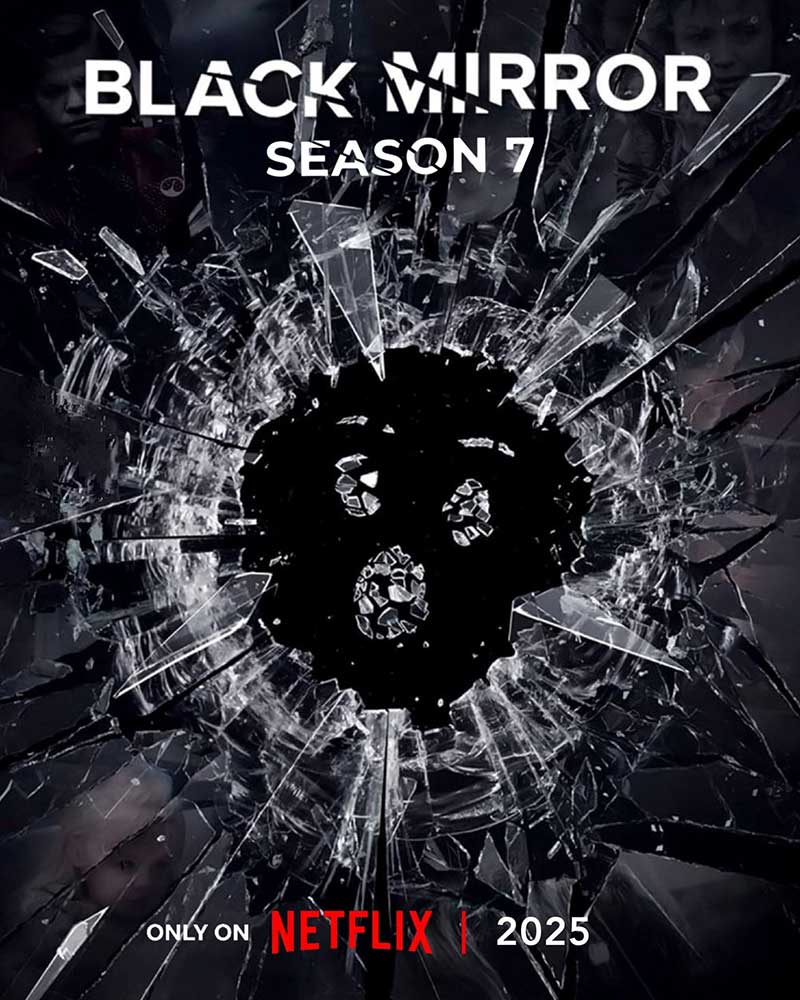*La nostra cultura, ormai così intensamente tecnologica, può essere definita narcotica. Marshall McLuhan fa riferimento al mito di Narciso per spiegare questo concetto (cfr. McLuhan, 2024). Il giovane che scambiò la propria immagine riflessa nell’acqua per un’altra persona, innamorandosene perdutamente, rimase del tutto ipnotizzato da quella che non si era reso conto essere in realtà un’estensione di sé. Fu esattamente questa la causa della sua rovina, che la ninfa Eco non poté evitare pur tentando di conquistare il suo amore allontanandolo dal suo riflesso. Narciso era ormai diventato uno schiavo di sé stesso. Il senso del mito, ci spiega McLuhan, è che gli umani sono profondamente attratti dal “fascino di ogni estensione di sé, riprodotta in un materiale diverso da quello stesso di cui sono fatti” (ibidem). È spiegato dagli studiosi di medicina Hans Selye e Adolphe Jonas il motivo per cui le estensioni di noi stessi determinino la sensazione di torpore (ibidem). Ogni estensione è in realtà assimilabile a un’auto-amputazione, la cui diretta conseguenza è uno stato di irritabilità e disagio, che viene colmato proprio dal torpore. È quindi un tentativo di conservare uno stato di equilibrio altrimenti perso, di ritrovare un’immagine tangibile di quella parte di sé ormai perduta. La tecnologia diventa per noi in tempi odierni un’estensione del nostro essere, come lo era il riflesso di Narciso per il ragazzo. In questo contesto, Black Mirror si presenta come un universo capace di racchiudere e rappresentare le tensioni della nostra epoca. Ideata e prodotta da Charlie Brooker, questa serie antologica dà forma alle angosce che accompagnano la nostra generazione relativamente all’uso della tecnologia. La settima stagione, con un incredibile riavvicinamento alle origini della serie, si propone come un nuovo accattivante racconto delle terribili e angoscianti conseguenze che le storture della tecnologia possono provocare su noi esseri umani, non dimenticandosi però di tenere conto delle emozioni, ciò che, del resto, è quello che ci rende tali: umani.
Tra bit e battiti
Se volessimo tentare una classificazione degli episodi di Black Mirror, potremmo identificare diverse tipologie di tecnologie: quelle legate alla relazione col bios, quelle legate alla relazione con la realtà circostante e quelle connesse alla possibilità di manipolare la dimensione spazio-temporale. Ciò che emerge dalla visione di alcuni episodi in particolare, è il tentativo della serie di esplorare il rapporto delle protesi tecnologiche e le dinamiche tra gli individui, così come il mondo che essi abitano. Identificate le creazioni tecnologiche come estensioni dell’essere umano, è interessante esplorare la relazione della teoria mcluhaniana con alcuni episodi della nuova stagione. In Hotel Reverie e Eulogy, l’estensione del corpo umano nelle tecnologie si coniuga con l’esplorazione della realtà virtuale da parte dei protagonisti, seppure per motivazioni differenti. In ciascuno dei due episodi è necessario l’utilizzo dell’ormai ricorrente dispositivo accessorio che, una volta posizionato sulla tempia, permette l’accesso al mondo alternativo. Come spesso accade in Black Mirror, viene esasperato il concetto di influenza della tecnologia sull’essere umano: i dispositivi non si limitano solo a mediare un’esperienza, ma sono in grado di intaccare l’identità di coloro che la vivono, alterando le loro percezioni, i loro ricordi, i loro legami affettivi. Gli episodi pongono in dialettica la sfera della fisicità con quella del virtuale, attraverso due rappresentazioni differenti, ma accomunate dalla stessa dinamica di fondo. La realtà virtuale non si presenta come semplice evasione dal reale, bensì come sostituzione della realtà corporea, configurandosi come uno spazio in cui i protagonisti possono giungere a una più profonda presa di coscienza del proprio sé e delle proprie relazioni. La chiave di volta dei due episodi è, infatti, il percorso di crescita interiore dei due personaggi. Come però già accennato, le due esperienze restano profondamente diverse.

In Hotel Reverie, ReDream è una tecnologia innovativa che permette alla star di Hollywood Brandy Friday (Issa Rae), di reinterpretare in modo rivoluzionario un classico film romantico. Le riprese non avvengono in modo tradizionale, ma impiantando la sua coscienza direttamente all’interno del film, interamente ricostruito grazie all’intelligenza artificiale, dalla scenografia fino ai personaggi. Per portare a termine l’esperimento, Brandy è chiamata a recitare il copione originale del film, interagendo con le ricostruzioni artificiali dei personaggi, i quali però ignorano di essere parte di una ripresa cinematografica. Diversamente, Eulogy è una compagnia il cui obiettivo è costruire memoriali per le persone defunte, attraverso fotografie di ricordi di chiunque scelga di contribuire. Phillip (Paul Giamatti) viene contattato a seguito della morte della sua ex ragazza Carol. Analogamente all’episodio precedente, la tecnologia entra in funzione attraverso il chip, ma questa volta il processo avviene in modo leggermente diverso. Una guida digitale accompagna il protagonista nel suo viaggio verso il ricordo di Carol, di cui Phillip sembra aver volutamente rimosso il volto, permettendogli di entrare virtualmente nelle foto che lui ha conservato del tempo trascorso insieme. Nonostante le loro unicità, è interessante evidenziare come i due episodi presentino diversi punti di contatto. Al momento dell’attivazione del chip, che si trasforma in un vero e proprio prolungamento della fisicità della protagonista, il corpo di Brandy appare quasi privo di vita. La sua coscienza viene trasferita nel mondo virtuale di Hotel Reverie, un universo in bianco e nero in cui i confini tra realtà e finzione si fanno sempre più labili e indeterminabili. A testimoniarlo sono le battute recitate dalla stessa Brandy, che man mano che trascorre il suo tempo con Clara, l’attrice protagonista del film, fatica sempre di più a seguire il copione originale. Le loro conversazioni cessano di essere sotto il controllo degli sceneggiatori che osservano gli schermi, mentre Clara sembra rivelarsi ben più di una semplice identità generata da un algoritmo. Sembra umana, reale.

Ma quanto può esserci di “reale” in un mondo interamente digitalizzato? Ancora di più, cosa è giusto considerare autentico, in una realtà che non è altro che una riproduzione di un vecchio film? Brandy sicuramente lo è, nelle sue battute spontanee e improvvisate. Forse lo è anche la figura di Clara, in cui riecheggiano frammenti di memoria della defunta attrice che un tempo la interpretava, Dorothy. E sicuramente lo è il loro amore. Sulle note di San Junipero (Black Mirror, 3×04), la serie torna a esplorare il legame tra due donne lontane, questa volta non separate solo dallo spazio, ma anche dal tempo, con un risvolto forse più amaro rispetto al tentativo precedente. Brandy resta intrappolata nel programma a causa di un improvviso malfunzionamento, che blocca le riprese del film rendendo proprio lei e Clara le uniche presenze attive e coscienti all’interno della simulazione. Il tempo scorre e l’attrice hollywoodiana è totalmente immersa nel nuovo universo, non più semplicemente con il corpo, ma anche con i sentimenti. Ogni momento condiviso con Clara la segna nel profondo, legandola irrimediabilmente a lei e facendole forse quasi dimenticare che, fuori da quella realtà artificiale, esiste ancora un mondo reale. Un mondo in cui il suo corpo giace immobile su un tavolo, abbandonato a un dispositivo che la tiene sospesa, ancorata a un universo che sente più reale di quello che ha lasciato. È questo sentimento che la porta ad accarezzare l’idea di non pronunciare l’ultima battuta del copione, condizione necessaria per abbandonare la simulazione del film. Ma, a differenza di quanto accade in San Junipero, dove Yorkie e Kelly possono scegliere di rimanere per sempre insieme in un mondo virtuale, la coscienza di Brandy non è destinata a rimanere insieme alla sua amata.
Ciò che succede a Phillip in Eulogy, invece, prende una direzione totalmente diversa. Visibilmente scioccato dalla notizia della morte di Carol, l’uomo accetta di partecipare al progetto per la creazione del suo memoriale. Tuttavia confessa alla sua guida virtuale di avere solo tre foto che documentino dei momenti trascorsi con lei. È esattamente questa scarsità di materiale, però, a rivelarsi essenziale nell’esperienza di Phillip. Grazie alla tecnologia il protagonista può letteralmente entrare nelle foto, muovendosi tra istanti sospesi, tra figure immobili e sfuocate o cancellate con un pennarello, tra dettagli nitidi solo fin dove arriva la sua memoria. La realtà e l’ambiente si ricostruiscono intorno a lui in modo frammentario, incompleto. La mancanza di ricordi tangibili diventa il simbolo di un legame probabilmente rimosso nel tempo per proteggerne la fragilità, o, forse, per proteggere sé stesso dal dolore e dalla verità di quanto era veramente accaduto tra lui e Carol.

Presto scopriamo che le prime tre polaroid che Phillip ha mostrato non sono tutto ciò che ha conservato. Il volto di Carol continua a mancare, come un vuoto incolmabile, un tassello di un puzzle volontariamente rimosso. Ma attraverso una canzone, un colore, lui tenta di ricostruire ogni fase della loro relazione, raccontando la sua verità. L’esperienza virtuale, più che offrire conforto, costringe Phillip a confrontarsi con i vuoti della sua memoria e con l’assenza, con tutto ciò che non ha mai detto, mai fatto, mai realmente affrontato. Ma a differenza di Brandy, che rischia di rimanere intrappolata nella simulazione, scegliendo di abbracciare un amore appena nato ma intensamente vissuto, Phillip è già prigioniero. Intrappolato nella realtà che la sua mente ha costruito col passare degli anni. Una realtà distorta, selettiva, in cui ha scelto di dimenticare o di non vedere alcuni frammenti del suo rapporto con Carol, una realtà che possa perpetuare solo un ricordo parziale della loro storia.
Black Mirror ci racconta questa volta un viaggio diverso reso possibile dalla tecnologia: il viaggio intimo e tormentato nell’animo umano. Phillip non viaggia solo attraverso i suoi ricordi, nella disperata ricerca del volto di Carol, all’apparenza perso per sempre. Si addentra nel profondo del suo animo, nei suoi rimpianti, nelle sue decisioni affrettate e nelle sue convinzioni forse errate, nate da fortuiti e dolorosi malintesi. Un percorso che culmina nell’amara realizzazione di non aver sempre custodito la verità assoluta e con essa che, forse, se avesse spostato anche solo un singolo tassello del puzzle, l’intero disegno della sua vita avrebbe potuto avere sfumature diverse.
Vita o sopravvivenza?
La tecnologia e il suo totalizzante utilizzano portano, come già evidenziato, a un impatto significativo sull’identità, sulla coscienza umana e sulle relazioni che i protagonisti intrattengono con il mondo e le persone che li circondano. Tuttavia, con l’episodio Gente comune, Black Mirror propone un ulteriore spunto di riflessione. La tecnologia si presenta questa volta come miracolo terapeutico. Quando Amanda viene colpita da un improvviso e incurabile tumore al cervello, la tranquilla e serena vita di lei e suo marito Mike subisce un drastico cambio di rotta. Dilaniato dall’idea di perdere la moglie, Mike accetta il programma sperimentale di una start-up medica, Rivermind. L’intervento prevede l’asportazione della parte malata del cervello di Amanda, sostituita con un impianto neuronale connesso a una copia digitale della sua mente, trasferita e conservata in un server. Il mantenimento dell’impianto è possibile però solo tramite un abbonamento mensile di 300 dollari. Se in un primo momento la vita della coppia sembra aver ritrovato la normalità, non passa molto tempo prima che quella che appariva come una cura miracolosa, si riveli una condanna. Le funzionalità del piano acquistato diventano presto obsolete, iniziando a causare non pochi problemi, e questo costringe Mike a fare l’impossibile pur di racimolare i soldi necessari per gli aggiornamenti. Di nuovo Black Mirror, con una dialettica raffinata, intreccia realtà diverse in un nodo che ci lascia senza fiato dall’inizio alla fine. E probabilmente, pur nei suoi toni dichiaratamente distopici e assurdi, questo è l’episodio che più riesce a penetrare nei nostri animi. Ciò che colpisce è la vicinanza tra gli spettatori e i protagonisti. Si chiamano Amanda e Mike, ma loro sono, appunto, gente comune. Cosa li differenzia da noi che sediamo davanti a uno schermo a guardare la loro storia?

C’è una crudeltà silenziosa e implacabile nel modo in cui le vicende si dispiegano. Le azioni disperate di un uomo che si aggrappa all’ultima ignota speranza per salvare sua moglie, si trasformano nella sua rovina. È come se Mike avesse firmato un patto col diavolo, del tutto inconsapevole della discesa verso gli Inferi che ne sarebbe conseguita. Ma la vera crudeltà sta nella realizzazione di ciò che spinge Mike ad agire. Il suo legame con la tecnologia non è dettato dalla tracotanza o dalla brama di potere di Faust nel suo celebre patto con Mefistofele (cfr. Marlowe, 2017). Mike è mosso dall’amore. Il suo è un tentativo disperato di avere più tempo con Amanda, per non doverla abbandonare prima del necessario. Il sistema che li circonda, però, rende loro impossibile amarsi nel modo giusto. Amanda e Mike vengono risucchiati dai sacrifici che sono costretti a compiere per poter semplicemente sopravvivere. In questo contesto, il ruolo di Rivermind assume un peso enorme, tanto per loro quanto per noi spettatori. È l’emblema, portato all’estremo, di una società basata su abbonamenti e microtransazioni. Rivermind “agisce creando dipendenza nei suoi stessi utilizzatori” (Fisher, 2018), e Amanda e Mike sono le vittime perfette: non possono semplicemente disdire il loro abbonamento, perché farlo significherebbe condannare Amanda alla morte. In questo modo, il programma si configura come un perfetto strumento capitalistico, che mette in luce le storture di una società in cui si è costretti ad annaspare per restare a galla. A ciò si aggiunge naturalmente l’invasività dell’impianto stesso: tra annunci pubblicitari intrusivi e ore di sereno riposo negate, si insinua nella personalità di Amanda al punto da comprometterne l’identità e farle smarrire sé stessa.
Narcosi e tecnologia: futuro o presente?
È evidente la capacità della serie televisiva di analizzare il futuro della nostra società in un modo che, per quanto distopico, risulta essere estremamente vicino alla realtà della nostra quotidianità. Le storie raccontate sono narrazioni estreme ma spaventosamente in linea con le nostre esperienze e ci spingono a riflettere su quanto effettivamente sia la tecnologia a nostro servizio e quanto, al contempo, stia trasformando la nostra società in modi non sempre prevedibili e desiderabili. La serie ci offre uno specchio deformante, ma mai del tutto irreale, in cui si riflettono i cambiamenti delle nostre abitudini, dei nostri valori, e, soprattutto, delle nostre relazioni. L’influenza della tecnologia sulla nostra identità, sui legami affettivi è esasperata, ma sempre più tangibile nella vita reale. Siamo ancora noi esseri umani i padroni della tecnologia oppure è lei che, inesorabile come un titano, detiene il pieno controllo su di noi?
*Questo articolo è l’esito di un lavoro di ricerca svolto all’interno del corso di “Storia e teoria dei media” tenuto da Antonio Rafele presso l’Università La Sapienza di Roma.
- Mark Fisher, Realismo capitalista, Produzioni Nero, Roma, 2018.
- Christopher Marlowe, Il Dottor Faust, Mondadori, Milano, 2017.
- Marshall McLuhan, Gli strumenti del comunicare, Il Saggiatore, Milano, 2024.