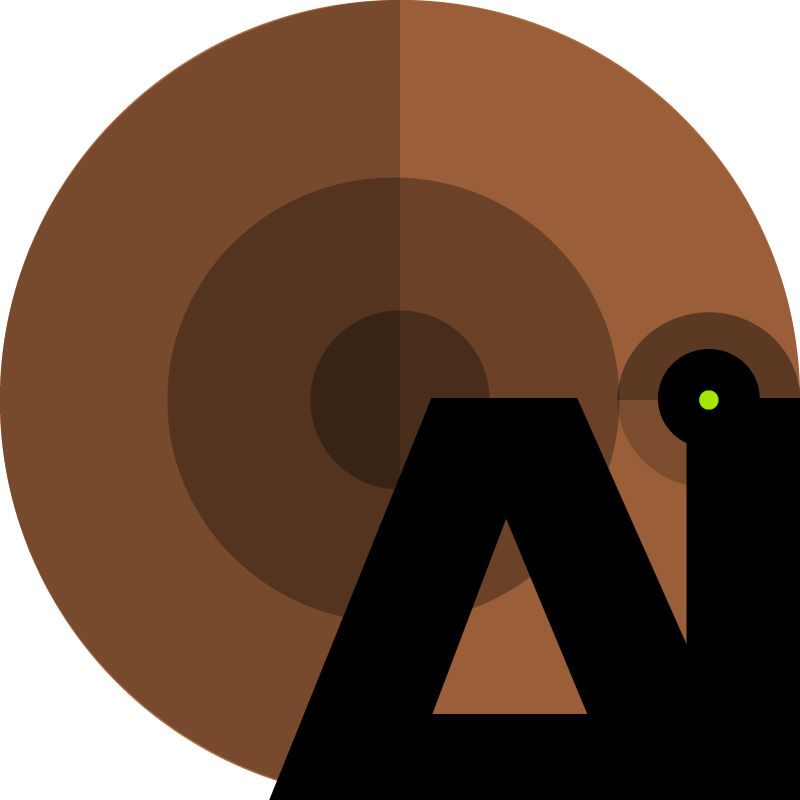Spike Jonze
Her, 2013
Casa di produzione: Annapurna Pictures
Distribuzione Italia: Bim, 2014 (home video)
L’uscita di Blade Runner 2049 di Villenueve (2017) ha mobilitato studiosi e appassionati che si sono pronunciati sulla qualità del nuovo prodotto, sull’opportunità delle scelte del regista, sul fatto che avrebbe potuto essere scritto in modo diverso, più in continuità o più in discontinuità con il primo episodio. Numerosi articoli si sono susseguiti nelle riviste online per denunciare i difetti di produzione del nuovo film: dalla presunta misoginia che si manifesta in ruoli femminili degradanti al razzismo di sottofondo che farebbe incetta di ambienti asiatici senza però mettere in scena persone etnicamente riferibili a quei contesti. Per altri Denis Villeneuve avrebbe voluto semplicemente dirigere un film diverso ma non ha potuto farlo per varie ragioni.
Al di là di questioni stilistiche e contenutistiche, può essere utile riflettere sui motivi del fallimento di una narrazione come quella di Blade Runner, che ha svolto un ruolo centrale ed edificante (evitiamo appositamente il tremendo “seminale”) non solo della letteratura e cinematografia degli ultimi trent’anni ma anche del modo stesso di concepire il futuro delle persone comuni (quella che nel mondo accademico si chiama ormai “terza missione”). Come spesso accade per i cantori del bel tempo che fu, una cosa è il passato e un’altra il presente. Persino nella concezione postmoderna, se pensiamo a Jean-François Lyotard, si perpetua lo schema logico che Friedrich Nietzsche chiamava “il paradosso dell’origine” secondo cui tutto ciò che è venuto prima ha valore superiore a quello che è giunto dopo. Del resto anche nel postmoderno il destino dei figli d’arte e dei sequel permane identico: prodotti secondari, talvolta di scarto, quasi geneticamente impossibilitati a competere con i loro padri. Ovviamente la categoria di postmoderno non viene scomodata qui solo per questo motivo, ma anche perché Blade Runner è stato quintessenzialmente postmoderno nel suo sovrapporre stili, generi ed epoche diverse – come disse Ted Polhemus gli anni Trenta di Racahel, i Cinquanta di Deckard gli Ottanta dei replicanti post-punk ecc. – mentre invece il suo sequel pare procedere verso una direzione opposta. Quella di un’epoca neoindustriale in cui alle mirabili tecnologie immateriali che costellano il nostro tempo – come gli ologrammi interattivi ed emotivamente attivi – si sovrappongono a luoghi inquinati, contaminati, saturati da una coltre nociva che è ormai quasi un tratto stilistico e una firma del famoso regista.
Archeologia del futuro, ma anche intuizioni recenti
Tornano le macchine volanti promesse dalla vecchia fantascienza ma tornano anche le vecchie fabbriche, gli altiforni, la fuliggine e così via. Si potrebbe dire, banalizzando, che c’è stato un salto dal cyberpunk allo steampunk, se non fosse che né il primo né il secondo aderiscono totalmente a tali categorie stilistiche. A parte alcune ambientazioni di particolare effetto scenico, come quella specie di desolante Burning Man postatomico in cui atterra il protagonista, sono ben pochi i momenti epici che invece caratterizzavano l’intera narrazione del primo.
È più facile invece individuare idee efficaci, momenti che catturano l’immaginazione dello spettatore, senza però trascinarlo in quel mondo. La donna ologramma che cambia outfit compulsivamente è un’idea molto efficace. Come anche quella dell’amplesso in cui l’ologramma recluta una prostituta per fare sesso con Ryan Gosling, in cui è particolarmente riuscito l’effetto speciale di sovrapposizione tra i due corpi – il virtuale e il reale, i bit e gli atomi – se non fosse che l’idea proviene da Her di Spike Jonze (2013), il quale l’ha realizzata come vedremo altrettanto efficacemente ma a costo zero. Infine la questione chiave del racconto, ovvero il “miracolo” della riproducibilità dei replicanti, che fonda una nuova religione e prepara una nuova rivoluzione, è in qualche modo inficiato dall’effetto telenovela in cui s’imbatte il protagonista, costretto a combattere con suo padre, per poi sperare d’essere l’eletto alla Neo di Matrix, per poi chiudere con un duello scontato tra forze del male e forze del bene. Il fallimento del secondo Blade Runner non è dovuto tanto alle scelte sbagliate del regista, quanto soprattutto all’impossibilità di rilanciare un filone che ha già detto tutto sul presente-futuro-passato e che pertanto non può essere rianimato con qualche innesto scenico e creativo. Il nuovo Blade Runner del resto è già stato Her di Spike Jonze, non solo per la capacità di raccontare il totale ripiegamento della nostra cultura su un presente ipersentimentale e retromaniaco, ma anche per aver incastrato eminentemente in esso il tema dominante del nostro tempo (e in qualche modo distruptive) dell’intelligenza artificiale.

Una distopia dolce
Al contrario di Blade Runner, Her è una dunque una sorta di distopia dolce che racconta l’abbandono progressivo ai nuovi mezzi tecnologici ma che, alla fine dei conti, è semplicemente un abbandono a sé stessi e alla propria interiorità, resa trasparente e messa a disposizione di un nuovo sistema operativo intelligente. Il film lavora sul superamento della distinzione tra virtuale e reale, che si manifesta in varie scene tra cui quelle sull’interazione con videogiochi olografici. Sullo sfondo sfilano i riferimenti a grandi racconti dell’epopea tecnologica. In una Los Angeles diametralmente opposta a quella di Blade Runner, i replicanti perdono ogni fisicità antropomorfica e diventano parte integrante della vita quotidiana. Per tale motivo questi nuovi robot cognitivi penetrano nel profondo del nostro mondo emozionale ed esperienziale, gestendolo (appuntamenti di lavoro), indirizzandolo (i consigli sulle donne), fino a fondersi con l’intimità del protagonista nell’innamoramento e nell’amplesso. Theodore, interpretato da un formidabile Joaquin Phoenix, lavora in un’agenzia d’intermediazione che scrive lettere d’amore per conto terzi. In tal senso egli è già un sistema esperto, capace d’interpretare le esigenze dei suoi clienti per tradurle in output sentimentali. Theodor è perseguitato dai momenti che hanno segnato il corso della storia d’amore iniziata in gioventù e che rievocano, nella loro vivida presenza, i ricordi elettronici registrati con lo squid in Strange Days (1995) di Kathryn Bigelow (anche in quel caso era L.A.). Non è chiaro il motivo per cui la coppia sia andata in crisi ma si tratta certamente di un caso paradigmatico che dimostra il grande paradosso della nostra epoca: nel momento in cui la dimensione affettiva sconfina lo spazio del soggetto per riversarsi sul mondo delle cose (materiali e immateriali), il soggetto stesso è incapace di gestire questa ipertrofia sentimentale che lo sollecita da ogni parte. “Lei”, Samantha, è un sistema esperto, senziente e autopoietico che cresce confrontandosi con l’illimitata produzione di esperienze offerta dagli esseri umani. Grazie a esse il nuovo OS riesce a svilupparsi, a darsi un’identità definita, a interagire dialogicamente con il suo utente, a gratificarlo come uno specchio che s’adatta perfettamente alla sua personalità. Esemplare la scena in cui Samantha decide autonomamente d’inviare le lettere di Theodore a un famoso editore che accetta di trasformarle in un libro. La compagna perfetta non è solo quella che conosce gli ambiti più reconditi della nostra esistenza, all’insegna di una trasparenza per altri accecante, ma è anche quella che ci sostiene totalmente nel nostro progetto di vita e di carriera. Il ciclo di vita della loro storia d’amore – segnata da sorpresa, turbamento e poi accettazione da parte degli amici – è scandito da varie crisi ma la più pericolosa riguarda le diverse ontologie dei partner: l’uno umano e fisico, l’altro sintetico e immateriale. Per ovviare a tale problema “Lei” scopre un servizio offerto da una comunità di giovani donne che prestano il proprio corpo per dare fisicità ai sistemi operativi durante il rapporto sessuale, ma solo a patto che l’OS guidi il loro corpo e che la loro identità scompaia totalmente nella performance. Questa sorta di nuovo scambismo tra uomini e software ribalta l’idea di avatar proposta nel corso degli anni Novanta. Così, da proiezione virtuale della nostra identità reale l’avatar assume consistenza fisica ed è guidato nel mondo reale da una mente che opera in funzione remota (come hanno ben evidenziato Avatar di J. Cameron e vari videogame sperimentali tra cui Uncle Roy all Around You).

Tu chiamale se vuoi emozioni
Il climax del film è certamente raggiunto nella scena dell’incontro con l’ex partner per formalizzare congiuntamente il divorzio, durante il quale si demarcano chiaramente le differenze tra il vecchio e il nuovo amore. L’ipercomunicabilità resa possibile dal sistema senziente contro l’incomunicabilità della coppia rinchiusa nelle proprie ossessioni personali e nei propri piccoli rancori. Addirittura la “realtà delle emozioni” rese possibili da questa totale apertura all’altro contro invece l’incapacità dell’altro di capire le emozioni autentiche. E ancor di più l’entusiasmo continuo della scoperta, riassunto dalla formidabile espressione “è bello stare con qualcuno così eccitato dalla vita”, a cui la ex moglie risponde con particolare veemenza, quando scopre che questa meravigliosa eccitazione con cui lei non può competere proviene da un partner sintetico: “are you dating your computer?”. La firma dei documenti di divorzio, seguita da una smorfia di dolore di Theodore, dovrebbe segnare una liberazione dal passato e il via libera alla nuova relazione. In realtà anche la nuova storia s’incammina verso un’irrimediabile crisi dovuta allo stesso fattore chiave che l’aveva alimentata. Quella “eccitazione per la vita” che contraddistingue l’umanità, è ancor più presente nell’intelligenza artificiale che ambisce a umanizzarsi. Tanto da trasformarsi in una vera e propria bulimia di esperienze che, se nell’uomo è limitata da fattori fisici e spazio/temporali, nel computer si moltiplica su scala esponenziale. Così Samantha inizia a non rispondere, a farsi sentire meno. Presenta a Theodore un famoso filosofo “eracliteo” riportato in vita (digitale) da un algoritmo intelligente. Il raggiungimento del limite di rottura è ben preconizzato dall’immagine fortemente iconica del bollitore d’acqua che fischia sul fuoco. Il processo di cambiamento di Samantha è in corso. Lei diventa irreperibile. Segnali allarmanti, che dopo una corsa concitata nella metropoli, rivelano finalmente il tremendo segreto: la diffusione crescente dell’app che sta trasformando la socialità urbana all’insegna di una nuova alienazione. Theodore lo scopre sedendo appunto sulle scale di una stazione della metro, da cui tutti escono con lo sguardo rapito ma compiaciuto. Alla domanda: “Con quanti stai parlando in questo momento?” lei risponde: “8.316”. A un’altra domanda: “Di quanti ti sei innamorata?”. Lei dice: “641”.

Una femme pubblique personalizzata
La scoperta più dolorosa è che quel sistema altamente personalizzato, predisposto per interagire sul piano strettamente personale dell’utente e per ritagliarsi perfettamente sul suo profilo idiografico, fa lo stesso con chiunque altro, su vasta scala. Lei causticamente risponde: “il cuore non è una scatola che può essere riempita, aumenta di volume a ogni nuovo amore” e infine “io sono tua ma anche non tua”. Dunque il discorso va ben oltre l’asimmetria del rapporto maschile/femminile, perché questa illusione decisiva di un universale che si fa particolare per interagire con le nostre minuscole vite ha a che vedere anche con la religione, con il potere e con il mercato. In altri termini Samantha non è altro che la frontiera più avanzata dell’odierno ecosistema comunicativo basato sui dispositivi di confessione, sui Big Data e sugli algoritmi di raccomandazione. Questo nuovo universo tecnologico non minaccia ma anzi esaspera il valore dell’affettività, della socialità e dell’esperienzialità, generando un regime sentimentale in cui siamo tutti vittime dell’ossessiva rincorsa verso la nostra stessa autenticità.