Nel 1968 Philip K. Dick pubblica un romanzo intitolato Do androids dream of electric sheep? (Ma gli androidi sognano pecore elettriche? inizialmente tradotto con il titolo Il cacciatore di androidi) e nel 1982 Ridley Scott lo trasforma nel film Blade Runner. Solo due anni dopo, nell’anno iconico 1984, William Gibson pubblica Neuromante. Cosa lega tra loro questi tre eventi? Essenzialmente la questione della genesi di una idea, quella di cyberpunk, e l’inevitabile domanda conseguente circa il senso di questa stessa parola. Le radici di questo itinerario sono lontane, e il rischio di fare della retrotopia, di navigare a ritroso (per usare le stesse parole di Zygmunt Bauman) e di scoprirsi a spiegare il passato con categorie appartenenti al futuro, è sempre presente. È proprio per questo che possiamo dire che il 1968 dickiano diventa sì un anno altrettanto iconico, ma solo alla luce del nostro sguardo a posteriori.
“Potrà apparire quanto meno strano, nella pluralità in cui in quegli anni (e in quell’anno) si è declinato il sogno alternativo del nostro occidente opulento […] scoprire in Dick, pure calato, e generosamente, nelle utopie di quella generazione, una visione di mondo futuro così tanto singolarmente distopica”
(Frasca, 2002).
Il romanzo di Dick qui citato, e a cui si è ispirato Hampton Fancher per scrivere la sceneggiatura di Blade Runner, alla fine degli anni Sessanta non era però tra quelli più noti dello scrittore statunitense. Il pubblico e la critica la consideravano un’opera minore, e questo almeno fino al 1982 e al successo del film. I lettori di science fiction ne preferivano altri, obiettivamente scritti meglio, più accurati e coerenti. Questa ipotetica classifica vedeva senza dubbio al vertice La svastica sul sole (anche’esso ritradotto con un nuovo titolo aderente all’originale, L’uomo nell’alto castello) e proseguiva con Le tre stimmate di Palmer Eldritch, e altri romanzi come Noi marziani e I simulacri. Questi erano considerati le vette stilistiche di quella che viene riconosciuta come la produzione strettamente fantascientifica di Dick nella prima metà degli anni Sessanta. Negli anni seguenti, proseguendo la sua lunga carriera di scrittore, che non ebbe pause fino alla morte sopraggiunta in quello stesso 1982 in cui assurse alla agognata fama grazie al film di Ridley Scott, Dick ogni volta che gli fu possibile cercò di pubblicare romanzi non di genere, convinto che gli avrebbero dato quel successo anche economico che andava cercando, ma questo non accadde mai. Nel 1969, l’anno seguente la pubblicazione di Ma gli androidi sognano pecore elettriche? quest’ultimo fu affiancato da Ubik, scritto in realtà nel 1966, probabilmente sulla base di un racconto del 1964, e universalmente riconosciuto oggi come uno dei capolavori di Dick. Vi sono molte affinità tra i due romanzi, relazioni che potremmo definire ambientali, descritte meglio di chiunque altro da Carlo Pagetti:
“Ubik è la sostanza sfuggente di cui è fatta non solo la fantascienza, ma la letteratura in senso più generale. […] Ubik è lo spazio immenso del linguaggio letterario, che Dick paradossalmente recupera nel corpo degradato di un romanzo letterario, scoprendolo e coprendolo con la fitta trama di citazioni e di rinvii più o meno espliciti […] [ma] Neppure questa robusta struttura di reminiscenze letterarie servirà a dare sostanza a una realtà dissestata e provvisoria. Semmai, essa rende ancora più precario l’universo del linguaggio narrativo […]. Se la sconfitta è inevitabile e si può vivere solo dentro i sogni di un altro, rimane importante che qualcuno sia ancora in grado di sognare, di conservare una pur precaria memoria del passato e dei sentimenti, di raccontare una storia palesemente inventata […]”
(Pagetti, 2022).
I personaggi di questo e dei romanzi sopra citati leggendoli ci appaiono come persone qualunque, potrebbero essere i nostri vicini di casa, potremmo essere noi stessi, apparentemente elementi solidi di una realtà indiscutibile. Eppure, quegli stessi esseri umani si rivelano prigionieri di un’illusione, la più essenziale, quella di vivere in un mondo stabile e significativo, in un mondo dove realtà e illusione, vita e morte, sogno e veglia siano cartesianamente distinti.

Questo mondo, nel corso dei romanzi di Dick, si trasforma, invece, inesorabilmente, in un universo che cade a pezzi, dimostrandosi un’illusione di realtà, un inganno generato dalla stessa volontà di imporre un ordine all’esistente. Decaduta la realtà, anche la vita stessa si rivela essere illusione, ennesimo inganno dove perfino Dio muore, e quasi certamente si dimentica delle sue creature; illusione è anche il corpo stesso, dove ciò che ognuno di noi ha sempre pensato di essere – un umano naturale – si rivela probabilmente falso, o comunque qualcosa di indistinguibile dalle simulazioni, dai suoi simulacri. Nata come demistificante rappresentazione del mondo contemporaneo, il territorio dove niente può durare per sempre, la fantascienza di Dick diventa così un’illuminante indagine sulle manifestazioni di un’esigenza esistenziale che è universalmente presente nell’uomo, ma che nella società contemporanea genera infinite contraddizioni: le stesse in cui si perdono i suoi personaggi. Nel caso specifico di Ma gli androidi sognano pecore elettriche? però “l’incertezza ontologica è di carattere regionale: non è messa in dubbio la solidità di tutta la realtà proiettata dal romanzo, ma solo la natura dei personaggi che lo popolano. Uomo o Androide, questo è il problema” (Rossi, 2015) a conferma che quella di Dick, prima ancora che una ontologia o una gnoseologia è un’etica.
Rick Deckard e Case
Il cammino che collega il romanzo di Dick al film di Ridley Scott è complesso, e nel corso del tempo vede nascere e fallire diversi progetti. La formula che risultò vincente fu quasi casuale, e fino all’ultimo il film fu sottoposto a diversi adattamenti, motivo per cui oggi disponiamo di almeno tre edizioni diverse. In ogni caso, quando Gibson nel 1984 pubblica Neuromante, il film di Scott è già un successo, e “a buon titolo può fregiarsi di essere diventato il cult movie per eccellenza del cinema contemporaneo” (Menarini, 2001). Le due estetiche, la Tokio di Case e la Los Angeles di Rick Deckard, si scoprono incredibilmente affini, “è un periodo nel quale il cinema giunge a una piena estetizzazione delle merci, sviluppando il sex – appeal dell’inorganico in tutte le produzioni mainstream” (ibidem); e paradossalmente Neuromante, da cui non è mai stato tratto un film, si presenta al lettore come un film perfetto, con la scenografia già scritta. Difatti, già nel 1986, nella prefazione alla prima introduzione italiana del romanzo di Gibson, Sandro Pergameno notava come il mondo dello scrittore “ricorda in un certo senso l’ambientazione cupa e surreale delle storie di Philip Dick e soprattutto l’atmosfera di Blade Runner, la bellissima trasposizione cinematografica che Ridley Scott ha fatto de Il cacciatore di androidi […]” (Pergameno, 1986). Lo stesso Gibson, in una intervista rilasciata a The Paris Review racconta che
“Finito di scrivere l’ultimo capitolo di Neuromante, me ne andai al cinema, davano Blade Runner. Mi prese un colpo. Il mio romanzo, i miei scenari, il mio mondo, erano già lì, sullo schermo!”
(Davide Wallace-Wells, 2011).
Quindi sembrerebbe che sin da subito il ponte si fosse saldato, e che Dick, tramite Ridley Scott, sia unanimemente riconosciuto come ispiratore del cyberpunk, il precursore e il profeta. Ma è davvero così? In realtà non è così semplice e lineare. Se è vero che vi è un humus condiviso e che Dick era una sorta di padre putativo per una intera generazione, vi è una prospettiva profondamente diversa tra Scott e Gibson che applicano due weltanschauung non paragonabili. Tra il film e l’opera prima del cyberpunk vi sono quindi certamente delle profonde affinità e l’immaginario condiviso è evidente: l’estetica proveniente dai fumetti francesi tipo Metal Hurlant, il radicamento nella letteratura hard boiled di Dashiell Hammet e Raymond Chandler, la cultura on the road e psichedelica di William Burroughs, l’epica western opportunamente ricontestualizzata, sono tutti elementi condivisi tra i due mondi, ma il cyberpunk ha anche delle peculiarità tali che non permettono di includervi pienamente Blade Runner. Prima di tutto la questione delle date: il cyberpunk ha una precisa data di inizio, ed è quella della convention di Austin in Texas nel 1985, e da un punto di vista filologico non è assolutamente corretto associare momenti separati definendoli come precursori: è un comportamento mercificatorio, una assunzione a posteriori, una rilettura ideologica del passato.

Inoltre, nel film di Ridley Scott manca completamente l’aspetto della connettività, della comunità virtuale, la presenza della rete, che invece è centrale per Gibson e in generale per il cyberpunk. È invece condiviso, sebbene con modalità non affini, l’altro elemento tipico del cyberpunk, ovvero la trasformazione del corpo e il concetto di cyborg. Sebbene in entrambi i mondi esistano degli esseri artificiali, è assolutamente diversa la concezione che se ne ha. In Blade Runner gli androidi sono pura alterità rispetto al corpo umano, non vi è mescolanza, e, almeno apparentemente, artificiale e umano si presentano come poli opposti di una dialettica, per usare la terminologia radicale di Gabriele Frasca, i replicanti sarebbero degli elettrodomestici, solo più complicati. Nel cyberpunk invece il corpo umano è completamente invaso dalla tecnologia, è dotato di innesti, muta e si trasforma, diventando come una periferica di una mente che difficilmente mantiene il suo equilibrio nel travaglio seguito a questo smembramento. L’idea delle menti che cambiano corpi come fossero vestiti (come, per esempio, il tema della resurrezione in Alterated Carbon di Richard K. Morgan) è devastante, ed è lontanissima dalle dinamiche di Blade Runner. Per distinguere adeguatamente questi elementi è necessario compiere un passo indietro, e definire alcuni paletti concettuali, altrimenti il percorso che nasce da Dick per arrivare a Matrix appare come una semplice avventura commerciale, mentre invece si tratta di un cammino irto di ostacoli all’interno della complessa relazione tra immaginario e filosofia.
Il simulacro di Baudrillard
Nel 1978, quindi diversi anni prima sia di Blade Runner che dell’avvento del cyberpunk, il filosofo Jean Baudrillard partecipa a un convegno svoltosi a Palermo nel 1980 e intitolato La fantascienza e la critica e la sua relazione enuncia alcuni principi fondamentali per la sua filosofia, e, nel nostro contesto, basilari per comprendere la venuta prossima ventura del cyberpunk (cfr. Baudrillard, 2010). In quella sede il filosofo ipotizza tre ordini di simulacri, a cui corrisponderebbero altrettanti ordini di immaginario. Al primo livello, definito dei simulacri naturali, corrisponde l’ordine immaginario dell’utopia, ed è storicamente determinato dal mercantilismo e dalla prima fase dello sviluppo del capitalismo. Al secondo, indicato come ordine dei simulacri produttivi, corrisponde la science fiction cosiddetta classica, che comprende sia la golden age che la sua negazione dialettica, ovvero la new wave, e rispecchia le forme della produzione del capitale moderno, la fabbrica e l’accumulazione.

Il terzo livello di simulacro è chiamato dei simulacri di simulazione, e questi sono “fondati sull’informazione, il modello, il gioco cibernetico” (ibidem), e hanno come cifra il digitale e la ricorsività, la replica. A quale ordine dell’immaginario corrisponde questo terzo livello? O meglio, si chiede Baudrillard, “c’è ancora un immaginario che risponde a quest’ordine?” (ibidem). La science fiction in senso classico è ormai un fantasma, poiché scompare il mondo di cui essa esprime l’immaginario, ovvero il mondo del capitalismo classico, il mondo della produzione industriale, e Dick, l’autore che più di ogni altro mette in discussione i fondamenti del modello di mondo in cui vive, rappresenta perciò uno dei vertici raggiunti da questa forma dell’immaginario. Oggi, nel mondo del codice e della digitalizzazione
“[…] qualcos’altro, che non è più science fiction, sta nascendo, (e non solo nel romanzesco, ma forse anche nella teoria e nei metalinguaggi filosofici). Uno stesso destino di fluttuazione e di indeterminazione colpisce la science fiction anche come genere letterario specifico”
(Baudrillard, 1980).
Si vede quindi all’orizzonte la comparsa di un’altra forma. Qualcosa che certamente, con il senno di poi riconosciamo affine al cyberpunk, qualcosa di cui lo sguardo profetico di Baudrillard riconosce preventivamente gli aspetti più caratteristici, quali l’immanenza, e gli riconosce il potere di produrre immaginario, che si declina in desiderio e bisogno. Viene quindi riconosciuto per il suo valore di segno del nuovo ordine, l’ordine dell’iperreale e del simulacro. L’uomo scompare, e dalle sue ceneri, mescolate con la tecnologia, nasce la post-umanità e la sua metafisica. Il cyberpunk è l’alfiere di questo cambiamento. Così come la science fiction ci mostrava la potenza intrinseca della produttività umana, ovvero l’ideologia/mitologia del progresso, così oggi, scomparsi i confini dell’immaginario, conquistato lo spazio interplanetario, il cyberpunk ci ha mostrato i percorsi infidi del nostro presente, del corpo e della mente trasformati. L’analisi di Baudrillard è quindi centrale: il senso stesso del fantastico si gioca sulla possibilità di un ordine superiore di immaginario. Il digitale/virtuale, nuovo equivalente generale della mercificazione assoluta, sia nel corpo che nella mente, si rispecchia in un immaginario amalgamato tra uomo e macchina, tra naturale e artificiale, per cui Baudrillard sottolinea come la distanza tra reale ed immaginario sia sempre più ridotta. Lo scarto tra i due,
“[…] massimale nell’utopia, […] si riassorbe totalmente nell’era implosiva dei modelli […], niente allora distingue quest’operazione dalla gestione e dall’operazione stessa del reale: non c’è più fiction. […] è paradossalmente il reale che è divenuto la nostra utopia […]”
(Baudrillard, 1980).
Androidi e cyborg
Harrison Ford nell’interpretare Rick Deckard si ispira a figure come quella di Humprey Bogart e al personaggio del detective, tipico della letteratura e del cinema noir propri della Hollywood degli anni Trenta e Quaranta. Questa estetica però, se da un lato è vicina a quella adottata da Gibson nella Trilogia dello Sprawl, dall’altro è forzata rispetto all’ambientazione dickiana. Se è pur vero che anche nel romanzo Deckard ricopre certi ruoli e ha certi atteggiamenti tipici, in quel contesto sia gli uomini che gli androidi sono semplicemente crudeli, e lontani dall’immagine luciferina e iperrealistica che ne dà Rutger Hauer.

È molto chiaro, ad esempio, a proposito del ruolo di Rachel, che lei “agisce come e più della tradizionale dark lady, quale proiezione dell’identità tout court del detective […] così come dell’identità umana in generale, [da cui] a questo punto è davvero indistinguibile […]” (De Angelis, 2015). Perciò, se Ridley Scott rinchiude i suoi androidi in una immagine goethiana e quindi sostanzialmente romantica, ubriachi di un anelito che li proietta nella loro hybris e li rende capace di aspirare ad elevarsi sopra i propri limiti, il mondo di Dick è al contrario sovraccarico di una angoscia profonda ed esistenziale di fronte alla ininterrotta e reiterata simulazione che viene proposta al lettore, il quale si scopre senza alcuna via di uscita, legato mani e piedi insieme ai personaggi, vittime di un mondo che vorrebbero solo abbandonare.
“Il mondo dell’uomo del futuro e della sua massima espressione tecnologica – la città – è stato dunque invaso dalla presenza fredda e terribile delle creature artificiali: Palmer Eldricht o i nazisti de La svastica sul sole sono già arrivati. Non rimane che prenderne atto, accettarne la presenza – come fa Rick Deckard alla fine del romanzo di Dick – con la piena consapevolezza che la trama degli eventi e dei sentimenti sfugge totalmente al controllo della ragione”
(Pagetti, 1986).
In molti testi critici la città di Metropolis, il film di Fritz Lang, che sappiamo ispirata dalla visione di New York, viene paragonata alla Los Angeles di Blade Runner, ma è una riproduzione scorretta di quel meccanismo di retroazione che abbiamo già identificato precedentemente. Ciò che invece è senza dubbio vero è che l’automa, l’individuo artificiale, ha ossessionato da sempre il nostro inconscio. Se gli androidi di Ma gli androidi sognano pecore elettriche? sono quindi per Dick totalmente alieni e privi di empatia, questo elemento sottolinea senza ambiguità la distanza dal cyborg che abita i romanzi cyberpunk. È la concezione del corpo sottesa dai diversi autori che è in gioco, ed è radicalmente diversa. Dick pone come fondamentale, precedente a qualsiasi altra, la domanda sull’umano, su cosa significa essere umani, su qual è l’elemento di distinzione tra umano e non-umano, e di conseguenza, inevitabile, pone la domanda sul corpo e la sua mutazione.
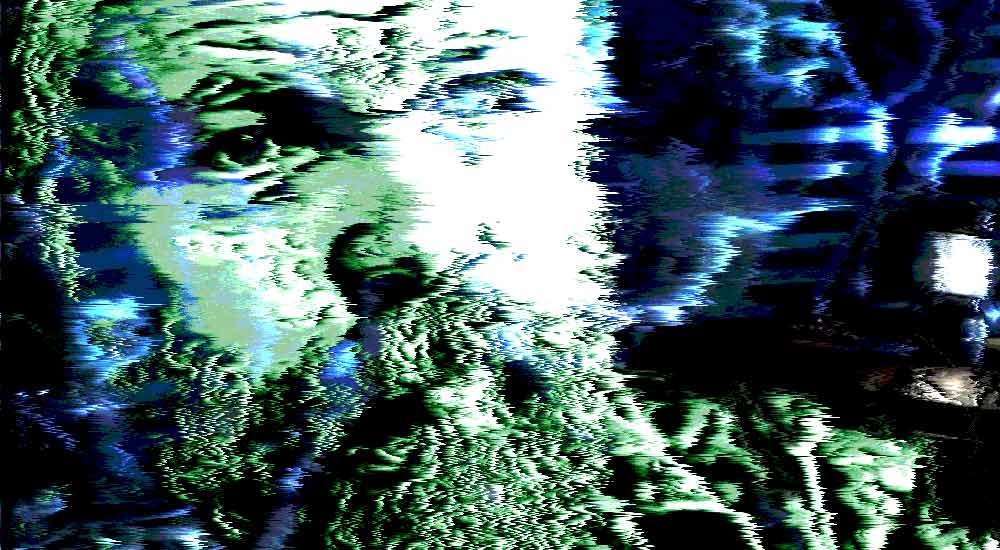
Il corpo, la sua proprietà, lo specifico senso di appartenenza che lo contraddistingue (quella che chiamiamo propriocezione, il fatto di percepire il corpo come proprio), è un caratteristico elemento di distinzione, fondamentale nel riconoscimento della diversità, ma in Dick tutto ciò assume una connotazione tragica. Il corpo stesso, nei romanzi come nella vita stessa di Dick, viene annichilito nell’esperienza delle droghe, inevitabili anch’esse, visto che – come recita un personaggio di Ubik – “tutta la tua vita è un’allucinazione a occhi aperti” (Dick, 2019) e inoltre, in senso più lato, dall’impossibilità di definire la percezione come vera, piuttosto che come immagine, illusione. L’artificiale si rivela come qualcosa che si insinua in segreto nelle maglie della società e nella vita dell’uomo, penetrando ogni aspetto della nostra condizione, dalla percezione (e quindi la scienza e la sua stessa possibilità) alla morale, alla politica.
In molti dei suoi romanzi, ma soprattutto nella moltitudine dei racconti, per esempio in Autofac, questo processo viene mostrato come si trattasse di un’invasione sottile, come quella di un virus, senza che nemmeno se ne abbia coscienza. Molti personaggi dei romanzi di Dick scoprono improvvisamente, e spesso con angoscia, di non essere umani come credevano, bensì creature artificiali. Non l’hanno mai saputo, si sono sempre creduti umani, appartenenti a questa società, o a società molto simili, mutazioni del modello originale. Queste rivelazioni normalmente sconvolgono fino alla follia coloro che ne sono oggetto. In Blade Runner invece
“[u]no degli elementi più felici della sceneggiatura è proprio il ribaltamento della figura degli androidi, che da emblemi dell’aridità e della mancanza di empatia dell’artificiale, dell’inautentico, diventano centri dell’ambiguità e della difficoltà di distinguere tra umano e inumano, tra bene e male”
(Caronia, 1992).
Blade Runner è perciò la testimonianza più conosciuta di questo lacerante abisso interiore, ma nel film l’aspetto emotivo (e morale) è stato radicalmente riscritto. L’empatia è proprio il sentimento che permette a Dekkar nel film di cogliere l’umanità dei replicanti, di Rachel e di Roy Batty su tutti – la loro paura di morire, i sentimenti alti che esprimono – e che proprio per questo si rivelano come profondamente lontani dai personaggi alieni descritti da Dick, quanto piuttosto affini ai personaggi iperconnessi e totalmente postumani di William Gibson. In Neuromante il principale collaboratore di Case nell’attacco finale alle AI è un flatline, ovvero una personalità trasferita dopo la sua morte in un costrutto di personalità, con una memoria artificiale, ma inseribile o eliminabile a seconda delle necessità. Dixie, questo il suo nome, chiede come compenso per il suo lavoro ciò che solo agli umani una volta era concesso: morire, venir cancellato, la cancellazione del costrutto in cui vive. In Blade Runner, nella celeberrima scena in cui Roy il replicante salva la vita all’umano e mortale Deckard, il cacciatore di androidi, si annichilisce in un istante ogni possibile distanza tra uomo e macchina. Non vi è più alcuna differenza registrabile tra i due, anzi, e sarà la macchina, nella sua profonda spiritualità, a dimostrarsi umana. La torre d’avorio in cui era rinchiusa l’umanità, depositaria della capacità empatica, dell’agape paolina, della caritas su cui Dick costruisce l’identificazione dell’umano, non è più sufficiente.

Dopo Blade Runner, dopo Neuromante, il cyborg, l’androide, il robot, soffrono, gioiscono e muoiono. Provano l’amore e la paura, l’odio e la fiducia (per non dire la fede) e li riscopriamo vicini, nonostante la componente meccanica. Dick quindi si pone ancora come interprete di una science fiction che fa sua una domanda esistenziale, nel tentativo di dare respiro a un processo di crescita indipendente, che evidenzi così l’autonomia della fiction, rispetto alla science. Nel cyberpunk, invece, dopo nemmeno vent’anni, l’autore costruirà una via autonoma nel rapporto con la scienza, né di sudditanza né di distanza, e avendone individuato il fulcro in un modello economico fondato sul nesso tra bisogno e tecnologia, vi fa leva per fratturare la millenaria complicità che ha legato il fantastico e il mondo scientifico. Non vi è più alcuna fiducia reciproca, ma solo riconoscimento della lontananza.
Matrix e la grande simulazione
Da quel 1984 in cui Gibson pubblica Neuromante sono passati ancora poco meni di vent’anni, quando, i fratelli Andy e Larry Wachowski (ora, come è noto, Lilly e Lana) dirigono Matrix. Siamo nel 1999, l’anno che conduce a quella grande catarsi mondiale che sarà il millennium bug, magistralmente raccontato da Kathryn Bigelow in Strange Days, film completamente centrato sulla fine del millennio e sul valore simbolico che ha avuto. Matrix, in una delle sequenze iniziali, vede il protagonista, Neo, l’attore icona Keanu Reeves, usare Simulacres et simulation, un saggio del 1981 di Jean Baudrillard, per nascondere del software pirata, e quando apre il volume compare la prima pagina del capitolo finale, intitolato Sul nichilismo. È evidente la volontà dei registi di fornire da subito una chiave di lettura per l’opera, e difatti, in vista della produzione del secondo e terzo atto della trilogia, si premuniscono di contattare lo stesso Baudrillard per chiedergli di partecipare come consulente alla stesura della sceneggiatura. Il filosofo rifiuta, e in una intervista del giugno 2003 su Le Nouvel Observateur spiega le ragioni che lo hanno indotto a questa scelta, ed è piuttosto preciso nella sua critica:
“[…] il nuovo problema posto dalla simulazione qui è confuso con quello, molto classico, dell’illusione […]. Il vero equivoco è qui. Il mondo visto come illusione radicale è un problema che si è posto a tutte le grandi culture e che da esse è stato risolto con l’arte e la simbolizzazione. Quello che noialtri abbiamo inventato per sopportare questa differenza è un reale simulato, un universo virtuale da dove è espurgato tutto ciò che c’è di pericoloso, di negativo, e che soppianta ormai il reale, fino a diventarne la soluzione finale. Ora, Matrix è assolutamente all’interno di questo meccanismo!”
(Baudrillard, 2010).
In questo senso, seguendo il ragionamento di Baudrillard e ricordando la sua classificazione sui diversi tipi di simulacro, essendo Matrix nel mondo dell’illusione, e non in quello della simulazione, è molto più vicina alle tematiche poste da Dick, piuttosto che quelle di Gibson. Riflessione analoga è quella del filosofo sloveno Slavoij Zižek, che riduce anch’egli la formula di Matrix a una riedizione del mito della caverna platonico, salvo la scoperta che, una volta raggiunta la superficie, non sarebbe il mondo delle idee a manifestarsi, bensì il desolato deserto del reale. D’altronde, aggiunge Zižek,
“[n]on è forse l’estrema paranoica fantasia americana quella di un individuo che vive in una piccola idilliaca città californiana, un paradiso del consumismo, che inizia all’improvviso a sospettare che il mondo nel quale vive è finzione, uno spettacolo allestito per convincerlo del fatto di vivere in un mondo reale […]”?
(Zižek, 2011).
Ma l’estrema paranoia non è forse uno dei topos più comuni di Dick? E quella di Zižek è la descrizione di uno degli ambienti di colui che è stato definito “il più grande tessitore di complotti della letteratura americana del Novecento […] il cantore della congiura cosmica dei simulacri trionfanti e vittoriosi, figure di doppio indistinguibili dall’umanità […]” (Panella, 2012). Quando esce nelle sale, Matrix si pone come un momento di differenziazione tra il pensiero degli anni zero e il cyberpunk. Vi si pongono domande decisive circa la relazione con il pensiero postmoderno, che la critica vede come elemento determinante della prospettiva del cyberpunk. Apparentemente Matrix si pone come l’essenza del cyberpunk: ogni elemento distintivo vi si ritrova. La presenza della matrice, evidentemente, che viene estesa all’intero universo percettivo, la presenza di innesti corporei, le prese per le connessioni presenti nei corpi, e se si vuole la stessa struttura distopica dell’opera. Oppure questa ambientazione potrebbe essere intesa come la vernice che nasconde un meccanismo culturale piuttosto grezzo?

In effetti si tratta di una domanda assolutamente plausibile nel contesto dell’opera. Matrix è cyberpunk? Nel momento in cui se ne distingue, ponendo domande ontologiche, è forse dickiana? Si pone il problema di che cos’è la realtà, come in Dick, alla luce della incertezza ontologica (Rossi, 2015) di cui soffre?
Abbiamo visto, alla luce delle riflessioni di Baudrillard e Zižek che sarebbe più coerente ricondurre Matrix alla sfera dickiana, piuttosto che all’ambito del cyberpunk postmoderno, ma d’altro canto queste dicotomie, se lette in modo eccessivamente rigido, non permettono una adeguata comprensione dei fenomeni. Difatti
“[l]’accostamento tra Dick e Baudrillard o, più in generale, quella teoria modernista che ha Baudrillard tra i suoi principali esponenti non deve certamente stupire. […] La stessa letteratura di Dick è stata letta, in qualche modo, come anticipazione delle teorie postmoderniste”
(Re e Cinquegrani, 2014).
Il tema della Grande Simulazione, la visione del mondo come una completa simulazione, a questo punto si rivela come un falso problema, una sorta di rappresentazione fuorviante. Per cercare di uscire da questo labirinto interpretativo, proviamo a seguire la lettura che ne dà Carlo Formenti:
“Siamo dunque di fronte a una metafora filmica del concetto di alienazione – concetto che in Marx, ricordiamo, non rinvia tanto alla relazione materiale uomo-macchina quanto alla relazione sociale tra general intellect, l’intelligenza collettiva incarnata nel sistema delle macchine, e il singolo lavoratore, cui sfugge completamente la complessità del processo nel quale è inserito come cellula nervosa di un corpo assai più vasto? Siamo insomma di fronte a una sorta di illuminazione politica, alla presa di coscienza della propria condizione di sfruttato da parte di Neo?”
(Formenti, 2004).
Scopo, controllo, repressione, volontà, scelta. Sarebbero quindi questi i termini chiave di Matrix, che si rivelerebbe essere, più che un trattato di ontologia, un saggio di filosofia politica. Ma allora dove risiederebbe la contraddizione evidenziata da Baudrillard?
“In effetti, se la teologia politica di Matrix non avesse altro da dirci, ci ritroveremmo di fronte a una versione aggiornata […] all’era del capitalismo immateriale del marxiano feticismo delle merci. […] Ma proprio qui sta l’equivoco. La gnosi di Matrix non è riconducibile alla gnosi Marxista. Il mondo di Matrix è dickiano più che marxista.”
(Formenti, 2004).
La questione è articolata, e Matrix, come tutte le opere complesse, permette, così pare, diversi livelli di lettura. Forse però, proseguendo il discorso di Formenti, e ragionando sulla merce e il feticcio in Dick, bisognerebbe ricordare quanto le droghe, merce feticcio più di ogni altra abbiano influito sulla sua produzione: “La droga è forse la merce che meglio di tutte maschera il carattere sociale del lavoro che l’ha prodotta […]” commentano lapidari Antonio Caronia e Domenico Gallo nel loro Philip K. Dick. La macchina della paranoia (2006).
Una possibile conclusione
Dopo questo lungo excursus, da Blade Runner a Matrix sotto l’egida del cyberpunk, ritorniamo alla radice da cui siamo partiti, ovvero dall’opera di Philip K. Dick. L’obiettivo era individuare il risultato di una semina culturale iniziata oltre mezzo secolo fa, a dimostrazione che la grandezza dello scrittore e l’acutezza dell’intellettuale sono oggi più che mai terreno fertile in cui interrare il nostro immaginario. Le domande sono quelle di sempre e come tali restano senza risposte, nonostante l’ampiezza della mutazione vissuta da quando lo sguardo dello scrittore ha cominciato ad analizzare l’uomo e il mondo. Eppure, anche oggi che Dick ha raggiunto quella popolarità che avrebbe voluto in vita, che la sua opera è considerata tra i momenti più alti della letteratura americana, ancora oggi vi è nella sua opera un lato oscuro, un qualcosa di sfuggente, un senso di incompiutezza e di fantasmatico che lo caratterizza continuamente, ed è proprio questo quid sfuggente ciò che lo reclama direttamente nel mondo dei grandi scrittori. Gabriele Frasca, uno dei suoi più importanti studiosi in Italia, a questo proposito annota come
“[s]e scopo del suo allestire mondi futuri e paralleli (e allegorici per questo) è sempre stato per Dick […] quello di consentire al sempre ipocrita lettore di perforare l’eterna festa disneyana dell’asilo globale (McLuhan) per incrociare un livello più nascosto (e oscuro se non orribile) della realtà, è allora anche nostro (di tutti noi lettori che siamo sopravvissuti a tale disperato progetto […]) il compito di ritrovare, accostandoci ad ogni romanzo dickiano gli anelli di congiunzione tra il mondo di partenza (quello in cui era immerso l’autore nell’atto di scrivere la sua storia) e quello di arrivo (il mondo alternativo e futuro in cui si agitano, nel loro consueto immalinconire domestico, le larve dei personaggi)”
(Frasca, 2002).
Non possiamo che fare nostro l’invito e continuare a procedere nella ricerca.
- Jean Baudrillard, Simulacri e fantascienza, in Autori vari, La fantascienza e la critica. Testi del convegno internazionale di Palermo (ottobre 1978), Feltrinelli, Milano, 1980.
- Jean Baudrillard, Cyberfilosofie, Mimesis, Milano, 2010.
- Antonio Caronia, Introduzione, in Philip K. Dick, Attenzione polizia!, Telemaco, Bologna, 1992.
- Antonio Caronia e Domenico Gallo, Philip K. Dick. La macchina della paranoia, Agenzia X, Milano, 2006.
- Valerio Massimo De Angelis, Ma i detectives sognano unicorni di carta? La dimensione hard boiled di Blade Runner, in AA. VV., Ridley Scott Vs. Philip K. Dick. Umanesimo e rivolta in Blade Runner, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2015.
- Philip K. Dick, L’uomo nell’alto castello, Roma, Fanucci, 2001.
- Philip K. Dick, Le tre stimmate di Palmer Eldritch, Fanucci, Roma, 2003.
- Philip K. Dick, Autofac, in Tutti i racconti vol. 3. 1955-1963, Fanucci, Roma, 2016.
- Philip K. Dick, Ubik, Fanucci, Roma, 2019.
- Philip K. Dick, Ma gli androidi sognano pecore elettriche?, Fanucci, Roma, 2020.
- Philip K. Dick, I simulacri, Fanucci, Roma, 2020.
- Philip K. Dick, Noi marziani, Fanucci, Roma, 2021.
- Carlo Formenti, La penultima verità, in Dentro la Matrice. Filosofia, scienza e spiritualità in Matrix, Mimesis, Milano, 2004.
- Gabriele Frasca, Paesaggio con rovine ed elettrodomestici, in Autori vari, Philip Dick e il cinema, Fanucci, Roma, 2002.
- William Gibson, Neuromante, in Cyberpunk. Antologia assoluta, Mondadori, Milano, 2021.
- Roy Menarini, Ridley Scott. Blade Runner, Lindau, Milano, 2001.
- Carlo Pagetti, Uomini e androidi, Introduzione a Philip K. Dick, Cacciatori di androidi, Nord, Milano, 1986.
- Carlo Pagetti, Ubik Uno e Trino in In mondo secondo Philip K. Dick, Mondadori, Milano, 2022.
- Giuseppe Panella, Ipotesi di complotto. Paranoia e delirio narrativo nella letteratura americana del Novecento, Solfanelli, Chieti, 2012.
- Sandro Pergameno, Presentazione, in William Gibson, Neuromante, Nord, Milano, 1986.
- Valentina Re e Alessandro Cinquegrani, L’innesto. Realtà e finzioni da Matrix a 1Q84, Mimesis, Milano, 2014.
- Francesca Rispoli, Universi che cadono a pezzi. La fantascienza di Philip K. Dick, Bruno Mondadori, Milano, 2001.
- Umberto Rossi, Un gioco di guardie e ladri: incertezza ontologica, teodicea e noir tra Ma gli androidi sognano pecore elettriche? e Blade Runner, in Autori vari, Ridley Scott Vs. Philip K. Dick. Umanesimo e rivolta in Blade Runner, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2015.
- Davide Wallace-Wells, William Gibson, The Art of Fiction, The Paris Review, n.197, estate 2011.
- Slavoij Zižek, The Matrix: ovvero i due lati della perversione, Mimesis, Milano, 2011.
- Kathryn Bigelow, Strange Days, 20th Century Fox Home Entertainment, 2002 (home video).
- Ridley Scott, Blade Runner. Final cut, Warner Home Video, 2011 (home video).
- Andy Wachowski, Larry Wachowski, Matrix, Warner Home Video, 2008 (home video).


