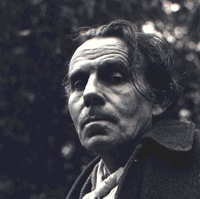Céline, 1915
Céline, 1915
QUEL PUNKETTONE
DI LOUIS-FERDINAND
di Francesco Zago
Pensate a un grosso pezzo di carta vetrata, di quella
abrasiva, bella spessa, a grana grossa. Ecco, Céline
è il virtuoso della carta vetrata. Per questo
Céline è punk. Diciamolo pure, a costo di cadere
in un flagrante anacronismo, o in un madornale errore critico.
Perché ovviamente il dottor Destouches non poteva sapere
nulla del punk così come lo conosciamo noi oggi,
perché non erano certo gli anni Settanta e Ottanta. Ma
Céline è un autentico punk
nell’atteggiamento, nella postura – persino fisica,
tanto che pare di vederlo uscire letteralmente dalle pagine, di
sentirlo nelle orecchie – del perenne incazzato. Astioso,
gesticolante, eccessivo, persecutorio.
Certo qualcosa divide
nella sostanza Céline da, tanto per fare un esempio, Sid
Vicious: laddove il punk ha celebrato l’incapacità
di suonare come espediente espressivo, l’autore del Viaggio
al termine della notte è un vero funambolo della
penna (o della carta vetrata, se preferite). Ma quasi tutte le sue
opere, più o meno note o celebrate, hanno così
tanti tratti in comune con certa cultura giovanile più
vicina alla nostra epoca che – con buona pace della critica
letteraria e musicologica – è quantomeno
affascinante immaginare il viso di Céline distorto dallo
stesso ghigno arrogante di Sid, o di vedere il dottor Destouches tra le
file di un Punk Front ante litteram, alfiere del
nichilismo più sconfortante, antisemita e collaborazionista
(non dimentichiamo lo sfoggio di simboli neonazisti da parte proprio
del leader dei Sex Pistols, ma non solo. La provocazione più
autentica può servirsi anche dell’offesa
più orrenda, inqualificabile, insostenibile. A ogni modo,
non ci si dilungherà qui sull’annosa questione
dell’antisemitismo di Céline: basti suggerire
l’accostamento).
Se conoscete già lo
scrittore, sapete di cosa stiamo parlando. Se non avete mai letto nulla
di Céline, allora vi suggerisco di partire da un libretto
modesto nelle proporzioni quanto sferzante nelle intenzioni. Ben
diverso nella mole dai grandi capolavori di Céline, i Colloqui
con il professor Y non sono da meno quanto a livore
tragicomico del Viaggio o di Morte a
credito. Anzi. In poche pagine l’autore riesce a
prendersela con tutto e tutti: inveisce, par di vederlo abbaiare,
sputazzare, gesticolare, farsi paonazzo. Le sue ossessive
recriminazioni non risparmiano nessuno, attraverso la figura ridicola
del suo intervistatore, vero e proprio capro espiatorio, il povero
Colonnello Réséda, alias professor
Y (via via apostrofato dal suo fantasioso interlocutore come, fra le
altre cose: “cagaculo”,
“incapace”, “troia”,
“porcone”, di nuovo “troia”,
“pisciarolo”, “fottuto intervistatore dei
miei coglioni”, “sozzo finto essere”, e
via dicendo). Le pessime condizioni della prostata del Colonnello lo
mettono in una condizione perlomeno imbarazzante; in sostanza, non fa
che pisciarsi addosso, con grave disappunto (come se non gli bastasse!)
di Céline. L’escalation conclusiva
dell’intervista/invettiva va di pari passo con
l’allargarsi della pozza di urina prodotta dal Colonnello, in
un crescendo ritmico degno di Stanlio e Ollio. Lo scrittore ce
l’ha con, in ordine sparso: l’editoria, i giovani,
le “idee” (“io non ho idee! neanche
mezza! per me non c’è niente di più
volgare, di più ordinario, di più disgustoso
delle idee”) e i “messaggi”, le emozioni
e la letteratura che vorrebbe suscitarle, il pubblico
(“bestia, minorato psichico e via dicendo”, i
“lettori francesi sono snob, fessi e servili”) e
gli scrittori (quelli francesi sono “tutti morti”,
quelli stranieri “non esistono”) che cercano di
assecondarne i gusti, i “cantanti
d’amore” (“cancheri marci del
lirismo”). Di passaggio, non dimentica i pittori, i turisti
(“non c’è caio più coglione
d’un turista”), il cinema, perfino la chirurgia
estetica (uno dei fulminanti casi di preveggenza di Céline:
“tutto l’obitorio di natiche impalate, coscie
impalate, zinne operate, nasi accorciati, e chili di
ciglia!”).
Lo scrittore sembra perfino crogiolarsi
nella propria maledizione, negli insulti e nelle accuse, nella galera a
cui è stato costretto per le sue
“invenzioni”, per la sporcizia e l’odio
che trasudano dalle sue pagine. Céline è
immodesto, egocentrico, aristocratico, tracima disprezzo (il suo
interlocutore lo definisce “un’immondizia vivente
per principio”), e se ne vanta: lui sì che ha il
coraggio di mostrare l’”io perpetuo”,
“l’indecenza! l’esibizionismo!”
È lo stile celiniano del
“metrò emotivo”, il “nero
metrò”, “quest’abisso sporco,
puzzolente e pratico”, un mostro metallico e sotterraneo che
travolge ogni cosa, che corre all’impazzata su binari
distorti, “profilati su misura”, i lettori
“stipati, chiusi a chiave, doppio giro!”, costretti
a subire violenza dallo scrittore, “stipati
‘ammucchiati emotivi’!” Céline
professa l’”ultraprecisione emotiva”, la
cacofonia del linguaggio parlato ritrascritta sulla pagina, gelosa
delle sue irregolarità, della sua patina lurida e
fatiscente. Ma i vagoni emotivi di Céline sono fatti per
deragliare e ribaltarsi: “Basta un niente… e salta
tutto! […] Binari costruiti apposta, che sembrano dritti e
non lo sono”. E poi, ecco il nocciolo della questione, il
nesso tra stile ed emozione, tra strumenti e artigianato della
scrittura e quel grumo viscerale e indefinibile di cui tutti,
scrittori, lettori e critici, si beano fino alla noia: “i
binari sono dritti solo nell’emozione!” I
binari dritti sono il classicismo, i cliché, i modelli
preconfezionati dell’editoria (e dell’arte in
genere), e soprattutto l’espediente cui ogni
“artista” ricorre sapientemente: esprimere
l’emozione e suscitare l’emozione, degradata a
passatempo, fremito domenicale e borghese, adatto a tutti, per ogni
palato (oggi la televisione e gran parte del cinema commerciale
sembrano incarnare questo demone dell’emozione a tutti i
costi, dell’espressività vuota e codificata).
Scomodo, eretico, anarchico, blasfemo, sovvertitore: perché
non vedere in questo irrimediabile rifiuto di ogni forma di
romanticismo e sentimentalismo (in tutti i sensi possibili, e senza
un’alternativa che non sia la violenza verbale) una conferma
della vena punk, cattiva, eretica di Céline? (Buttiamola
lì: vi dicono niente nomi come John King, autore fra
l’altro di Human Punk, e Irvine Welsh?
Con le debite differenze, non vi sembrano parecchio vicini a
Céline, prima di tutto nel frantumare la lingua scritta e
accademica, nell’eliminarne le cadenze, i ritmi, i sillogismi
della trama, sostituendoli con il parossismo e
l’allucinazione, lasciando esplodere la vita e il desiderio
cocente che la anima?)
Il modo in cui Gianni Celati parla dei Colloqui
(nella “Nota” conclusiva
all’edizione Einaudi) potrebbe applicarsi tranquillamente al
più blasfemo e irriverente dei punkettoni: “In
questo senso, per questa sua interna vocazione al travestimento
completo, al carnevale catastrofico, l’opera di
Céline si colloca naturalmente in uno spazio underground,
ed è tanto più estrema (il che significa meno
socialmente integrabile) di tante forme di letteratura
‘bassa’ giocate su un’astuzia
intellettualistica” (in Céline, 2009). Ci sembra
che qui Celati abbia visto davvero giusto; perfino l’immagine
del “metrò emotivo”, scomodo,
sgangherato, notturno, su cui insiste a lungo Céline
richiama le atmosfere urbane, degradate e sotterranee, tanto care al
punk e ai nipotini di Sex Pistols e Clash. (Si rimanda a quella
“Nota” per le conseguenze critiche di questa
impostazione, sull’idea di “maschera”
céliniana, sulla non-identità tra la parola
scritta e le opinioni concrete, quotidiane del
“Céline in carne e ossa”.)
Non si è tirato in ballo il punk tanto per fare, ma
anche per sfatare un mito, o semplicemente un luogo comune. Alcuni
hanno segnalato, e forse in parte giustamente, il parallelismo tra il
linguaggio di Céline e il jazz. Può darsi che sia
così. Ma non ci sembra che tale accostamento sia dei
più riusciti. In primo luogo perché il jazz
– almeno un certo jazz, quello degli anni Trenta e Quaranta
– non aiuta a chiarire meglio una lingua, quella di
Céline, così unica, irriducibile a modelli
letterari e, a maggior ragione, extraletterari. (A mo’ di
corollario, ci sembra importante aggiungere, la lingua di
Céline non aiuta certo a capire meglio il jazz.) In secondo
luogo, credo che il paragone calzerebbe se si riuscisse a vedere in una
pagina dello scrittore una parafrasi, una riscrittura, una
riproduzione, in una qualunque misura consapevole ed esplicita, del
linguaggio jazzistico. (Fra parentesi, continuiamo a parlare di
“jazz”: come si può paragonare lo stile
di un autore a un’entità tanto vaga,
un’etichetta del tutto astratta? Né basta, come
qualcuno sarà stato sicuramente tentato di fare, appigliarsi
al più ritrito dei luoghi comuni popolar-musicologici,
cioè che il jazz è musica
“sincopata”… Un’espressione
incomprensibile: a parte forse il canto gregoriano, dalla fine del
Medioevo a oggi non c’è musicista che non abbia
rinunciato alla sincope nella propria scrittura. Dove
c’è tactus, dove
c’è pulsazione, c’è anche la
sincope. Pare sia un espediente inevitabile. Se poi si tenta la carta
dell’improvvisazione, in quanto tratto distintivo, questo
sì, della pratica jazzistica in genere, siamo completamente
fuori strada: non c’è scrittura più
calcolata e dettagliata di quella di Céline.)
Detto
questo, mettiamo da parte per un momento il jazz, e rileggiamo
Céline come un esteta ante litteram del
punk, del disordine espressivo e debordante (si può essere
calcolati ed eccessivi? Céline fu un maestro in tal senso, e
quindi maestro della contraddizione). E non perché la sua
scrittura sia appena appena assimilabile al punk in quanto genere
musicale (di per sé fra i più poveri e privi di
sviluppo, va detto, almeno in termini strettamente tecnici). Ma per le
migliaia di voci distorte, urlanti, biascicanti, con cui
Céline investe il lettore: l’assenza totale di
compromessi, l’angheria verbale, meglio se gratuita. Come con
grande efficacia scrive Michele Mari in I demoni e la pasta
sfoglia, Céline, “grande untore di
indefinibili sgradevolezze […] si immola come un capro
espiatorio che sussuma tutta la bassezza del mondo, e salvi se stesso e
il mondo trasformando quel male in stile” (Mari, 2010,
p.257). E infine: “In ogni caso ci troviamo di fronte a uno
scrittore che come nessun altro artista ha posto la questione del
manierismo in termini di abiezione, tanto che la sua sigla, i suoi
proverbiali tre puntini, ci appaiono come smagliature di un tessuto,
punture di insetti velenosi, reazioni a un vaccino, punti chirurgici,
melanomi, ictus, o qualsiasi altra cosa sia
estranea alla nostra ingenua idea di salute, di benessere, di
conservazione e autoconservazione. Perché quei puntini, ce
lo dice l’etimologia, sono abietti, sono gettati via,
sono il segno di un continuo sacrificio di sé”.
In
altre parole, il jazzista mi sembra troppo
“educato”, sofisticato, perfino
“pulitino” (pur non ignorando le vicende di droga e
alcol di Charlie Parker, i denti sfasciati di Chet Baker, la tragica
fine di Pastorius, e chi più ne ha più ne metta),
mentre il punk è sistematicamente, geneticamente rozzo,
sporco, eretico, attaccabrighe, bestemmiatore, sgradevole, grottesco ma
mai comico, tantomeno divertente. Uguale: Louis-Ferdinand
Céline.
Il dottor Destouches,
in quanto medico, ha deciso consapevolmente di “mettere le
mani” nelle turpitudini peggiori del corpo umano –
fisico e metaforico – con lo stesso piglio eroico e
strafottente di quel dottor Semmelweis protagonista della tesi di
laurea in medicina di Cèline. Il personaggio reale si
confonde con la pagina; l’io narrante e onnipresente
– testimone di una sproporzionata parabola autobiografica
– coincide con l’uomo Céline. Proprio
come Semmelweis – irruento, caparbio, ma incompreso e
perseguitato – finisce per essere infettato dopo aver
scoperto l’origine della febbre puerperale, Céline
“è un martire-missionario votato allo scandalo e
al paradosso” sostiene Mari. “Per questo, lui
fobico igienista, sguazza nella sporcizia, perché solo dal
basso l’agonismo può essere antivirale; per questo
è persecutore e perseguitato, guerrafondaio e pacifista,
dandy e straccione, sempre sincero e sempre falso […] egli
è lo scrittore che come nessun altro ha insieme ammesso e
negato il perturbante nella propria pagina, una pagina senza dimensione
simbolica perché in essa tutto è
sintomo” (Mari, cit. p. 256). E tutto questo, aggiungiamo,
senza neppure il filtro, freudiano e junghiano, dell’anima,
dell’Io o di chissà quale altro schermo
“psicologico”: l’uomo è il suo
corpo e basta, anatomico, organico, orribile e ridicolo. Se la
letteratura è il mezzo con cui si esprime – si
anatomizza, si descrive, si disseziona – il corpo, la
letteratura stessa non può che raccontarne le malattie, i
morbi, le deformità, le aberrazioni. Non
c’è racconto interiore, flusso di coscienza o
altro, ma sintomatologia e anamnesi di un corpo che sembra impossibile
guarire.
LETTURE
× Céline L.F., Entretiens avec le Professeur Y, 1955, trad. it. Colloqui con il professor Y, Einaudi, Torino, 2009.
× Céline L.F., Semmelweis, 1924, trad. it. Il dottor Semmelweis, Adelphi, Milano, 1975.
× Mari M., I demoni e la pasta sfoglia, Cavallo di Ferro, Roma, 2010.