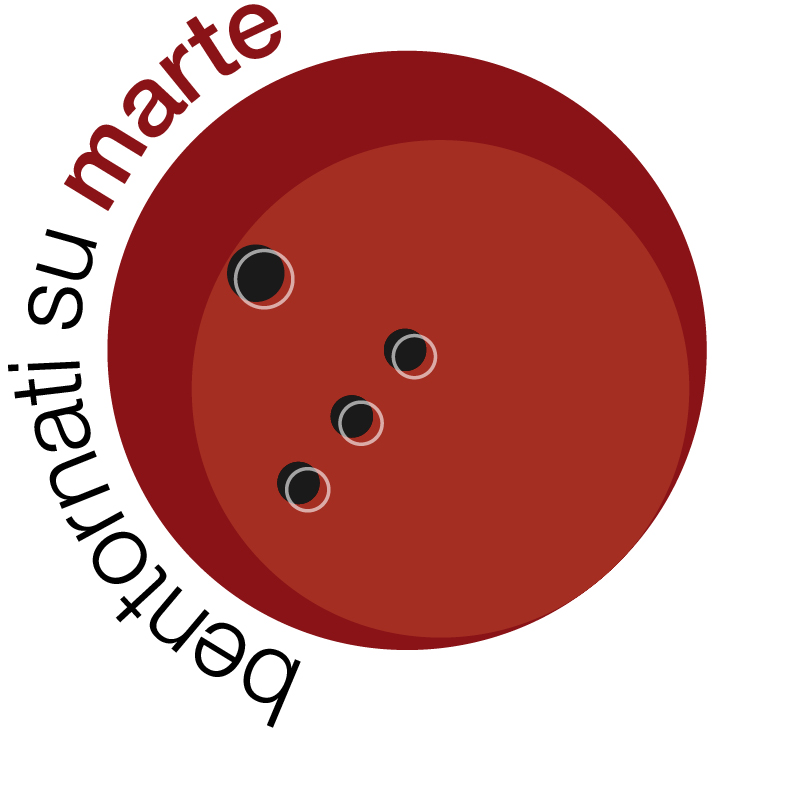Ray Bradbury
Cronache marziane
Traduzione di Giorgio Monicelli
Mondadori, Milano, 2001
pp. 304, €. 12,00
Alla sua uscita nelle librerie americane, nel 1950, e poi, nel 1954 nella traduzione di Giorgio Monicelli in Italia, Cronache marziane di Ray Bradbury sembrò dimostrare come la fantascienza potesse sconfiggere il disinteresse e la sufficienza con cui, a dispetto delle rivendicazioni dei suoi appassionati, veniva guardata dalla cultura accademica e dalla critica letteraria “alta”. L’opera, la seconda in volume pubblicata da Bradbury, è composta di ventotto racconti, alcuni dei quali pubblicati in precedenza su varie riviste, e narra della futura (per allora) esplorazione e colonizzazione (oggi diremmo terraformazione, almeno tentata) del Pianeta rosso. La narrazione si sviluppa nell’arco di ventisette anni, dal 1999 al 2026, dal primo sbarco su Marte di un unico astronauta, alla definitiva adozione di Marte come nuova patria dei terrestri ormai marziani, dopo l’esito di una guerra apocalittica che ha devastato e reso inabitabile il pianeta di origine, la Terra.
Per uno dei paradossi della narrativa di science fiction, seguiamo così quelli che sarebbero stati i nostri discendenti del passato in un futuro alternativo, mentre arrivano prima alla chetichella, poi sempre più organizzati su Marte e pian piano lo occupano, in una migrazione che fa pensare alla invasione dell’America del Nord da parte degli europei fra il XVI e il XIX secolo. In effetti, il Marte di Bradbury assomiglia molto al sud-ovest nordamericano in quanto a paesaggi, orizzonti, panorami, clima. Così come i comportamenti e le azioni dei terrestri immigrati e dei sempre più evanescenti marziani assomigliano molto a quelli dei coloni che popolarono il Nordamerica spostando sempre più a ovest la frontiera, e a quelli dei pellerossa che subirono sempre più impotenti e inermi l’invasione. Contemporaneamente (o forse proprio per questo), il Marte di Bradbury esprime una antichità archetipica, immensa, vertiginosa, in questo raccogliendo e rilanciando un aspetto dell’immaginario tradizionale sul Pianeta rosso, ovvero quello per cui è un deserto arido e desolato non per la sua distanza dal Sole, per le sue dimensioni, per la sua composizione, ma per la sua antichità: è un mondo ormai sfinito, prosciugato, insterilito dall’età, dal fatto che il tempo ha risucchiato ed esaurito tutte le sue risorse. In questo, assomiglia ancor di più al sud-ovest degli Stati Uniti. Tornano in mente le ben più recenti impressioni che il filosofo francese Jean Baudrillard affida al suo diario americano al cospetto del Gran Canyon del Colorado: “Monumentalità geologica, dunque metafisica, l’opposto dell’altitudine fisica dei normali rilievi. Rilievi al contrario, scolpiti in profondità dal vento, dall’acqua, dal ghiaccio, vi trascinano nella vertigine del tempo, nell’eternità minuziosa di una catastrofe al rallentatore” (Baudrillard, 2016)
Quei paesaggi marziani così familiari
L’abisso del tempo che sembra osservarci dalle immense formazioni rocciose del New Mexico, dell’Arizona, dello Utah viene trasferito da Bradbury su Marte, in continuità con gli scrittori di science fiction che lo avevano preceduto: prima di tutto il John Carter di Edgar Rice Burroughs che, guarda un po’, parte proprio dall’Arizona per arrivare sul Pianeta rosso, per arrivare poi a Philip K. Dick e il suo Noi marziani (1964), il cui titolo in italiano (l’originale è Martian Time-Slip, qualcosa come “discronia marziana”) forse involontariamente rimanda all’ultimo racconto delle Cronache di Bradbury, Ottobre 2026: La gita d’un milione di anni: “«Ho sempre voluto vedere un marziano» disse Michael «ma non lo vedo mai. Eppure, me lo avevi promesso, papà!». «Guardali, dove sono, i marziani» disse il babbo, che si tirò Michael in braccio, indicandogli l’acqua. Laggiù, i marziani? Erano là, i marziani, nell’acqua del canale, che ne rimandava l’immagine. Erano Tim, Mike, Robert, la mamma, il babbo. E i marziani rimasero là, a guardarli dal basso, per molto, molto tempo, in silenzio, a guardarli dall’acqua che si increspava lieve…” (Bradbury, 2001).
Realismo panico & science fiction
Scomparsa la Terra, distrutta dalla guerra atomica, la nuova patria degli umani è ormai, definitivamente, Marte. Nostalgia di un mondo mai esistito, di un futuro impossibile? Una delle cifre della scrittura di Ray Bradbury, sicuramente. Che, in fondo, narra la nostalgia degli americani per la vita nella natura incontaminata nei territori che man mano conquistavano alla cosiddetta civiltà, un tratto da sempre presente nel loro immaginario, una dimensione panica probabilmente connessa alla particolare propensione al sacro dei nordamericani, di cui scriveva Harold Bloom, uno dei più grandi critici letterari del Novecento, e, più di recente lo “sciamano” Erik Davis. Tutto rimanda al dominio del magico, dell’immaginifico: un tempo senza tempo, indefinito, al di là della cronologia proposta nei titoli; un luogo continuamente mutevole, dove umano e naturale si alternano e si mescolano, e dove, periodicamente, riemergono le vestigia dell’antichissima, e ormai scomparsa, civiltà indigena, che allude decisamente più al mondo classico dell’antica Europa (l’Ellade, se vogliamo il Medio oriente o il Nordafrica) che a quello autoctono delle grandi culture centro e sudamericane, come quella Azteca, quella Maya, quella Inca. D’altronde, la prima caratteristica che balza agli occhi è il totale disinteresse di Bradbury (che crediamo sia un merito) nei confronti dell’attenzione alle certezze scientifiche dell’epoca, anche quelle più condivise e scontate: i marziani hanno volta per volta caratteristiche diverse (da quelle umanoidi a quelle completamente aliene), l’atmosfera, seppur rarefatta, è in sostanza respirabile anche per i terrestri… Come scrivevano negli anni Settanta del secolo XX i due critici americani Robert Scholes e Eric S. Rabin, “è importante sapere, per esempio, che Ray Bradbury doveva essere consapevole nel 1950 che gli umani non potevano respirare senza aiuto su Marte, questo rivela che intendeva rendere favolistico il suo Cronache marziane” (1977, traduzione dell’autore, ndr). E ancora, “scrivendo dopo la Seconda guerra mondiale, e ben dopo il discredito scaricato sugli argomenti di Lowell sulla vita intelligente (Lowell, l’astronomo americano dell’Ottocento convinto che Marte avesse ospitato vita intelligente, fraintendendo il concetto dei “canali” scoperti da Giovanni Schiaparelli, n.d.a.) Bradbury sapeva bene di poter ancora contare su una platea che condivideva una certa tradizione letteraria su Marte. Collocando Cronache marziane in questo mondo ormai riconosciuto come puramente letterario, poté portare dentro la fantascienza i vantaggi di un paese delle fate convenzionale, quel tipo di luogo di solito richiamato alla mente dalla frase «C’era una volta, in un paese lontano lontano», con l’aggiunta della declinazione nel futuro” (ibidem). Bradbury sposta quindi il baricentro della sua narrazione dalla narrativa di speculazione a quella del meraviglioso, rafforzando la dimensione di una scrittura “poetica” e “favolosa”.

Paesaggi segnati dal tempo
Ancora, la coerenza interna dello sviluppo della storia della migrazione dei terrestri su Marte si regge su un filo sottilissimo, a volte solo intuibile, a partire dalla ambientazione terrestre di partenza: dal sognatore che vuole rendere Marte verde, alberato e fertile come il suo pianeta d’origine e che riesce come per magia nell’impresa (Dicembre 2001: Il verde mattino) alle garrule e ingenue signorine in attesa di partire per raggiungere i fidanzati già emigrati, tipiche giovani donne dell’America di provincia della fine degli anni Quaranta, vestite di vaporose camicette con le maniche a sbuffo e gonne a campana (Giugno 2002: L’immensità), sicuramente ancora ignare della rivoluzione che avrebbe sconvolto i rapporti fra giovani e adulti fra drive-in, blue jeans e rock’n’roll, ai vecchi inaciditi e rancorosi che non riuscirebbero mai a farsi una ragione del fatto che i “negri”, senza chiedere loro il permesso, se stanno andando tutti su Marte (Giugno 2003: Su negli azzurri spazi), alle teste di ponte costituite dai protagonisti dei primi sbarchi di civili: uomini insoddisfatti e in fuga, rudi, coraggiosi; falegnami, prima di tutti, per aprire la strada (immaginiamo) ai carpentieri, ai contadini, ai fabbri… e alle donne (Febbraio 2002: Le locuste). Artigiani, insomma, padroni del loro lavoro, ed eroici nella missione che si sono dati. E, alla fine, ai missionari, i portatori di quella calamità, la religione cristiana, che ha sempre legittimato e spianato la strada alle conquiste dell’Occidente seminando terrore, morte e sensi di colpa (Novembre 2002: Le sfere di fuoco), che però, per una volta, dovrà arrendersi alla potente indifferenza degli indigeni che i monaci inviati su Marte incontreranno: sfere di fuoco azzurro, antichissime, immortali, consapevoli della loro intangibilità, oltre la religione e il sacro. Un mosaico, insomma, che si espande al tempo (futuro) e allo spazio (alieno, ma così familiare), lavorando per frammenti, per sketches, per dettagli di parabole, esemplari e rassicuranti, e i cui tasselli, seppur sporadici, riescono a mostrarci le dimensioni dell’intero disegno. Pure, a rileggere oggi quello che è stato considerato uno dei capolavori di Ray Bradbury, si avverte un’evidente aura di datato, legnoso, scontato. E viene da chiedersi se questa impressione è giustificata, e se sì, da cosa può dipendere. Intanto, come accennavamo in apertura, l’opera fu accolta con molto favore, in patria come in Italia.
Incrociando l’orbita di Hemingway
Sergio Solmi, per esempio, critico letterario raffinato e istituzionale, agli albori della penetrazione della fantascienza in Italia (si veda a tal proposito la storia della science fiction in Italia) scriveva nel 1955 sulla prestigiosa rivista Nuovi argomenti: “Chi si scandalizza della fantascienza, che mai dirà della mia predilezione per uno scrittore come Ray Bradbury? […] Cronache marziane, testé uscito presso l’editore Mondadori… non è, in realtà, un romanzo come si proclama, ma piuttosto una serie di racconti brevi, nati evidentemente da spirazioni diverse e cuciti assieme col filo bianco d’una mirabolante cronaca del Duemila…” (Solmi, 1971). Anche se in realtà viene il dubbio che l’attenzione al libro sia venata di una certa condiscendenza (magari mascherata, almeno da intellettuali come Solmi) legata alla sufficienza con cui comunque veniva vista la narrativa di massa in generale. Ancora il critico, infatti, scrive: “Naturalmente, per leggere Bradbury è indispensabile una certa predisposizione alla meraviglia infantile, un gusto per l’invenzione e la trovata, magari spinte […] una materia fantasticamente così arbitraria spesso si esprime nei termini di quel realismo fresco e pungente che è proprio dell’attuale maggior corrente della letteratura americana, che fa capo a Hemingway” (ibidem, corsivo dell’autore, ndr).
Ecco, forse qui troviamo una traccia che ci permette di capire l’ambivalenza di Solmi che oscilla fra la passione per la fantascienza e il paternalismo, la sufficienza che emerge a tratti dal suo discorso. Le opere di Hemingway erano già note in Italia, dove ne erano state pubblicate un paio durante la Seconda guerra mondiale e poi a cascata, tutte le opere maggiori, fino a Il vecchio e il mare, pubblicato nel 1952 da Mondadori, quindi due anni prima di Cronache marziane. Proprio su Il vecchio e il mare si concentrò nel 1964 Umberto Eco in Apocalittici e integrati per ragionare sui rapporti fra letteratura di massa e letteratura mainstream. E, ispirandosi alle analisi di Dwight McDonald, intellettuale americano estremamente critico nei confronti della cultura istituzionale ma anche di quella di massa, Eco si concentra su un registro, quello del Midcult, “bastardo del Masscult” (Eco, 2001), che a MacDonald (1969) “appare come «una corruzione della Cultura Alta», che di fatto è soggetto ai desideri del pubblico, come il Masscult, ma in apparenza invita il fruitore a una esperienza privilegiata e difficile” (ibidem). Secondo Eco, che riprende MacDonald, il romanzo di Hemingway è perfetto per esemplificare questo registro “bastardo” della produzione letteraria, nel suo essere scritto in una “prosa falso-biblica… con una grande abbondanza di «e, e, e»… in modo da conferire al tutto la cadenza di un antico poema, i personaggi sono mantenuti in un’aura di generalità (il Bambino, il Vecchio)… proprio per sottolineare l’impressione che non siano individui, ma Valori Universali” (ibidem). E si potrebbe andare avanti ancora su questo piano. Il punto chiave è che il romanzo “procede continuamente sull’orlo della falsa universalità” (ibidem): dà l’impressione di voler mettere in scena valori immortali, eterni, mitici, l’Arte che rappresenta la Vita, si ferma piuttosto alla rappresentazione di Hemingway che imita Hemingway, scivolando fatalmente nel kitsch.
Lo stesso si può scrivere di Bradbury. I lunghi elenchi di cose e persone, i personaggi che vorrebbero essere esemplari, il racconto che procede a ondate. Tutto vuole rimandare alla dimensione del Mito, un mito moderno, ancora a venire, che ritorna continuamente all’epica della Frontiera americana, per rilanciarla nostalgicamente, esaltarne i protagonisti, e magari diluire il senso di colpa nei confronti dei pellerossa, di cui i marziani rappresentano una trasparente replica.
Indiscutibile punto di non ritorno
Comunque sia (e sia stato), Cronache marziane rappresentò uno spartiacque, un punto di non ritorno: riepilogando l’immaginario su Marte, per il registro scelto scatenò gli entusiasmi degli appassionati e la curiosità della critica ufficiale, e aprì alle esplorazioni narrative successive; fino al Desolation Road di Ian McDonald del 1988 e alla Trilogia di Marte (1992-1996) di Kim Stanley Robinson, solo recentemente pubblicata in Italia. E, a proposito dei predecessori e dei continuatori di Bradbury, lo studioso anglosassone Edward James scrive in Science Fiction in the 20th Century che “Marte ha avuto tutti i tipi possibili di trattamento, dalla romantica terra di guerrieri e principesse perdute di Edgar Rice Burroughs alle nostalgiche immagini della cultura del Midwest americano coesistente con i fantasmi della antica civilizzazione marziana di Ray Bradbury […] Ancor più oneste nel confrontarsi con la tradizione fantascientifica sono tre romanzi di scrittori britannici: Desolation Road di Ian McDonald (1988), Red Dust di Paul McAuley (1993) e Harm’s Way di Colin Greenland (1993). McDonald rivisita il Marte di Bradbury e vi infonde lo spirito di Cent’anni di solitudine di Gabriel García Márquez (1967), il classico romanzo del realismo magico sudamericano” (James, 1994, traduzione dell’autore, ndr).
In realtà, se McDonald si è richiamato in maniera esplicita al realismo magico della narrativa sudamericana della seconda metà del Novecento, è vero che già fra Bradbury e García Márquez sono visibili delle similitudini: la dimensione epico-mitica, senz’altro, ma, prima di tutto, le radici dell’immediato successo che ebbero ognuno a suo tempo le due opere; in un caso per la presunta introduzione nella science fiction delle forme della letteratura alta e del riscatto della semplicità, nel secondo, per la visionaria carica di denuncia dei poveri, degli oppressi, degli sfruttati dell’America latina in un’epoca di grandi ribellioni e solidarietà globali. A ben vedere, forse il romanzo di García Márquez non regge davvero al tempo (ormai è passato mezzo secolo dalla sua pubblicazione in Italia nel 1968 per Feltrinelli), come non regge al tempo la raccolta di racconti di Bradbury: laddove il realismo magico di García Márquez finisce per ridursi a un fantasioso, accattivante ossimoro, il panismo nostalgico di Bradbury si rivela come un anchilosato tentativo di imitazione di uno stile riservato al passato.
- Jean Baudrillard, America, SE, Milano, 2016.
- Harold Bloom, La religione americana. L’avvento della nazione post-cristiana, Garzanti, Milano, 1994.
- Edgar Rice Burroughs, John Carter e la principessa di Marte, Mondadori, Milano, 2012.
- Philip K. Dick, Noi marziani, Fanucci, Roma, 2016.
- Umberto Eco, Apocalittici e integrati, Bompiani, Milano, 2001.
- Gabriel García Márquez, Cent’anni di solitudine, Mondadori, Milano, 2016.
- Ernest Hemingway, Il vecchio e il mare, Mondadori, Milano, 2015.
- Edward James, Science Fiction in the 20th Century, Oxford University Press, Oxford-New York, 1994.
- Dwight MacDonald, Controamerica, Rizzoli, Milano, 1969.
- Ian McDonald, Desolation Road, Zona 42, Modena, 2014.
- Kim Stanley Robinson, Il rosso di Marte, Fanucci, Roma, 2016.
- Kim Stanley Robinson, Il verde di Marte, Fanucci, Roma, 2016.
- Kim Stanley Robinson, Il blu di Marte, Fanucci, Roma, 2017.
- Robert Scholes, Eric S. Rabin, Science fiction History Science Vision, Oxford University Press, London-Oxford-New York, 1977.
- Sergio Solmi, Ray Bradbury, in Della favola, del viaggio e di altre cose Saggi sul fantastico, Ricciardi, Milano-Napoli, 1971.