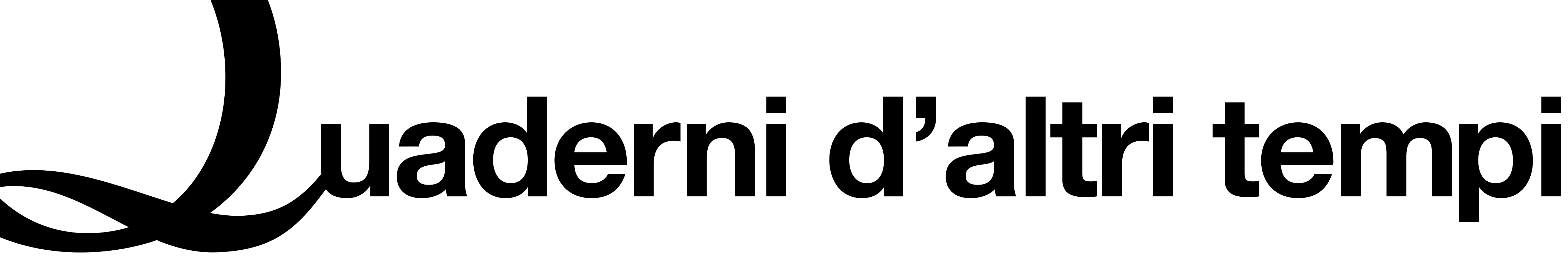A ben vedere, anche se il verbo qui stride parecchio, lo scenario che presentava la serie prodotta da Apple+, See (tre stagioni dal 2019 al 2022) narrava di uno sviluppo tutto sommato plausibile di quanto aveva immaginato John Wyndham circa settant’anni prima nel romanzo Il giorno dei trifidi, un classico, un autentico stracult, tornato in libreria nella nuova traduzione italiana di Marisa Bulgheroni per Neri Pozza. Nella serie che aveva per protagonista principale Jason Momoa, quanto resta dell’umanità a seguito di un virus è non vedente e sopravvivere in quel mondo è affare violento. Una condizione terrificante descritta alla perfezione nel romanzo di Wyndham senza indulgere in dettagli raccapriccianti e in situazioni all’insegna dell’orrore più spettacolare. La sua scrittura possiede dignità letteraria sopra la media dei prodotti di genere, in special modo di quelli dell’epoca. Ecco perché tra intuizioni rivelatesi nel tempo anticipazioni dei disastri e dei timori contemporanei e un’espressione letteraria sofisticata, il romanzo è da annoverare tra gli imperdibili della fantascienza. Un titolo meritato e guadagnato nonostante che a Hollywood ci si impegnò non poco nel farne una trasposizione cinematografica nel 1963 davvero brutta e pasticciata che l’edizione italiana in un primo momento riuscì anche a peggiorare intitolandolo L’invasione dei mostri verdi. Soltanto nel 1976 venne ridistribuito con la traduzione letterale del titolo originale identico a quello del romanzo (anche la prima edizione di Urania, va detto, modificò il titolo, trasformandolo in L’orrenda invasione). Si faranno preferire i diversi adattamenti radiofonici della BBC (nel 1957 e nel 1968) e assai più convincenti si sono rivelati le trasposizioni per la televisione messe a punto sempre dalla BBC: la prima nel 1981 articolata in sei puntate e in seguito una miniserie in due episodi andata in onda nel 2009 (dagli adattamenti per la tv sono tratte le immagini a corredo dell’articolo, ndr).

Per chiudere con il cinema, chi in realtà gli ha reso in tempi più recente un formidabile omaggio è stato Danny Boyle con l’intera sequenza iniziale del suo 28 giorni dopo (2002). La Londra ridotta a un ammasso di corpi senza vita, macchine abbandonate, per lo più distrutte, principi d’incendio, suoni acusmatici che infrangono un silenzio assordante, le scene di un disastro colossale che un ragazzo di nome Jim, il protagonista del film, si trova di fronte al momento del suo risveglio in ospedale dopo ventotto giorni in terapia intensiva, è la fotocopia di quella che si presenta agli occhi del protagonista del romanzo, Bill Masen. Lui è un biologo finito come succederà poi a Jim in una struttura ospedaliera, nel suo caso per porre riparo agli effetti del veleno con cui è entrato in contatto mentre lavorava con piante d’allevamento, potremmo dire: i trifidi appunto.
Creature vegetali, alte circa due metri, frutto di esperimenti di laboratorio, perché “di sicuro non crebbero per generazione spontanea, come pensarono alcune anime semplici”, come annota Masen a un certo punto, preziosissime per l’olio che se ne estrae. Hanno però il vizio di saettare un aculeo per iniettare veleno letale nei malcapitati che si trovano alla giusta distanza, qualsivoglia creatura vivente, umani compresi. Il guaio è che il pungiglione non è un’arma di difesa, ma di attacco, necessaria ai trifidi per procurarsi cibo, essendo carnivore. Difatti, dopo che il corpo della vittima ha iniziato a decomporsi, i trifidi si nutrono della carne in putrefazione. A renderli ancora più pericolosi è la loro capacità di muoversi, deambulando sui tre grossi steli/radici, che trascinano lentamente, sì, ma eppur si muovono. Quando tutti o quasi perdono la vista, dopo aver osservato la luce verde emanata dalla cometa (ma “siamo sicuri che fosse una cometa?”, dice il protagonista a un certo punto), inizia una doppia apocalisse, perché all’immane difficoltà di sopravvivere senza vedere si aggiunge il trifido di turno sempre in agguato, silenzioso, per colpire e nutrirsi.
“Orribili creature che l’uomo stesso aveva creato chissà come, e che ora fiorivano e trionfavano sulle nostre rovine…”.
D’altronde, come scrisse Wyndham in un successivo e altrettanto celebre romanzo The Midwich Cuckoos (o Village of the Damned) da noi noto sia come Il villaggio dei dannati (lo stesso dicasi per il film che ne fu tratto, l’ottimo lungometraggio di Wolf Rilla uscito nel 1960) che con il titolo I figli dell’invasione:
“Non c’è concetto più falso del senso di affettuosa domesticità implicito nell’espressione Madre Natura. Ogni specie deve lottare per sopravvivere, e lo fa con ogni mezzo in suo potere, per quanto odioso sia”
(Wyndham, 1984).
Nel magistrale incipit, Bill Masen si rende subito conto che quella mattina qualcosa non va, mentre è in attesa di essere sbendato e mandato a casa dopo aver verificato l’efficacia delle cure per i suoi occhi.
“Quando un giorno che secondo voi dovrebbe essere mercoledì vi sembra, fin dall’inizio, domenica, potete stare certi che qualcosa non va. Ebbi subito questa impressione, svegliandomi”.
La notte precedente tutto il mondo o quasi, aveva atteso in preda a un’eccitazione collettiva che l’orbita della Terra passasse “attraverso una nube formata da frammenti di cometa […] il più grandioso spettacolo celeste cui si fosse mai assistito”. È l’inizio della fine, perché quella mattina la quasi totalità degli esseri umani, tutti coloro che avevano assistito a quello spettacolo si ritrovano ciechi, e per giunta in balia dei trifidi, ora liberi di scorrazzare per il pianeta. Tutti, tranne qualche fortunata eccezione, come nel caso di Masen, che ne è ben cosciente:
“Se non fui travolto subito anch’io dalla fine del mondo – il mondo quale l’avevamo inteso fino a quel momento –, fu per caso; come per un destino di sopravvivenza, a pensarci bene”.
Prende il via da qui un magistrale romanzo di sopravvivenza, che vedrà Masen fuggire da una Londra devastata cercando una condizione più favorevole nella campagna inglese, obiettivo tutt’altro che facile da raggiungere. un compito arduo, anche perché tra gli umani ancora in grado di vedere, ci sono non pochi malintenzionati, a riprova dell’antico adagio, homo homini lupus. Un romanzo che fissa le coordinate del genere survival ma anche una storia di denuncia, tra i primi a segnare la svolta della fantascienza, che per l’intero decennio abbandonerà i temi dell’età dell’oro, utopico-scientifiche, rivolgendo il suo sguardo a nuove tematiche caratterizzate da critica sociale, puntando il dito contro le degenerazioni della società industriale avanzata. Qui il sospetto consiste nell’ipotizzare una causa umana per la cecità collettiva, come insinua Masen, dopo aver accennato alla corsa allo spazio:
“Supponi, ora, che uno di quei satelliti fosse stato costruito per emettere radiazioni capaci di ledere irrimediabilmente il nervo ottico…”.
E a partire dal mercato statunitense si rovescia uno dei valori fondanti del genere, perché dalle meraviglie della scienza e della tecnica, panacea di tutti i mali, motori di uno sviluppo (e di una produzione) che si espande illimitatamente, si passa alla messa in dubbio dei valori tecnico-scientifici o quantomeno il futuro inizia a far paura. Fioriscono in quegli anni le distopie, le società da incubo, nasce la cosiddetta fantascienza sociologica, in particolar modo sulle pagine della rivista capofila del movimento, Galaxy, sulla quale scrivono autori come Robert Sheckley, Frederick Pohl, Cyril KM. Kornbluth, Damon Knight. A favorire questa rivoluzione copernicana erano state le bombe sganciate su Hiroshima e Nagasaki e contemporaneamente il cambio generazionale del pubblico (oltre al considerevole boom delle riviste specializzate) con il passaggio dai giovanissimi lettori degli anni Trenta e Quaranta agli universitari e a tecnici del nuovo decennio. Arrivano anche i grandi irregolari che mescolano le carte del genere stesso, in alcuni casi facendo proprie anche le tematiche sociologiche, come Alfred Bester o il giovane Kurt Vonnegut jr, e soprattutto Philip K. Dick, oppure l’iconoclasta Philip José Farmer.

In questo scenario, la produzione letteraria di genere nel Regno Unito, condivideva con caratteristiche particolari l’apprensione per il futuro, che appariva ricco di incognite tutt’altro che rassicuranti. Gli autori inglesi dedicarono la propria attenzione alle mutazioni pericolose della natura indotte dall’uomo, coltivando e portando a maturità il filone catastrofista, a suo modo imparentato con le varie cronache del dopobomba redatte negli USA. Il giorno dei trifidi nacque all’alba di questa stagione e ne codificò il canone oltre a preludere alle narrazioni del decennio successivo, a quelle visioni pericolose di cui James Ballard si fece cantore iniziando proprio da un poker di catastrofi. Interprete del suo tempo ma anche erede di una tradizione fantascientifica tutta britannica, perché è indubbio il legame tra lo scenario del romanzo di Wyndahm e La guerra dei mondi di H. G. Wells, autore che tralaltro Bill Masen cita a proposito del racconto Il paese dei ciechi.
Profilo d’autore
Ma chi era John Wyndham al secolo John Wyndham Parkes Lucas Beynon Harris? Quando pubblicò Il giorno dei trifidi, vantava già un ventennio di attività letteraria e aveva sfruttato l’opportunità di utilizzare diversi pseudonimi (John Beynon, Wyndham Parkes) grazie a un simile nome, arrivando a firmarsi semplicemente John Wyndham proprio con Il giorno dei trifidi. Aveva esordito nel 1931 sulle pagine della rivista statunitense Wonder Stories con un racconto intitolato Worlds to Barter che convinse a metà. Arrivò al romanzo con The Secret People pubblicato a puntate sulla rivista inglese The Passing Show nel 1935. Una storia che prendeva le mosse “dal progetto di fertilizzare il Sahara trasformandolo in enorme lago interno con l’apporto di acque dal Mediterraneo, e dall’incidente capitato ad un giovane inglese, che precipita con il suo aereo privato ed una ragazza nel lago in formazione” (Montanari, 1977). Il grande successo de Il giorno dei trifidi lo convinse definitamente a proseguire la carriera di scrittore di fantascienza, dando alla luce oltre al succitato I figli dell’invasione, almeno un altro romanzo di egual valore, I trasfigurati (The Chrysalids, 1956), la sua personale rivisitazione del tema dei mutanti, qui collocati all’interno di una società che li perseguita e li condanna al rogo in quanto li ritiene figli del demonio non rispondenti alla descrizione di uomo fatto a immagine e somiglianza di Dio. Si tratta di lavori invecchiati bene e poco, così come alcuni racconti, in primis, Considera le sue vie (Consider Her Ways, 1956), che in anticipo sui tempi solleva questioni legate all’emancipazione femminile.

Tornando a Bill Masen e alla sua lotta per sopravvivere, c’è da aggiungere che contrariamente agli eroi degli anni precedenti, quelli dei sogni dorati della fantascienza tecnologica, ma anche diversamente da anti eroi radicali che iniziavano a farsi largo nella narrativa dell’epoca, è un uomo, come spesso accade nelle storie di Wyndham, che “è cosciente di trovarsi fronteggiato da una società stupida e spesso crudele (sia essa composta da membri del governo o da masse popolari alienate), e cerca quasi sempre rifugio nell’affidarsi al proprio buon senso o a risorse personali” (Montanari, 1977).
Al di là di quanto ci si possa identificare in questo profilo, del romanzo rimangono i temi di fondo: manipolazione genetica, incidente tecnologico, armi ultra sofisticate di distruzione di massa, genocidio, un corto circuito che rende ancora attuali le parole di un altro dei personaggi del romanzo, Michael Beadley:
“la via della sicurezza cominciò a restringersi fino a divenire sottile come una corda tesa, lungo la quale dovevamo camminare con gli occhi deliberatamente chiusi sugli abissi sottostanti. In ogni momento degli anni trascorsi da allora avrebbe potuto verificarsi la fatale caduta. E possiamo essere sicuri che, presto o tardi, si sarebbe verificata. Che poi questo potesse avvenire per malvagità, disattenzione o incidente non ha importanza. Il risultato sarebbe stato lo stesso”.
Verrebbe da dire che c’è da tenere costantemente gli occhi aperti, sempre che poi questo non risulti fatale…
- Gianni Montanari, Ieri, il futuro. Origini e sviluppo della SF inglese, Edizioni Nord, Milano, 1977.
- John Wyndham, I figli dell’invasione, in John Wyndham. I Massimi della Fantascienza, Mondadori, Milano, 1984.
- John Wyndham, I trasfigurati, Neri Pozza Editore, Vicenza, 2015.
- Danny Boyle, 28 giorni dopo, 20th Century Fox, 2004 (home video).
- Ken Hannam, The Day of the Trifids, BBC One, 1981.
- Steven Knight, See, Apple Tv+, 2019-2022.
- Steve Sekely, Il giorno dei trifidi – L’Invasione dei mostri verdi, Passworld, 2012 (home video).