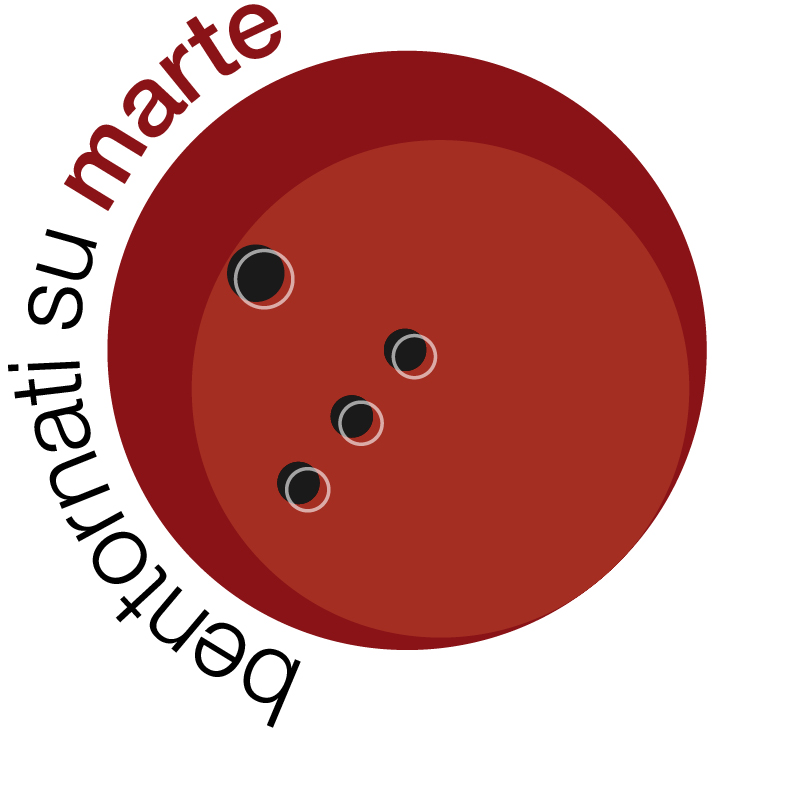Lieti, come i suoi astri volano
attraverso la volta splendida del cielo,
percorrete, fratelli, la vostra strada,
gioiosi, come un eroe verso la vittoria.
Friedrich Schiller, Poesie filosofiche

Philip K. Dick
Noi marziani
a cura di C. Pagetti
Fanucci, 2016
pp. 281, € 16,00
Attraverso le funzioni-segno narrative della science fiction, estremizzandone le convenzioni e arricchendole con significativi riferimenti alla cultura underground degli anni Sessanta, i metaforici viaggi su Marte di Philip K. Dick, immaginati in varie sue opere, consentono all’autore di rappresentare problematici aspetti della contemporaneità, adombrando il futuro, instaurando relazioni simboliche e proiettandosi verso un orizzonte metafantascientifico, non traducibile in mero “gioco intellettuale”, bensì in attenta interpretazione della “crisi che travaglia l’uomo tecnologico e [in particolare] la società americana del Ventesimo secolo” (Pagetti, 1989).
Le visioni allucinate e la bizzarra phantasìa che animano la produzione letteraria dickiana, mai identificabili semplicisticamente in puro escapismo, in futili evasioni dalla palpabile quotidianità, si rivelano piuttosto tentativi di far spaziare nell’orbita della speculative fiction tematiche ancorate alla realtà sociale, evocando i miti letterari che hanno forgiato la percezione del pianeta rosso e attraversando l’oscuro percorso che si lancia avveniristicamente dalla falla temporale degli anni Sessanta al buco nero del futuro.
Il viaggio su Marte diventa il pretesto per raccontare la previsione del “crollo del mito del pionierismo spaziale” (ibidem), tracciando un segmento di immaginario condiviso a livello planetario e tratteggiando grazie alla letteratura quella sfera della realtà statunitense segnata dal declino delle utopie liberiste nonché dalla definitiva metamorfosi dell’American dream in “incubo metastorico” (Pagetti, 1998): gli slittamenti temporali di Noi Marziani, uno tra i più straordinari romanzi dickiani, pubblicato nel 1964 ma scritto nel 1962, anno carico di drammatiche tensioni politiche internazionali, si configurano come un vertiginoso viaggio agli Inferi, che dissolve la luminosità, alimentata dal mito positivistico dell’ortodossia fantascientifica, per avvolgere il quarto pianeta nel buio spettrale di un distopico cono d’ombra. Così come la figura dell’alieno, il paesaggio marziano sembra costituire una “congettura mitologica”, una forma di materializzazione, di proiezione nel vuoto degli archetipi dell’inconscio collettivo (cfr. Jung, 1998), quelle immagini arcaiche, primordiali, appartenenti al patrimonio comune dell’umanità, risultato di esperienze ricorrenti nella vita, come la nascita, la fuga dal pericolo o la morte (cfr. Jung, 1977).
Le dickiane descrizioni di Marte riproducono le ambientazioni selvagge e le aride distese desertiche di una natura minacciosamente sinistra, desolata riproduzione dell’habitat terrestre: è raffigurata una vegetazione “magra e malsana”, dall’“aspetto cadaverico, come se qualcosa l’avesse avvelenata”, mentre, laddove giacciono uccelli morti e carogne sfatte, il vento fa frusciare cespugli “nudi e spolpati come ossa” (Dick, 2016) piantati nel suolo di un’ecosfera mutilata. Delineando l’immagine di una terra dissacrata e massacrata, piagata e agonizzante, opus alienum, Dick rende visibile il risultato delle dinamiche promosse dagli interessi oscillanti tra struttura produttiva, rapporti di potere e architettura istituzionale.
Verità collettive e doppi fantasmatici
In un susseguirsi di inquietanti sequenze narrative, Marte, colonia cinicamente depauperata dalla Terra, costituisce l’amara “parodia delle colonie americane delle origini, della Frontiera del West”, ma anche della competizione accanita su cui si fonda “il Capitalismo rampante esportato oltre ogni confine (Pagetti, 1998), nonché dell’ottuso contrasto antagonistico tra i progetti di perversa speculazione edilizia che baronie e clan rivali, divorati dalla legge impietosa del profitto e dominati dalla lotta feroce per il potere, mirano a realizzare su un territorio suddiviso in aree sfruttate da predatori potentati economici. Probabilmente destinato a esser trasformato da un colossale evento economico, il pianeta rosso riproduce dunque la comunità americana “disossata di tutte le mediazioni […] etiche” e basa i propri fondamenti culturali su un sistema pedagogico realizzato da una “serie di automi dai nomi altisonanti (Mark Twain, Thomas Edison), depositari di una conoscenza meccanica, […] conformista” (ibidem), implacabile dispositivo di rimozione di ogni elemento eccentrico e di ogni forza eslege rispetto al disegno originario di perpetuazione di un’organizzazione simbolica legittimante l’efferato status quo. Macroscopica entità automatica, singolare organismo artificiale, la Scuola, con i suoi Insegnanti Androidi, fortifica il legame indissolubile con l’eredità valoriale tramandata dal pianeta madre, rivelandosi uno strumento volto non solo a informare o a istruire, ma teso soprattutto a plasmare la personalità soggettiva, secondo modalità rigidamente determinate, attraverso un’educazione ideologizzata, ispirata alle esperienze della tradizione, innervata sull’interiorizzazione di costruzioni nomiche reificate, cristallizzate, nonché funzionalizzata secondo finalità in grado di garantire la deviante continuità della “verità collettiva” (Frasca, 1989).
L’elusione del contesto prescrittivo si attesta in Dick attraverso la ricerca di potenti suggestioni che consentono di contravvenire alle norme sanzionate dalle convenzioni sociali nonché di disattendere le pretese di uniformità delle maggioranze costituite, affidando unicamente alla soggettività la testimonianza dell’esperienza. Nei romanzi e racconti ambientati su Marte l’abbandono di una terra oppressiva e disumana si traduce in approdo a un pianeta abitato da eventi e creature orrorifici, dunque altrettanto ostile, avverso e disforizzante. Esemplare a tal proposito appare l’interminabile transito compiuto dai protagonisti di Tornando a casa, memorabile racconto del 1959, in cui sei astronauti, provenienti dal maledetto inferno rosso, invaso da mosche e detriti, orbitano indefinitamente intorno ai continenti e agli oceani terrestri. La loro nave spaziale, o meglio il suo doppio fantasmatico, tenta vanamente di ricongiungersi alla Terra, mentre l’equipaggio, in realtà schiantatosi sul suolo marziano, nell’assoluta irrealizzabilità di un aggancio con il reale, appare condannato a un disperato ed eterno anelare, paradossalmente coincidente con un’invincibile brama di morte.
Riferito ineludibilmente al turbinio dello spaesamento è anche la struggente descrizione in Noi Marziani degli aborigeni, chiara allusione alla questione razziale, fortemente sentita da Dick, alla condizione, dunque, della schiavizzata popolazione nera, evocazione resa ancor più palese dall’uso del termine “Bleekman”, assonante alla parola “Blackman” (cfr. Vaccari, 1989), nonché della vetusta civiltà dei pellerossa superstiti, i quali non si sono mai integrati con la dominazione colonizzatrice e mai adattati alla realtà dissonante dello sviluppo urbano, edificato su una terra in passato amica e ospitale, ma successivamente animata dalle spietate strade delle megalopoli in cui si realizza l’ineludibile trionfo della più accanita iperproduttività e del consumismo più selvaggio.
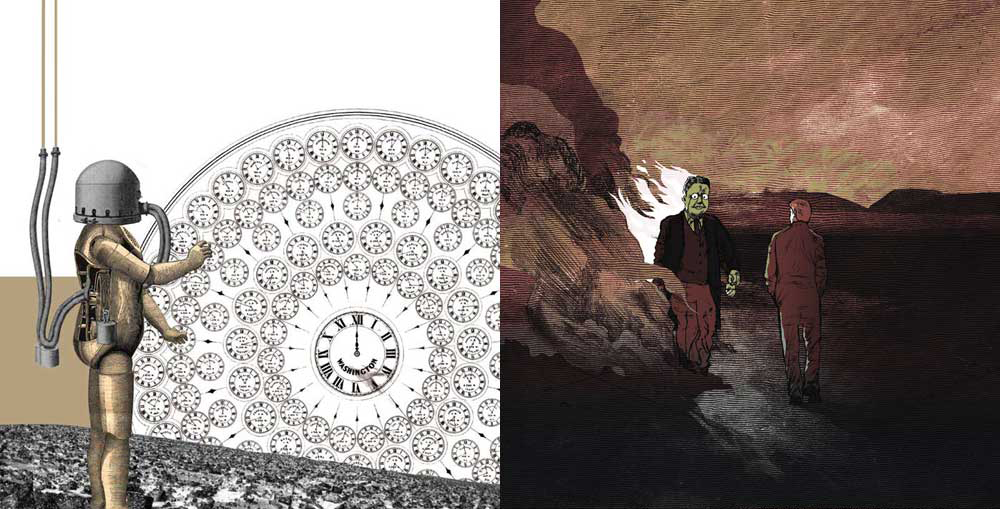
Distopie del presente e vanitas vanitatum
I disorientati indigeni, allontanati dalla consuetudine del tempo ordinario, mostrano capacità preveggenti simili alle facoltà mentali di un bambino autistico, Manfred Steiner, figura chiave dell’intreccio narrativo, che percepisce gli effetti perversi di un presente distopico. Il devastante programma edilizio crea futuri scenari “di rovina e di disperazione, e di un avvilimento inerte, grave, senza tempo” (Dick, 2016), sovrastati da stormi di neri uccelli, enormi e cupi, simili ad avvoltoi, mentre il piccolo protagonista, come prigioniero, con uno sguardo perduto e senza speranza, scruta l’oscuro degrado circostante. È questa la precognizione, miseramente tetra, dei sobborghi diroccati, percepiti dall’occhio di Manfred, “ciclone esistenziale entro cui si dissolve ogni certezza” (Pagetti, 1998). Nella drammatica affermazione di un’espressione assolutamente idiosincratica, indubbio appare il rinvio all’orrifico grido levato dagli allegorici, vorticosi turbinii dell’angoscia munchiana, esplicitamente richiamato in un perturbante luogo di Ma gli androidi sognano pecore elettriche?, straniante romanzo dickiano pubblicato nell’“antinomiano” (Hobsbawm, 1995) 1968, in cui la presenza aliena dallo spazio esterno affiora nello spazio interno come insorgenza dell’“inconscio filogenetico” (Dick, 1997), come epifania di inquietanti misteri nascosti nella psiche collettiva umana.
Dick ha spesso scritto di “mondi simulati, semireali, così come di mondi singolari deviati, spesso abitati da una sola persona” (ibidem): il piccolo Steiner è il “figlio dell’uomo” nonché il più rappresentativo esempio di un’“alienità” che viaggia con i protagonisti dalla Terra a Marte e che “contamina il principio stesso della colonia planetaria tanto caro alla tradizione fantascientifica” (Pagetti, 1998). Egli attrae coloro che incontra nella sua realtà, crudelmente “atroce, erosa dall’entropia, un territorio” in cui “tutto è successo e succede nello stesso momento, in cui non potrà mai succedere niente di nuovo, una vita che è come la morte”, un “mondo della tomba”, pronto a “inghiottire tutti quelli che gli si avvicinano, a diventare ogni creatura e ogni cosa, [in cui] tutti diventano Manfred” (Carrère, 2016).
Lo spettacolo di distruzione prima descritto è offerto dai quartieri-dormitorio al centro di un rapace piano di investimento immobiliare, attraversati da una strisciante ventata di putrefazione avvertita dal bimbo autistico, che trascina in un futuro disastrato gli edifici precogniti, denominati AM-WEB: Allen Menschen werden Brüder (Tutti gli uomini diventano fratelli), con rinvio tristemente ironico all’auspicio schilleriano. Il piccolo Steiner, che “condensa” in un incomprensibile “squittìo” il “vanitas vanitatum dickiano”, percepisce l’avvenire nella soggettività della patologia che lo rende “statutariamente fraintendente […] e, dunque, unico autentico depositario del vero” (Frasca, 1989). Manfred domina l’alternativo mondo marziano immergendolo nel proprio indecifrabile silenzio, nel proprio solitario sgomento, coltivando un hortus clausus attraversato da tenebrose correnti e dimorando così in una riserva protetta, costruita su strutture e segni di un linguaggio solipsistico che nega ogni potenzialità comunicativa. La sua profezia, destinata a restare inascoltata e a essere interpretata come un insignificante e delirante balbettio, esprime compiutamente l’angoscia dell’esserci alla mercé del terribile che lo sovrasta, tormentato da un delirio di corruzione dove nulla è in contatto soltanto con il sé, ma sempre anche con ciascun’altra cosa. Gli accadimenti futuri adombrati suonano la “campana a morto” per ognuno dei personaggi, “reietti della Terra vomitati con qualche bella promessa su Marte, pronti a riciclarsi, anche lassù, in immondizia, spazzatura” (Pagetti, 1998), quel gubble indistinto a cui la vita marziana è ridotta e da cui è impossibile, oltre che inutile, fuggire per tornare sul pianeta di origine, ormai anch’esso inesorabilmente in disfacimento, devastato dalla “materia pura su cui vanamente si accanisce ogni forma” (Frasca, 2007) e che ossessivamente ricorda che tutto tornerà ad esser polvere.
Profezie del silenzio e solitudine cosmica
Nella waste land marziana gli smarriti abitanti compiono il proprio percorso fino alla fine, verso l’abisso dell’abisso, ed è soltanto il raggiungimento di quel limite estremo, che, forse, permetterà una rinascita, resa possibile dalla comprensione dell’indecifrabile farfugliare di Manfred, il quale, alla fine del romanzo, ormai vecchissimo, nell’implosione di un tempo deformato, tornerà dall’avvenire. Diventato decrepito, circondato dai primitivi Bleekman, capaci di condividere le sue visioni nonché di assistere caritatevolmente al suo declino, contrastato da circuiti, batterie e valvole, il “profeta del silenzio” (Pagetti, 1998) sembra finalmente aver sbloccato il guasto dialogico ed essere in grado di articolare suoni, anche se innaturali, di pronunciare parole, anche se stridule. “Il soggiorno era pieno di Bleekman. E, in mezzo a loro, […] parte di una creatura vivente, un vecchio, solo dal petto in su; il resto era un groviglio di pompe, tubi e quadranti, un macchinario incessantemente attivo che ticchettava. […] La cosa parlò. -Jack Bohlen-, stridette; la voce usciva da un altoparlante, non dalla bocca. -Ora ti posso ringraziare-, disse il vecchio” (Dick, 2016). Ridotto a un ammasso di carne rattrappita e congegni meccanici, un irriconoscibile Manfred esprime gratitudine per chi ha provato a comprenderlo, e lo fa con una voce artificiale che sembra di poter udire, con una fatica straziante che sembra di poter vedere. Un lamento che ne evoca un altro, altrettanto inquietante, altrettanto mostruoso, altrettanto inaspettato, apparente vibrazione di corde vocali umane lese, in realtà spaventoso mugolio di un cane del dopobomba, un cane alieno con il dono della parola, trotterellante e scodinzolante (cfr. Dick, 2006), diventato altro da sé, trasformato crudelmente da una mortificante mutazione, aberrazione che atterrisce e intenerisce, destando sbigottimento e compassione, nonché un inesauribile, perturbante alternarsi di altre fosche e indefinibili emozioni.
“Emblema vivente” della “solitudine cosmica” e dell’“incomunicabilità totale”, radicata in una “visione di metafisico orrore” (Pagetti, 1989), il solitario protagonista dimostra che quando l’estraniazione dell’esserci è pressoché totale, l’esperienza delirante si muove disegnando un circolo e costituendo un modo della temporalità in cui l’esserci ricade su se stesso come nudo esserci, assolutizzando la sensibilità per il terribile. Il baratro in cui vive Manfred, vale a dire l’esperienza della morte perenne, è segnato dall’“inaudita restrizione della struttura temporale [e spaziale] e quindi dell’ex-sistere, […] nel senso del rimanere fissati nella permanente prospettazione di qualcosa di minaccioso” (Binswanger, 1994), l’inesorabile, unico possibile punto di vista, dimensione esclusiva e totalizzante, il grembo-tomba, il womb-tomb che ha arredato anche il “mondo schizofrenico di Ellen West” (Frasca, 2007), reso noto da Ludwig Binswanger allo stesso Dick, che ne fu a lungo ossessionato. Bloccato nell’arresto di un tempo distorto che non si sviluppa più nella spirale delle proprie estasi, in nome dell’apparire simultaneo di ciò che fu, ciò che è e ciò che sarà, il piccolo Steiner, che scorge il “paesaggio permanente” (ibidem), risolve il proprio paradosso non nella mera distorsione di uno schematismo trascendentale, bensì in un processo di annichilimento che infrange sia l’armonia del cerchio temporale che ripete se stesso sia l’idea di una durata come catena di istanti che acquisiscono senso l’uno in funzione dell’altro. Oltre a suggerire come il pathfinder, “il pioniere” (Pagetti, 1998) reinterpretato dalla contemporaneità, il quale rielabora il mito della frontiera riscrivendolo sullo spazio cosmico, sia proteso a contaminarsi sempre più inscindibilmente con la macchina, Manfred-cyborg, metamorfizzato infine in un ibrido chimerico, nel convertire il futuro nel proprio passato, sembra voler indurre a riflettere su quanto appaia rilevante il binomio naturale-artificiale nell’elaborazione critica delle categorie mediante cui è possibile intendere le operazioni di funzionamento del tempo.
Un interrogativo ricorrente e inaggirabile, che, larvatus, attraversa sottotraccia Noi Marziani, riguarda il destino di parte dell’universo come civilizzazione interplanetaria unificata dalla tecnica e determinata dalla forma che vi assume proprio la contaminazione di organico e inorganico: tra la condizione di finitudine della materia, attanagliata dalla morsa entropica, e l’eternità immateriale dell’informazione estropica affiorano le realtà aliene che popolano la schizofrenica e gubblish notte dickiana su Marte, svincolate dagli orizzonti spazio-temporali del logos umano, distaccate dal fluire di una vita, meramente biologica, dispersa nell’ineluttabilità del proprio destino, nonché rivelatrici delle sempre nuove cibernetiche configurazioni di un inedito essere e dei sempre più inquietanti risvolti di inusitate verità.
- Ludwig Binswanger, Il caso Suzanne Urban. Storia di una schizofrenia, Marsilio, Venezia, 1994.
- Emmanuel Carrère, Io sono vivo, voi siete morti, Adelphi, Milano, 2016.
- Philip K. Dick, Mutazioni. Scritti inediti, filosofici, autobiografici e letterari, Feltrinelli, Milano, 1997.
- Philip K. Dick, Le presenze invisibili, Vol. 3, Mondadori, Milano, 1998.
- Philip K. Dick, Ma gli androidi sognano pecore elettriche?, Fanucci, Roma, 2000.
- Philip K. Dick, Cronache del dopobomba, Fanucci, Roma, 2006.
- Philip K. Dick, Noi Marziani, Fanucci, Roma, 2016.
- Gabriele Frasca, Non vale far paura, 1989, in Gianfranco Viviani, Carlo Pagetti (a cura di), cit.
- Gabriele Frasca, L’oscuro scrutare di Philip K. Dick, Meltemi, Milano, 2007.
- Carl Gustav Jung, Gli archetipi dell’inconscio collettivo, Bollati Boringhieri, Torino, 1977.
- Carl Gustav Jung, Civiltà in transizione: dopo la catastrofe, Bollati Boringhieri, Torino, 1998.
- Eric J. Hobsbawm, Il secolo breve. 1914-1994: l’era dei grandi cataclismi, Rizzoli, Milano, 1995.
- Carlo Pagetti, Dick verso la metafantascienza, 1989, in Gianfranco Viviani, Carlo Pagetti (a cura di), Philip K. Dick. Il sogno dei simulacri, cit.
- Carlo Pagetti, Il lungo viaggio attraverso la notte marziana, in Philip K Dick., Noi Marziani, Fanucci, Roma, 1998.
- Bruno Vaccari, L’allucinazione come mezzo conoscitivo, 1989, in Gianfranco Viviani, Carlo Pagetti (a cura di), cit.
- Gianfranco Viviani, Carlo Pagetti (a cura di), Philip K. Dick. Il sogno dei simulacri, Editrice Nord, Milano, 1989.