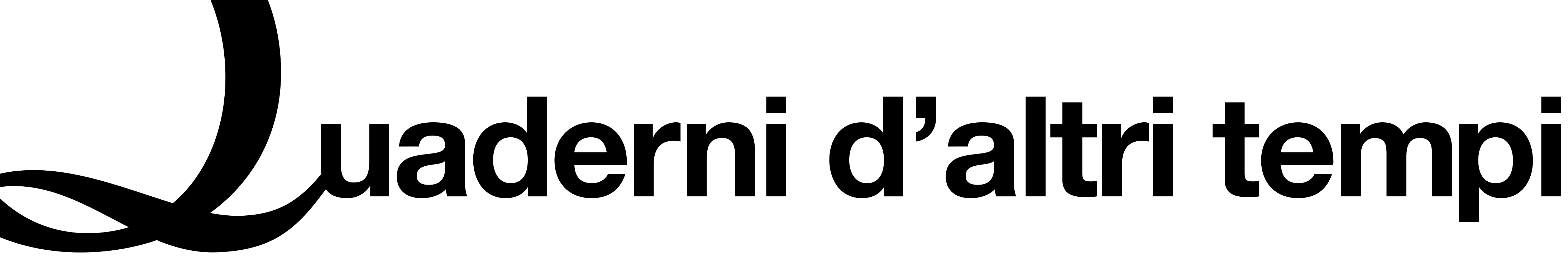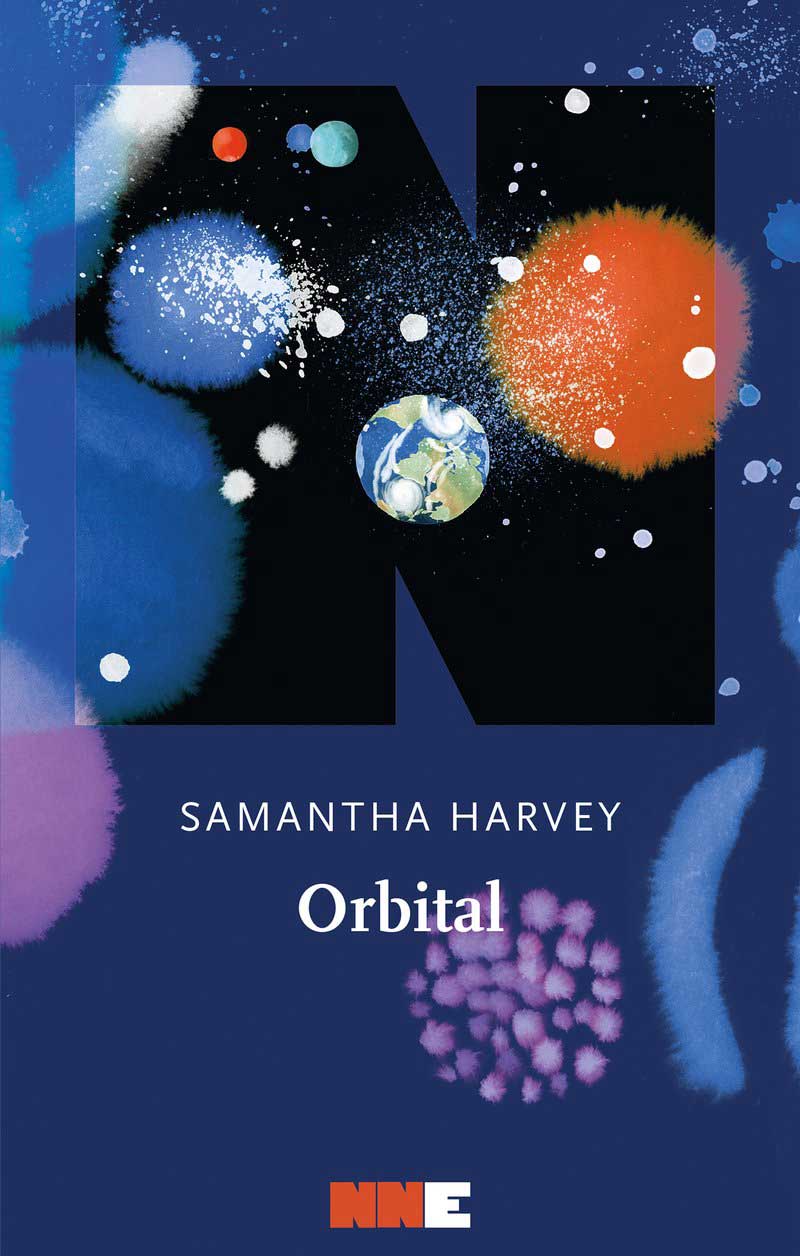Nel 2024 i cinque giurati del Booker Prize decidono di assegnare il prestigioso premio a Orbital, di Samantha Harvey. Si tratta di un romanzo breve, e questa particolarità viene – non a caso – sottolineata sul sito del premio stesso. La critica è unanime nel sottolineare il valore dell’opera, e il romanzo è anche un successo di vendite, già prima dell’assegnazione del premio. Harvey racconta la storia di sei astronauti di diverse nazionalità e della loro vita a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. La narrazione si svolge nell’arco di una giornata, seguendo le attività degli astronauti mentre osservano la Terra dall’alto e riflettono sulle loro vite e sul nostro pianeta. Orbital, racconta Harvey, è stato scritto durante il lockdown, frutto inquietante e doloroso della sua insonnia cronica, che la accompagna da lungo tempo e di cui già soffriva durante la pandemia. Chiusa in casa per la quarantena, aveva come desktop del computer la trasmissione in diretta dalle telecamere della SSI. Davanti ai suoi occhi si svolgeva ininterrottamente la rotazione della Terra, per cui le si ripresentavano periodicamente alla vista paesi, nazioni e continenti, che poteva ammirare insieme agli astronauti. Questa genesi nel terreno dell’insonnia non è un dettaglio marginale ma una rilevante chiave interpretativa.

L’esperienza personale dell’autrice – quel senso di caduta senza fine, quella dimensione liminale tra veglia e sonno – si rispecchia perfettamente nella condizione degli astronauti sospesi in un perpetuo stato di galleggiamento. Come l’insonne che vede scorrere le ore senza potersi abbandonare all’oblio del sonno, così gli astronauti osservano il continuo avvicendarsi di territori terrestri senza poter mai toccare o partecipare a ciò che vedono. Questa sostanziale impotenza osservativa accomuna l’esperienza dell’insonnia a quella dell’orbita. Lo scorrere inarrestabile del tempo è perciò una delle due colonne su cui si fonda la struttura del romanzo. Per questo la sua brevità è un elemento rilevante. Non è necessario riproporre più volte gli stessi concetti in forma differente. Ciò che accade nella SSI e in cui Harvey ci coinvolge non è un momento narrativo, non si ha una trama – l’autrice non scrive un racconto: sulla pagina troviamo solo la visione della quotidianità, la rappresentazione in scala estremamente ridotta dove un giorno vale per l’eternità. La circolarità diventa così non solo un tema centrale del romanzo ma il suo principio strutturale organizzativo. Come l’orbita della stazione spaziale è un eterno ritorno senza progressione reale, così la narrazione si avvolge su sé stessa. Questa struttura circolare si contrappone deliberatamente alla narrazione lineare e progressiva tipica del romanzo occidentale, con il suo movimento verso un climax e una risoluzione. In Orbital il tempo non avanza verso un obiettivo, ma ruota eternamente, creando un effetto di straniamento che riflette l’esperienza degli astronauti stessi.
Quattro uomini e due donne
Sono sei gli astronauti: Anton, Roman, Nell, Chie, Shaun e Pietro – due russi, una inglese, un italiano, una giapponese e un americano. Ognuno di loro ha un passato, una storia, una famiglia. Improvvisamente, Chie, l’astronauta giapponese, viene informata della morte della madre. Questo evento luttuoso è forse l’unica anomalia rispetto alla quotidiana ripetizione di manualità e di esperimenti. L’improvvisa emergenza della morte e del lutto mostra quanto la vita sulla stazione sia solo una riproduzione in scala ridotta del dramma quotidiano della vita sul pianeta. Chie deve affrontare il lutto della perdita della madre mentre si trova sulla stazione spaziale, impossibilitata quindi a partecipare al funerale. La famiglia le propone di rimandare la cerimonia fino al suo ritorno, ma lei rifiuta. Non è necessario. Il lutto di Chie rappresenta la più potente irruzione della linearità temporale terrestre nell’eternità circolare dello spazio.
“Da quando Chie è arrivata in cucina venerdì sera mentre preparavano la cena, il viso terreo, e ha detto: È morta mia madre. […] Da quel momento, si ritrovano a guardare la Terra mentre le girano intorno (sembra un vagabondare, ma non potrebbe essere più falso), e c’è quella parola: madre madre madre madre. Ora l’unica madre di Chie è quella sfera rotante e luminosa che si lancia involontariamente intorno al Sole una volta l’anno”.
La morte è l’evento lineare per eccellenza, il marcatore definitivo del passaggio del tempo che non può essere reintegrato in alcun ciclo. E proprio per questo diventa così problematico da elaborare nello spazio, dove tutto è costruito intorno alla negazione di questa linearità. Lo stato d’animo di Chie non è pertanto solo il risultato del dolore personale, ma anche della fondamentale incompatibilità tra l’esperienza umana della mortalità e l’ambiente artificiale dello spazio, che simula un’eternità meccanica. Lei, come tutti i suoi compagni, seppur ognuno secondo la propria disposizione d’animo, vive l’angoscia che nasce dal gap esistente tra i ricordi dei loro sogni da bambini, le ambizioni di una vita finalizzata a un obiettivo, e la realtà di una quotidiana, noiosa routine. Harvey esplora l’esperienza del dolore nello spazio, un ambiente già di per sé alienante. L’esperienza del lutto di Chie viene amplificata dall’isolamento fisico estremo e dalla prospettiva unica di osservare la Terra – dove sua madre non c’è più – da lontano. Questo crea un distacco sia fisico che psicologico che intensifica il suo trauma. C’è un contrasto straziante tra l’idealismo infantile e il sogno romantico dello spazio, le ambizioni professionali che li hanno portati fino a quel punto e la realtà quotidiana fatta di routine, manutenzione, piccoli compiti ripetitivi. Questo contrasto emerge nel confronto con i colleghi che vanno sulla Luna. Loro sono andati ancora un passo oltre, non sono più legati – o almeno questa è l’illusione – alla ripetitiva quotidianità dell’orbita. I sei astronauti pur trovandosi nel luogo più straordinario immaginabile, sperimentano noia, alienazione e un senso di vuoto. Questa disconnessione tra l’eccezionalità della loro posizione e la mondanità della loro esperienza crea una profonda crisi esistenziale. È particolarmente potente il modo in cui il romanzo esplora come questi individui, addestrati per essere razionali e metodici, affrontino emozioni profondamente umane e disordinate come il lutto, la nostalgia e la disillusione in un ambiente così innaturale.
Il pianeta azzurro
Gli eventi accadono sullo sfondo dell’unico pianeta che abitiamo, mentre intorno risuona la sinfonia delle stelle e dei più variegati corpi celesti. La visione della Terra dallo spazio, anziché offrire consolazione o prospettiva, sembra accentuare però il senso di alienazione in alcuni dei personaggi. È come se quell’overview effect tanto celebrato si rivelasse un’arma a doppio taglio. La prospettiva privilegiata degli astronauti si trasforma così da benedizione a maledizione. L’overview effect, descritto da numerosi astronauti reali come un’esperienza di profonda connessione cosmica e comprensione della fragilità terrestre, viene qui sovvertito da Harvey. Vedere tutto non significa necessariamente comprendere tutto, e l’apparente oggettività della visione globale paradossalmente intensifica la soggettività del dolore e dell’alienazione. In questo, Harvey si affianca a scrittori come Stanisław Lem in Solaris, dove la presunta oggettività scientifica dell’osservazione si scontra con l’inconoscibilità fondamentale dell’altro, sia esso un pianeta alieno o la propria psiche. Come gli scienziati di Lem non riescono mai a comprendere veramente il pianeta Solaris nonostante lo scrutino con ogni strumento possibile, così gli astronauti di Harvey non riescono a trovare conforto nella loro visione privilegiata della Terra. Harvey descrive continuamente i luoghi che transitano sotto la SSI: città, laghi, fiumi, mari, oceani, montagne, anche il tifone che seguono in dettaglio, tutti elementi di quella sorta di sublime ma inconoscibile visione che è il pianeta dallo spazio.
“il tifone che si sta muovendo sul Pacifico occidentale verso l’Indonesia e le Filippine all’improvviso sembra aumentare di intensità. Non è ancora visibile sulla loro traiettoria attuale, ma tra un paio di orbite si sarà spostato verso ovest e l’avrà raggiunta”.
Questo continuo rimando tra vita privata, interiorità e viaggio spaziale permette un collegamento con Interstellar, il film di Christopher Nolan. Anche in quel caso la problematica cruciale, quella che emotivamente connette i personaggi, non è la visione del futuro, la prospettiva della nuova frontiera nello spazio, quanto quella familiare, nella relazione padre – figlia, il fil rouge che lega ogni cosa, attraverso ogni forma dello spazio-tempo. Orbital, così come il film di Nolan, vuole esplicitamente far convivere questa tensione tra l’infinitamente grande (l’esplorazione spaziale) e l’infinitamente intimo (le relazioni familiari). Harvey però ha un tono più malinconico. Nel caso di Chie, la relazione madre-figlia diventa ancora più complessa perché il lutto viene vissuto a distanza, con l’impossibilità fisica di partecipare ai rituali di addio terreni. Tutto ciò che riguarda la vita, anche la sua negazione, avviene sul pianeta, non può essere altrove: la Terra è il luogo della vita e proprio per questo è anche il luogo della morte. La Terra è la realtà della finitudine, mentre la SSI è il velo dell’eterna ciclicità. Gli astronauti non vorrebbero mai tornare, ammettono tra di loro, ambiscono all’eterna cristallizzazione delle orbite gelide.
Dissonanza evolutiva
Il nostro sistema nervoso, il nostro cervello, è il frutto di una evoluzione avvenuta qui, sul pianeta terra. Nel momento in cui ce ne dovessimo allontanare non avremmo quel tempo che la biologia richiede per adeguarci a un nuovo ambiente. Questa dissonanza evolutiva è al centro di Orbital così come di molta letteratura sull’esplorazione spaziale. Il nostro corpo e la nostra mente si sono evoluti in stretta simbiosi con la Terra – la sua gravità, i suoi cicli di luce e buio, i suoi orizzonti, persino il comportamento sociale che abbiamo sviluppato è calibrato per questo ambiente specifico. Quando ci allontaniamo, come fanno gli astronauti di Harvey, portiamo con noi queste strutture biologiche e psicologiche che improvvisamente si trovano in un contesto completamente alieno. Ed è qui che i topolini assurgono a un ruolo simbolico molto più profondo di quanto possa sembrare. La loro capacità di adattarsi, anzi, di prosperare nell’assenza di gravità, imparando a volare con evidente euforia, crea un contrasto drammatico con gli umani. Gli esseri meno complessi, meno evoluti, mostrano paradossalmente una maggiore plasticità adattiva. Non appesantiti dal senso del sé, dalla nostalgia, dalla coscienza della morte, i topolini possono abbracciare pienamente il nuovo ambiente. Questa immagine rovescia la consueta narrazione del progresso evolutivo umano come trionfo adattivo. In Orbital, sono proprio le caratteristiche più avanzate dell’esperienza umana – la coscienza riflessiva, la memoria autobiografica, il senso del tempo – a rivelarsi ostacoli insormontabili per un vero adattamento allo spazio.
“Quando Chie va a controllare i topi, come fa ogni sera, vede sul monitor che è successo un miracolo: volano in cerchio. Ci hanno messo una settimana ma hanno abbandonato le sbarre della loro gabbia e imparato a gestire la microgravità”.
I topolini che giocano in assenza di gravità diventano così non solo un esperimento scientifico ma una potente metafora della possibilità di una forma di vita post-umana, l’unica forse capace di trovare vera gioia al di là dell’atmosfera terrestre. Orbital descrive questo trauma evolutivo. Gli astronauti possono razionalmente comprendere dove si trovano, ma i loro corpi e le loro menti profonde non sono equipaggiati per elaborare veramente l’esperienza. Questo crea una frattura esistenziale che si manifesta come angoscia. La stazione spaziale diventa così una sorta di limbo esistenziale – né completamente separata dalla Terra che gli astronauti possono osservare costantemente, né parte di essa. Questa posizione liminale amplifica il senso di sradicamento e disagio che già sperimenterebbero sulla Terra. Portare l’umano fuori dal suo contesto evolutivo non rivela solo i limiti della nostra adattabilità fisica, ma espone anche le vulnerabilità più profonde della nostra psiche, e questo viene costantemente rimosso.
Las Meninas: il gioco di specchi
Shaun, quando era un quindicenne che già desiderava diventare un pilota, assiste a una lezione di storia dell’arte a proposito del celeberrimo quadro di Velasquez, Las Meninas. Probabilmente se ne sarebbe completamente dimenticato se non fosse che in quell’occasione conosce la ragazza che sarebbe diventata sua moglie, e da allora il quadro è diventato per la coppia una sorta di continuo tavolo da gioco, su cui si confrontano e discutono le relative interpretazioni. Il riferimento a Las Meninas non è casuale e si rivela una delle metafore strutturali più potenti del romanzo. Il quadro di Velázquez è celebre per la sua complessità autoreferenziale: mostra il pittore stesso nell’atto di dipingere una tela che non vediamo, mentre osserva qualcosa o qualcuno fuori dal quadro (presumibilmente i reali di Spagna, che appaiono riflessi in uno specchio sullo sfondo). Questo gioco di sguardi e prospettive crea una vertiginosa ambiguità: chi sta osservando chi? Chi è il soggetto e chi l’oggetto dello sguardo?
“… il re e la regina […], la loro figlia […], le sue damigelle […], l’uomo dall’aria furtiva che sembra portare un messaggio e si intravede in fondo, sulla porta, Velázquez […], o siamo noi, gli spettatori, che occupiamo la stessa posizione del re e della regina, che guardiamo dentro e che siamo guardati sia da Velázquez sia dalla principessa bambina e, di riflesso, dal re e dalla regina? O il soggetto è l’arte stessa […] o la vita? Oppure – aveva detto l’insegnante – è solo un dipinto sul nulla? Soltanto una stanza con dentro della gente e uno specchio?”
In modo analogo, Orbital sovverte continuamente la relazione tra osservatore e osservato. Gli astronauti guardano la Terra, ma allo stesso tempo sono consapevoli di essere osservati dalla Terra e dai suoi abitanti. La Terra stessa diventa un occhio che li scruta, trasformandoli da soggetti osservanti in oggetti osservati. Questa inversione continua della prospettiva ricrea precisamente la vertigine di Las Meninas, dove non è mai chiaro quale sia il punto di vista privilegiato. Shaun ha portato sulla SSI una cartolina raffigurante il quadro, dove la moglie ha scritto tutte le sue possibili interpretazioni. Per lui si tratta di un evidente oggetto transazionale, del cordone ombelicale che lo lega a lei, e di conseguenza al pianeta, ma il gioco di specchi continuo è anche una metafora del ruolo che i sei astronauti svolgono in orbita, senza avere chiaro chi è il pittore, chi è il soggetto e chi invece i personaggi di contorno. Così, come Velázquez si ritrae nell’atto stesso della creazione, Harvey costruisce un romanzo che riflette costantemente sulla propria natura artificiale. La stazione spaziale, costruzione umana che orbita intorno alla Terra, diventa metafora del romanzo stesso, costruzione linguistica che orbita intorno all’esperienza umana senza mai poterla catturare completamente. Vi è una serie di elementi, rilasciati nel corso del romanzo, che compongono una sorta di orizzonte interpretativo del legame multiplo e condiviso che i sei in quanto unità hanno con il pianeta. E così il lutto che colpisce Chie, il quadro a cui pensa Shaun, i pescatori filippini colpiti dal tifone di cui si preoccupa Pietro, i topolini che imparano a volare, la fine del matrimonio di Roman, sono tutti tasselli di una visione unitaria del cosmo. Il gruppo di astronauti parla di sé come della famiglia per aria, c’è una unità che li lega e li rende alieni, la stazione stessa è vista come corpo, in un processo di completa decostruzione dell’ego.
Una solitudine tragica e crudele
Il vissuto degli astronauti sulla SSI è una angosciosa catabasi in cui ognuno trasferisce nello spazio i propri drammi personali, e la visione dell’immensa bellezza dell’universo non annulla il dolore, anzi, l’indifferenza del tutto rende il proprio incubo personale ancora più invivibile, ed è per questo che, come antichi primati, i sei astronauti si riuniscono in una piccola tribù, cercando di proteggersi a vicenda. Questo rovesciamento della tradizionale narrativa dell’esplorazione spaziale come trionfo della tecnologia e dell’ingegno umano ci potrebbe indurre a posizionare Orbital in una particolare tradizione letteraria che potremmo chiamare space fiction esistenziale. A differenza della fantascienza classica che celebra la conquista dello spazio, opere come Solaris di Lem o Aurora di Kim Stanley Robinson esplorano lo spazio come luogo di confronto con i limiti della condizione umana. In Orbital, Harvey si inserisce in questa tradizione ma con un’attenzione particolare al quotidiano, al minuscolo, all’apparentemente banale. Non sono gli incontri con civiltà aliene o le grandi scoperte scientifiche a definire l’esperienza spaziale, ma il modo in cui la cura dei topolini, la preparazione dei pasti, o l’osservazione di un tifone diventano esperienze cariche di significato esistenziale.
“Hanno le mani infilate in contenitori sigillati per esperimenti oppure impegnate a montare o smontare unità ammortizzate o a riempire il distributore automatico di cibo per i topi, i piedi sono fissati alle postazioni di lavoro, con i cacciaviti, le chiavi inglesi, le forbici e le matite che fluttuano sopra le loro teste e le spalle, un paio di pinzette si stacca e naviga verso i condotti di ventilazione e il loro impercettibile risucchio, dove vanno ad arenarsi tutti gli oggetti smarriti”.
Questa attenzione al microcosmo all’interno del macrocosmo rappresenta una delle maggiori innovazioni di Harvey nel panorama della letteratura spaziale. Laddove molte opere di fantascienza tendono a focalizzarsi sull’enormità dello spazio per ridimensionare le preoccupazioni umane, Orbital fa il contrario: utilizza la vastità dello spazio come sfondo per amplificare l’intensità dell’esperienza umana più intima e quotidiana.
La Terra come unica casa possibile
Ciò che emerge con forza da Orbital è una riflessione profonda sui limiti dell’adattabilità umana e sulla nostra inscindibile connessione con il pianeta che ci ha generati. Nonostante tutta la nostra tecnologia e i nostri sogni di conquista spaziale, il romanzo suggerisce che potremmo essere fondamentalmente incapaci di trascendere la nostra terrestrità. Questa conclusione non appare però come un fallimento, ma come un invito a riconsiderare il nostro rapporto con la Terra. Se non possiamo veramente fuggire da questo pianeta – non solo fisicamente, ma soprattutto psicologicamente – allora forse dovremmo concentrarci maggiormente su come abitarlo in modo più armonioso. La brevità stessa del romanzo diventa così un elemento di significato: in un’epoca di narrazioni inflazionate e interminabili, Harvey ci ricorda che ciò che conta davvero può essere espresso in poco spazio, così come il pianeta stesso, visto dallo spazio, appare come un fragile punto blu nell’immensità del cosmo. Orbital è dunque molto più di un romanzo sull’esplorazione spaziale: è una meditazione sulla condizione umana, sui limiti della nostra capacità di adattamento, sulla natura circolare del tempo e dell’esperienza, e sulla fondamentale inseparabilità tra noi e il pianeta che chiamiamo casa. Se c’è una speranza, suggerisce Harvey, non si trova nell’oltrepassare la nostra condizione terrestre, ma nell’abbracciarla pienamente, con tutte le sue contraddizioni e la sua bellezza fragile.
- Stanislaw Lem, Solaris, Sellerio, Palermo, 2013.
- Kim Stanley Robinson, Aurora, Ubiliber, Milano, 2024.