“Sarò degno?”, ovvero, dell’incertezza di riuscire a percorrere un cerchio nella sua interezza, una volta intrapreso il cammino. Perché è con questo interrogativo che si apre il romanzo-saggio Il pantarèi di Ezio Sinigaglia, riproposto per i tipi di TerraRossa Edizioni dopo la prima pubblicazione risalente al 1985 per SPS. Contributo che non snatura l’edizione di più di trent’anni fa, piuttosto ritorna alla memoria e alla fatica di quell’arcana esplorazione del romanzo e della sua sopravvivenza, oggi come sempre.
Un interrogarsi, sul romanzo e sulla possibilità di parlarne, che brulica di doppi, tripli, multipli dubbi, nella prospettiva incalzante di percorrere tutti i punti di un cerchio senza perdersi tra crepe e rimbalzi. Prospettiva che sa di luce, se il protagonista del romanzo la illumina nel presagio del suo cognome germanico, Stern, Stella. Quando l’angolo di osservazione è luce anche di notte, senza ammetterlo o forse anche senza saperlo.
Ottobre, Anna fuggita da quel Perry Mason di Franco, trent’anni, Clark da scapolo marrone scuro quarantadue, mezzo milione in cinque giorni per la compilazione di quaranta pagine tassative sul romanzo del Novecento, sezione “Enciclopedia delle donne”, dottoressa Ghiotti, terzo piano a sinistra, la scaletta da seguire nelle parole a venire e una Olivetti dietro il cui ticchettio affannarsi.
Negli spazi bianchi, l’indugio o la partenza della domanda iniziale, per percorrere la pista parallela di un lavoro editoriale da consegnare e di un amore da dimenticare. Geometria perfetta di incroci tra destrutturazione e ristrutturazione, tanto del protagonista quanto della materia di cui si occupa. Certo, tra saliscendi vari, forse vale la pena almeno semplificarsi un po’ la vita con una scala in meno, la scaletta della redattrice Ghiotti. Imposizione, o impostura, di allineare un nome dietro l’altro nell’esperienza sinuosa del romanzo novecentesco. E no, la scaletta è fuori scala. Via Thomas Mann, dentro Louis-Ferdinand Céline. Dove comanda il cuore. O le sue intermittenze, direbbe il buon Marcel Proust.

E, non a caso, è da lui che Stern intende partire nella sua avventura editoriale. I tasti della Olivetti si cimentano nell’evocare l’invisibile e persistente profumo dei lillà, rinnovato dal protagonista nel tempo della memoria. Le madeleine? No, Stern preferisce i lillà, perché anch’essi parte “della realtà composita e varia dell’universo proustiano, affollato di persone e cose, di desideri e amori e sensazioni fuggenti, universo evocato, affiorante con straordinario rilievo da quello che banalmente chiameremmo passato, ma che invece è realtà vivente e operante nella coscienza”.
Le intermittenze, non una concatenazione logico-cronologica, fanno da impulso alla trama proustiana. Un risveglio involontario della memoria nell’incontro con i segni del reale, tale da riattualizzare il passato e concedergli il privilegio di una verità intemporale. Così, la ricerca del romanzo proustiano si vivifica di una dimensione nuova, quella interiore, che rende ritrovato il tempo perduto.
Insomma, la tradizione non ce ne voglia, nel Novecento abbiamo finalmente scoperto la trascendenza emotiva. Oltre il ritmo prevedibile di fatti, spazi, luoghi
“il mondo che interessa è quello che sta nel retroscena del visibile: di quel visibile che la narrativa precedente si è preoccupata solo di inventariare” (Debenedetti, 1975).
Fermi tutti! E le panoramiche congetture su realismo (cfr. Auerbach, 2000), cronotopo (cfr. Bachtin, 2001) o qualsivoglia sovrastruttura teorica sia stata ispirata dalla precedente narrativa? Confidassero in un propizio “tutto torna”, per ora la nuova proporzione del raccontarsi ha rifiutato l’edizione-base. Ma torniamo a Stern. Il dopo Proust per lui obbedisce proprio alla legge della memoria. Ha la nitida fattezza di un ricordo da scacciare. “Castiga la memoria, frùstala, dómala”, si ripete il protagonista, però il passato esibisce la sera del 12 maggio, il giorno dell’abbandono. Anna sul divano, una tapparella giù, l’incompiuto amarsi incollato a un addio, l’inspiegabile rito della valigia, qualcosa tirato dentro a singhiozzi, l’essenziale dimenticato nei cassetti, un implicito arrivederci per chi rimane, il silenzio dietro una porta sbattuta. Poi, la memoria ritrovata su una panchina del parco, così simile a quella su cui Stern sedeva la notte del 12 maggio.
Maledetto Proust e il passato che non muore! Non resta che confessare ad Anna, in una lettera forse mai scritta, di essere rientrato, quella stessa notte, nella loro camera disfatta, ma stavolta con Michele. Su una panchina del parco, l’incontro fortuito di un amore con il nome al maschile. Bando ai ricordi, tocca ripartire nell’impresa solitaria della scrittura, la versione rapida dei sentimenti passa per il rullo veloce dell’Olivetti. Stavolta Stern scrive Joyce. Stream of consciousness. Ovvia conseguenza.
Il romanzo del secolo decimonono sta lì a tirarsi dietro un altro punto cardine del passato. Salutate, lettori di tutto il globo, l’onnisciente Manzoni, oggi ci caliamo nella coscienza di un personaggio e ne ascoltiamo le voci in rincorsa. Niente panico se vi manca qualche punto, virgola, due punti, o un prima e dopo. Focalizzazione interna significa prospettiva relativa, ombre inconsce ad aspettarci e un linguaggio acrobatico tutto per loro. Povero Stern, mentre ne trova una definizione, è già tutto un flusso di coscienza inarginabile. Che sia colpa di Sigmund Freud, nemmeno vale chiederselo. Stern si sente un ribollire di neologismi, etimi, onomatopee, ossimori, sillabe in improbabili crasi, fino ad arrestarsi sulla soglia di un insolito vaticino:
“Nullamore sternarsi nottitudine teterrima nerotonante fuor del pantarèi”.
A quel rapidissimo istante di metamorfosi, che Eraclito definiva “panta rei”, Stern ha la precisa intuizione di potervi sfuggire. Lui, di nullamore ormai capace, sente di essere ruotante nella solitudine teterrima della sua notte. Alla logica del fluire, percepisce la sua resistenza. Uno squarcio di universo, appena dopo il più noto “orizzonte degli eventi”, dove non vaga né tempo né spazio né slancio di luce. Un buco nero, senza amore.
Il mezzogiorno successivo a questo immemore smarrirsi, ci suggerisce uno Stern diretto nuovamente alla polifonica ricostruzione della tradizione narrativa. Un buco nero, sì, ma con un contratto da rispettare.
È la volta di Robert Musil. Con lui la demolizione della tradizione passa soprattutto per l’eroe. L’uomo senza qualità è Musil a presentarcelo, nella speciale accezione del disimpegnato organizzato. Erede degli eroi del passato, proiettati verso ruoli realizzabili, l’uomo senza qualità, Ulrich, si aggira senza variazioni tra amore, lavoro, ideologia, vita, aperto a tutte le possibilità del reale, ma mai affine a una sola delle stesse. Un romanzo che vede come referente un tale protagonista, ha una sola opzione di finale prevedibile: un non finale.
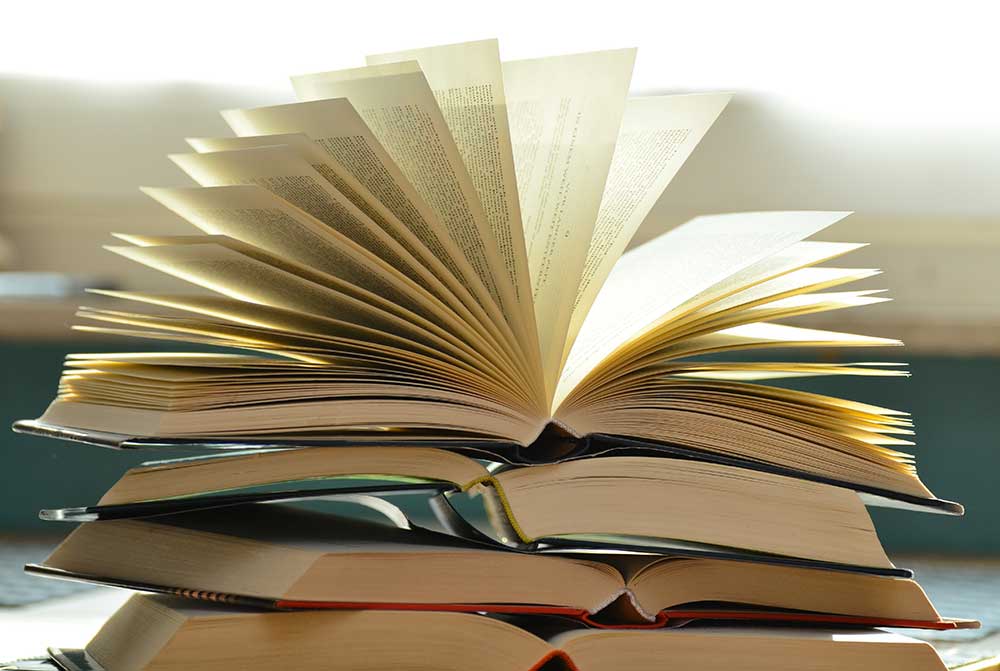
Il foglio si srotola dietro l’ultimo tac di battitura e Stern rivede in Ulrich quel qualcosa di sé, per così dire, sospeso. Tra dilazioni e attese, non resta che decidersi almeno ora al passo di una scelta. Presentarsi da Anna. Assumere una posizione, quella che conta. Ed è qui, esattamente a metà romanzo, che l’identità tra Stern e la materia di cui si trova a scrivere si fa più trasparente. Stern, dentro e accanto al romanzo novecentesco, sta ricercando semplicemente un nuovo sé rispetto all’ieri.
Questo nuovo sé ha, tuttavia, da redimersi non solo dal fallimento di Anna ma anche dalla ritrosia di un altro amore a metà, quello per un romanzo tutto suo, che serbi il coraggio di un contributo alla vita. Proiezione troppo pretenziosa per chi si sente buco nero. A meno di non ricorrere ancora al soccorso di scritti altrui. Italo Svevo gli strizza l’occhio e Stern è pronto per una nuova pagina o una nuova maschera, che dir si voglia.
Sì, perché, in una sorta di psicodramma, a prestarsi a un raffronto con Stern è proprio l’anti-eroe di Svevo, l’uomo la cui coscienza si fa voce per rivendicare la paura o l’orgoglio di una propria autenticità. Complice di questa esplorazione del sé è la scrittura, con la sua “funzione terapeutica e insieme redentrice: quella di restituire un senso e un valore all’esistenza […] Perché cercarsi significa essere vivi”.
Dalla terza persona alla prima, il passo è di pochi centimetri. Stern non è più un lui, ma un io in forma di diario.
“Anna mi ha lasciato cinque mesi fa, il 12 maggio. Solo oggi ho raggiunto dentro di me la certezza di averla perduta […] Non so dire quando ho cominciato a nuotare verso la superfice […] Non so, dunque, dove collocare il turning point: ma qualcosa mi induce a metterlo in relazione (casuale o causale?) con il lavoro sul romanzo”.
Che fare? Limitarsi a compendiare l’audacia di altri o appartenere al loro stesso coraggio e votarsi al rischio di una metempsicosi da buco nero ad astro? Forse vale la pena tentarlo, questo romanzo. Che sia il proprio stavolta. Così, in un rapido crescendo, Sinigaglia trasforma la lotta contro il tutto possibile dei personaggi kafkiani, lotta tanto più schiacciante quanto più consacrata all’umiliazione, nei deliri dello stesso Stern, nelle linee temporali accavallate, nei gorghi dell’assurdo, nell’avida prepotenza di simboli indecifrabili, nel groviglio di piani tra visibile e invisibile. Sembrerebbe una retromarcia, invece, quella tensione esplode in un “vorrei scriverlo io un romanzo, ma non so proprio da dove cominciare”. Da dove? Dal filtro allucinatorio con cui Céline trasfigura la forma del romanzo?
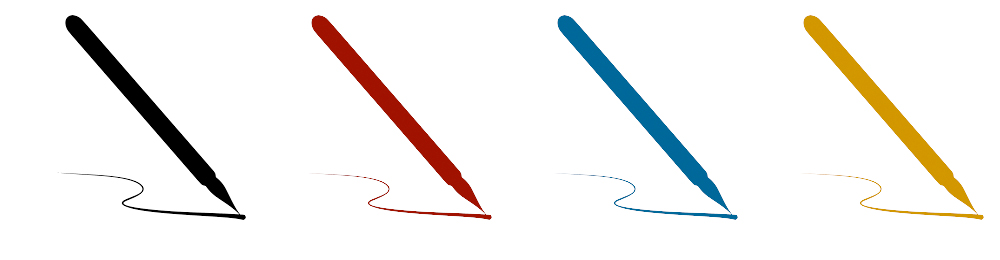
Dall’inferno che William Faulkner disigilla dietro gli angoli della dannazione? Dall’ansiosa negazione di tutta l’architettura narrativa, personaggi, vicende, sentimenti, cronotopi, eventualità, alla maniera di Alain Robbe-Grillet? Forse, il margine di errore nella previsione si riduce solo nell’associare Stern a un finale proseguibile, nella vita dei sentimenti come della scrittura. Eppure, questo finale basta a dirci quanto ci aspettavamo.
Audaci narratori dei tempi nuovi, vi è concessa la liberatoria: lunga vita al romanzo e ai suoi capricci! Lunga vita all’astro nascente di Stern! Il romanzo non è morto. Merita piuttosto ali nuove. Ed è proprio qui che si coglie la necessità di una riproposta del romanzo-saggio di Sinigaglia dopo oltre trent’anni.
“Vivere è questo. Ma quando si racconta la vita, tutto cambia. Solo che è un cambiamento che nessuno nota: la prova è che si parla di storie vere. Come se potessero esserci storie vere: gli eventi si svolgono in un modo e noi li raccontiamo in modo inverso” (Sartre, 2014).
Allora, il romanzo, per avere un senso oggi, deve prendere non la forma di una rassicurante risposta sottintesa nel racconto della vita, bensì di una problematica domanda dietro cui interpretarla. Non a caso, Eclissi dello stesso Sinigaglia, datato 2016, è romanzo che prende corpo tutt’intorno a una domanda taciuta e affidata, anche qui, a un segnale del sistema astronomico, l’eclissi. “Una domanda che forse si nascondeva dietro il disco nero della luna”.
Romanzo di domande più che di risposte è la responsabilità narrativa dei nuovi tempi. È il ritorno possibile del romanzo al pantarèi e sotto una nuova stella. È il “sarò degno?” preliminare in un cerchio che si chiude.
- Erich Auerbach, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, Einaudi, Torino, 2000.
- Michail Bachtin, Estetica e romanzo, Einaudi, Torino, 2001.
- Giacomo Debenedetti, Il romanzo del Novecento, Garzanti, Milano, 1975.
- Jean-Paul Sartre, La nausea, Einaudi, Torino, 2014.
- Ezio Sinigaglia, Eclissi, Nutrimenti, Roma, 2016.

