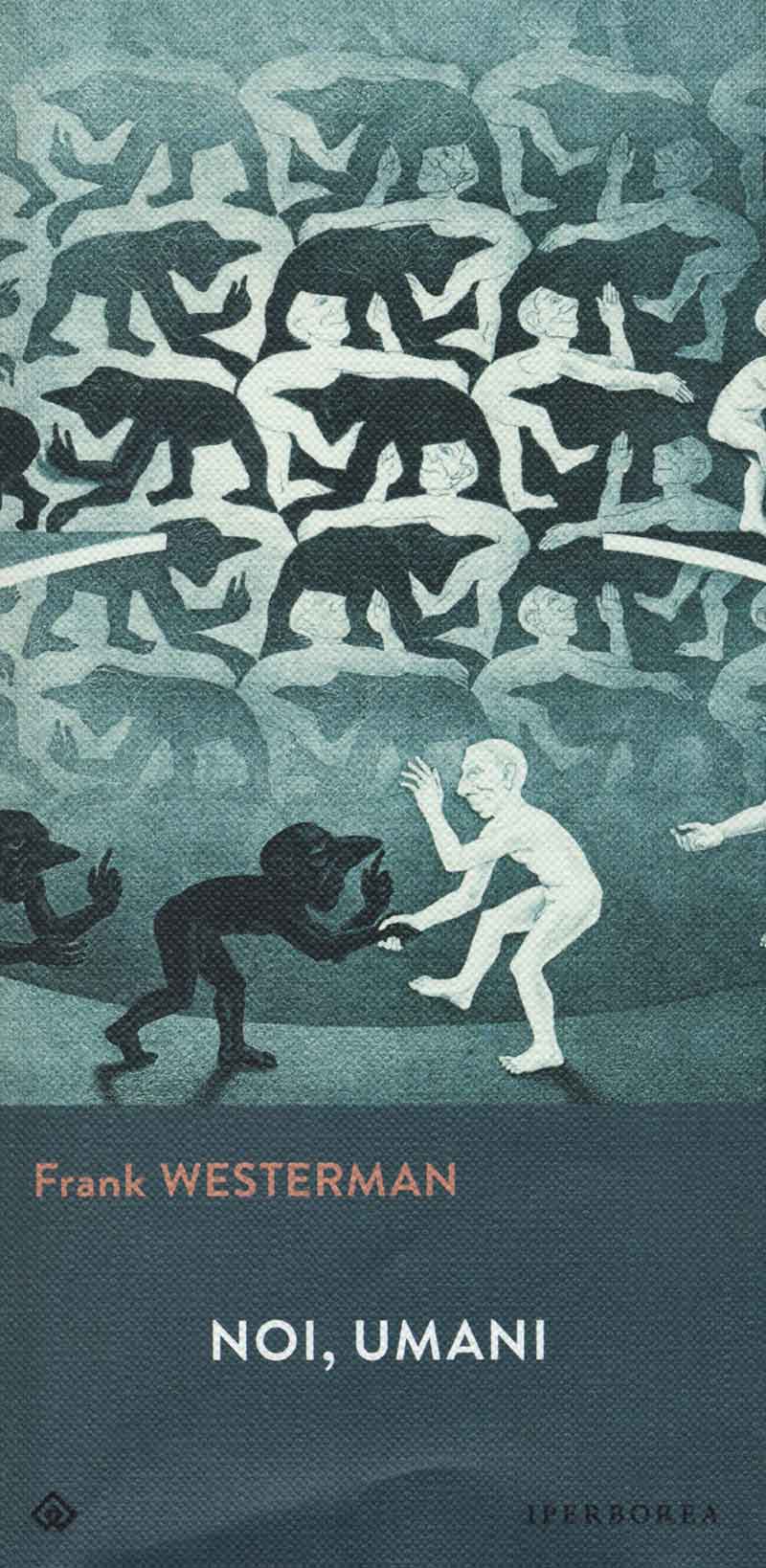La riflessione sulla storiografia e sulla metodologia della ricerca storica ha origini lontane, radicate nella Grecia classica. Erodoto, Tucidide, Polibio e Tacito, solo per indicare alcuni autori che dovrebbero essere noti a chiunque abbia frequentato un liceo, hanno fatto della riflessione sul metodo storiografico il centro della loro indagine. La domanda prioritaria che uno studioso si deve porre, al fine di un corretto approccio a una metodologia della ricerca nel campo dell’umano, riguarda quindi il rapporto esistente tra il modo in cui si racconta un oggetto e l’oggetto stesso. È perciò evidente quanto questo tema, oltre a essere costituente della ricerca storica, della storiografia e dell’antropologia, sia ancora oggi la questione fondante del giornalismo, dell’inchiesta e del reportage. Per dirla filosoficamente, è la questione della verità.
La ricerca di Frank Westerman si potrebbe riassumere in queste poche parole, che hanno la semplicità delle questioni epocali e il respiro delle domande essenziali. Domande che si ripropongono da quando gli esseri umani riflettono su loro stessi, su ciò che fanno e sulle conseguenze che ne derivano. D’altronde è proprio l’appartenenza a quella plurimillenaria riflessione che fa da sfondo al recente Noi, Umani, un po’ saggio un po’ memoir, che lo rende interessante ai nostri occhi. Anzi, onore al merito a Frank Westerman, che, senza mai pretendere di essere attuale, conscio di tutte le implicazioni sottese da questo termine, e accettando di essere un nano sulle spalle di giganti, riesce, grazie alla specificità del suo oggetto, a incuriosire e ampliare un orizzonte, per quanto già scrutato dagli strumenti ottici di generazioni di narratori e scrittori, cercando un cammino autonomo, e spiegandoci le difficoltà che vi si incontrano.
“Ogni reporter dovrebbe sentirsi come un bambino che si precipita a casa per raccontare alla mamma la cosa straordinaria che gli è appena successa. Il che obbliga a frasi brevi e a un ordine nel discorso, la cosa più importante per prima. Ma io quel metodo l’ho abbandonato. La realtà è troppo ribelle per prestarsi a un lavoro frettoloso. Troppo contorta per una rappresentazione lineare. Troppo spigolosa per essere raddrizzata. Troppo assurda per essere costretta in una logica”.
Così l’autore, e difatti la più breve delle frasi del volume, quella che più di ogni altra impone un ordine e indica un cammino, in questo caso è il titolo, di fronte a cui ci troviamo come davanti a un fatto compiuto, che è già di suo una netta indicazione, sia metodologica sia di contesto e che chiarisce così cosa dobbiamo aspettarci dal proseguo della lettura: Noi, umani, con quella virgola che delinea le implicazioni così come le responsabilità. Siamo noi, autore e lettori, insieme, l’oggetto di questo testo. È di noi che si parla, e siamo noi stessi a parlarne. Ci guardiamo allo specchio, riflettiamo su ciò che siamo. Non tanto su ciò che facciamo, se non nella misura in cui ci interessa il modo in cui agiamo, il nostro essere agenti, quanto piuttosto espressamente sul nostro statuto ontologico. Noi, e si definisce il contorno, l’orizzonte, il limite. Umani, ovvero un aggettivo, una modalità dell’essere. Si noti inoltre che non vi è alcun verbo, non vi è una frase completa, uno spazio linguistico dove il soggetto possa agire (o subire) una azione caratterizzata da un complemento. Vi è solo un evento, un accadere, un dato, una posizione, un fatto, direbbe Westerman. Noi, umani. Quasi fossimo contrapposti a ogni altro ente o categoria, un titolo figlio della drammatica necessità di identificarsi e differenziarsi. L’assenza del verbo fa emergere una ulteriore particolarità, che merita di essere specificata.
 Hominids di Breval.
Hominids di Breval.
Nelle intenzioni dell’autore la relazione, il nostro appartenere a un mondo reticolare di collegamenti e scambi, viene intesa come un aspetto marginale, che passa assolutamente in secondo piano rispetto all’emergenza dello status ontologico primario. Per Westerman il legame tra individui parrebbe quindi una modalità dell’essere asservita al nostro puro accadere in quanto umani, alla nostra specificità, dove l’unico legame acconsentito è quel comune tema genetico, che è poi ciò che determina il noi, ma che si mostra come monadico, mai come affezione. Una folla di schegge impazzite che, fatto salvo riconoscersi come comproprietarie di uno stesso genoma, alla fine non hanno nulla in comune. Riferendosi ai suoi allievi, commenta, abbozzando una critica che resterà centrale per tutto il testo:
“[…] immersi come sono nel postmodernismo per loro la realtà consiste al massimo in una sottile e divertente ragnatela di rimandi. Niente esiste «davvero»: l’equatore, un semestre, il nord e il sud. Tutto è una convenzione!”.
In quel noi Westerman cerca quindi complicità, prova a coinvolgere il lettore in questa sua visione antropocentrica, in questa sorta di proselitismo, per quanto molto problematico e carsico, convinto che la razza umana debba riunirsi intorno alla sua specificità, pena la scomparsa nell’indistinto dell’alterità e della scarsa definizione.
Un racconto attraverso il tempo e lo spazio
La storia che ci viene raccontata viaggia su diverse linee narrative. La prima è quella dell’autore, insegnante di reportage all’Università di Leida, che affronta insieme ai suoi studenti un tema su cui lavorare, tema che potremmo definire di storia dell’antropologia o della paleontologia: “[…] avremmo contribuito tutti alla nascita di un nuovo libro. Questo libro”. Si tratta della scoperta dei resti di un tipo di ominide, ritrovati nell’isola di Flores, in Indonesia, e che, non senza difficoltà e molte ritrattazioni, vengono identificati come una diversa specie del genere homo, che fu chiamata Homo floresiensis. Il riconoscimento ufficiale da parte degli studiosi avviene nel 2003, dopo il ritrovamento di uno scheletro, ma Westerman racconta una storia di ricerche e scoperte che risale a molto tempo addietro, sino alla metà dell’Ottocento e alle teorie che Alfred Russel Wallace elaborava parallelamente al suo coevo Charles Darwin. Il volume quindi contiene, mescolata alle altre narrazioni, una sorta di storia alternativa della paleontologia, che ripercorre con dovizia di dettagli gli scontri e gli asti tra i ricercatori.
 Alfred Russel Wallace e Charles Darwin.
Alfred Russel Wallace e Charles Darwin.
Posizioni spesso anche meschine e molto poco rispettose della scienza di cui avrebbero dovuto essere alfieri. La scienza, o meglio, gli scienziati, non escono certo bene dall’impietoso ritratto che ne traccia Westerman, il quale non perde occasione per sottolineare i giochi di potere e gli interessi di bottega sostenuti dalle varie fazioni, sostenitori di una particolare teoria o di una certa interpretazione dei fatti. Inoltre, Westerman realizza come alla radice di questa ricerca vi sia anche un grande bisogno di mantenere la cosa in un ambito che assomiglia più allo show business che a una accademia scientifica.
“A soli dieci anni dalla scoperta dell’homo florensis il genere homo si era arricchito di un nuovo virgulto, l’homo naledi, […]. Ormai i titoli dei giornali si potevano riciclare: ai redattori delle pagine scientifiche bastava sostituire solo il nome della specie”.
Tutto ciò secondo l’autore è molto distante dalla centralità epocale del tema in oggetto, e non esita a inquadrare i molti personaggi di questo teatrino anche sotto la lente della psicoanalisi, mettendo così in luce l’ossessione che così frequentemente li accompagna.
“La collezione Dubois è il più grande bottino di fossili coloniali dell’Olanda, arrivato via nave nell’Ottocento dall’isola di Giava in quattro grandi casse. Quarantamila reperti tra ossa, denti e conchiglie trovati nel corso degli scavi archeologici eseguiti a Giava e Sumatra […]”.
Questo è solo uno dei molti passaggi del testo che mettono in relazione la ricerca sulle origini con la prassi dei paesi colonizzatori (da evidenziare il modo decisamente discutibile in cui si parla del professor Tenku Jacob, che, da indonesiano, cerca, magari non con i modi ufficiali, di proteggere il patrimonio archeologico del suo paese). Una storia della paleontologia olandese in particolare, si rivela essere anche storia della colonizzazione dell’Indonesia, anzi, ne è il personaggio principale, e difatti molti degli studiosi – archeologi, paleontologi, storici – che indagano sul passato dell’isola, provengono dalla stessa terra di Westerman. Lo scrittore nel corso dell’indagine ripercorre la vita di molti di loro, e la scopre spesso corredata di traumi, situazioni angoscianti e difficili, oltre che mal sopportata dai personaggi del suo stesso racconto. È Il cammino seguito dal gruppo di lavoro organizzato con gli studenti, e che collega la Valle della Mosa, ormai ridotta a una gigantesca area industriale dove la terra, il fiume, l’aria e il mare sono stati lungamente avvelenati (e sì, siamo Noi, umani a esserne responsabili) con l’isola di Flores, incredibilmente lontana, nel tempo e nello spazio, nemesi e contrappasso delle terre basse del nord Europa.
Sulle ragioni del metodo adottato
La seconda linea narrativa è quella metodologica, attraverso cui l’autore ci racconta come viene affrontato il tema fin qui esposto. Emergono qui le domande cruciali che l’autore si pone circa la ricerca che sta svolgendo e il modo in cui è più corretto compierla, tutto quanto riguarda le sue implicazioni, anche sottointese, e la capacità che ha di far emergere fatti abbandonati o volutamente dimenticati. Quello che però scopriamo è che le risposte alle domande si trovano se si segue una disciplina, un metodo, se si applica una strategia investigativa adeguata.
“Perché preferisco il reportage al romanzo? La risposta più semplice è: perché davanti alla vita vera non c’è fantasia che tenga. Mi imbatto di continuo in storie realmente accadute così inverosimili che, se immerse nella finzione letteraria, perderebbero subito ogni residuo brandello di credibilità”.
Poche pagine dopo aggiunge:
“[…] Questo mi ha condotto a un punto decisivo, l’idea dell’oggetto del reportage come moving target. In un reportage che si propone di indagare un argomento, l’oggetto dell’indagine è «mobile». Si sposta. […] Partire e verificare sul posto è una condizione essenziale, un requisito imprescindibile. Un romanzo si può scrivere senza fare ricerca sul campo, un reportage no”.
Nulla di ciò che emerge viene tralasciato, a partire dal problema della relazione scienza-religione, di come è stato affrontato e delle reazioni sia ufficiali delle varie chiese cristiane (a Flores gli abitanti sono in larghissima maggioranza cattolici, nonostante l’isola sia parte del più grande paese musulmano del mondo), sia individuali degli uomini che si devono confrontare con la crisi di un mondo e il vacillare della fede. Westerman non è comprensivo con i portavoce delle chiese: in diverse occasioni ne mostra gli abusi, gli errori, la chiusura mentale e la complicità con i potenti. Nella parte conclusiva del volume vi è una sentita e doverosa trattazione della repressione avvenuta in Indonesia negli anni Sessanta, e l’autore non si esime dall’annotare:
“[…] ho letto fin nei dettagli più rivoltanti il comportamento tenuto dal clero cattolico durante i massacri del 1965 – 66. Almeno si fossero limitati a voltare la testa dall’altra parte. […] Dall’archivio ecclesiastico della città di Ende risultava come il clero di Flores avesse incoraggiato lo «sterminio» dei non fedeli e dei credenti di altre religioni”.
La questione post-coloniale, collegata tra l’altro allo spinoso problema del possesso dei reperti scavati dalle nazioni europee e ora esposti nei musei e nelle collezioni dell’occidente, oggi rivendicati dai legittimi proprietari, è al centro di molti passaggi del libro, così come l’antropocentrismo, oggi messo all’indice dalla gran parte del mondo evoluzionista, che rifiuta il modello ad albero, proprio di una visione progressista, teleologico e finalista.
“Lo ammetto, trovo gli esseri umani delle creature eccezionali. Non perché dotate di una maggior sensibilità rispetto ad altre, non per questo. Ma sicuramente diverse, stupefacenti. […] gli scimpanzè non hanno incubatrici in cui tenere neonati prematuri, né satelliti spia, né piatti pronti, né sigarette, né adesivi con su scritto IL FUMO UCCIDE, né ipoteche, piani pensionistici individuali, razzi Tomahawk, detrazioni fiscali per donazioni a ONLUS, avvocati penalisti, orchestre sinfoniche, camere della tortura, TAC, inginocchiatoi, tappeti di preghiera, casinò, bordelli, cani guida per ciechi. Noi esseri umani siamo gli unici al mondo a inventare storie e a scriverle: siamo capaci di arrossire e raccontare barzellette, programmare e sabotare, filosofare e fare teatro”.
Dell’antropocentrismo
Westerman, trincerato nel suo antropocentrismo, pare non comprendere le modalità composite di casualità e adattamento proprie dell’evoluzione, e difatti non riesce ad accettare che l’homo sapiens sia un risultato dello stesso processo che ha portato alla formazione del mondo animale e vegetale. Certamente il suo è un atteggiamento pieno di dubbi e di domande, ma alla fine il risultato si esprime chiaramente.
“Però, forse, non ogni singolo aspetto della natura umana ha una banale spiegazione biologica. Erano soprattutto i comportamenti contro natura ad apparirmi tipicamente umani. Sprecare scommettere, farsi un trip, medicare, evangelizzare. […] perché le persone dovrebbero donare il sangue degli sconosciuti? Da dove viene la compassione che proviamo per vagabondi e mendicanti? Perché creiamo mense per i poveri, luoghi di accoglienza per i profughi e centri di riabilitazione? Quali vantaggi concreti offrono altruismo e solidarietà nella lotta per la sopravvivenza?”.
Westerman crede che per gli esseri umani non si possa più applicare il meccanismo della selezione naturale, la propensione della specie alla riproduzione. Di fatto vede l’evoluzionismo applicato alla nostra specie come un riduzionismo semplicistico, nonostante la biologia contemporanea sia andata ben oltre questo meccanismo. Per lui l’uomo è un prodotto sostanzialmente culturale, e in quanto tale va compreso e discusso con un metodo e un modello indipendenti, per quanto questo non implichi nessun tipo di giustificazione, anzi.
“Intelligenti come siamo, siamo stati capaci di manovrare gli scambi dell’evoluzione, e siamo usciti dai binari della natura. Come autoproclamato «coronamento della creazione», abbiamo inquinato così tanto il pianeta, atmosfera compresa, che questo ci sta uccidendo. Benvenuti nell’Antropocene!”
Il testo di Westerman è quindi un oggetto molto variegato, in cui i collegamenti sono spesso intrecciati tra loro, e il dubbio, o per lo meno un’epochè husserliano, diventa l’unico filo conduttore che l’autore permette. Sotto una formale imparzialità e una effettiva onestà intellettuale si nasconde però una emotiva partecipazione a un mondo di valori forti, dove l’umanità si erge nella grandezza delle sue opere, dalle piramidi alla scienza moderna, e i valori dell’occidente restano quelli che meglio di tutti permettono anche a chi non vi appartiene di usufruire dei suoi benefici. Solo qui, nella vecchia Europa siamo stati in grado di mettere in discussione i nostri stessi fondamenti, permettendo quindi al resto del mondo quella emancipazione che forse altrimenti non sarebbe mai giunta.

Il cranio dell’Homo floresiensis in 3D.
Certo questo non sottende alcuna giustificazione ai genocidi di cui siamo stati responsabili, e Westerman in nessun punto lascia intendere questa weltanschauung illuminista come qualcosa di diverso da una problematica con cui fare inevitabilmente i conti, e la riproposizione di una visione ottocentesca che chiuda gli occhi sulle nostre responsabilità è una possibilità esclusa a priori, anche come ipotesi di scuola. Il nostro mondo è di ciò che lui ritiene il migliore dei pensieri possibili, ma coerentemente lo considera alla stregua di una delle possibili verità, e non elude nessuno dei limiti che incontra. Per l’autore questa sorta di illuminismo progressista a cui è tenacemente aggrappato è un principio metodologico, che gli impone di restare altrettanto agganciato ai fatti:
“Con i miei studenti voglio fare il passaggio dall’astratto al concreto, con tanto di crani da far passare di mano in mano. Solida materia: il reportage non è un mollusco, ma un genere che appartiene alle forme vertebrate del racconto, che trae forza da una spina dorsale di fatti”.
Questo è il proposito, all’inizio del testo. A poche pagine dalla fine, quando, dopo la constatazione dell’assenza di qualsiasi certezza, si pone il dubbio che una visione postmodernista sia forse più efficace, Westerman ribadisce che:
“I fatti restano il mio chiodo fisso, e non li mollo. Li prendo in mano, li volto e li rivolto, li studio alla luce della lampada frontale della mia immaginazione. Ma per quanto riguarda le teorie su ciò che rende tale un essere umano, ne erano state formulate così tante nel corso degli anni che ormai, più che interessarmi nel merito, mi colpivano per quanto fossero diverse e per quanto durassero poco”.
Insomma, una visione della paleoantropologia che, pur essendo sempre alla ricerca di una dottrina unificante forte, riconosce di essere un work in progress, e di avere molte difficoltà nel costruire un’idea coerente circa il problema delle origini della nostra specie.