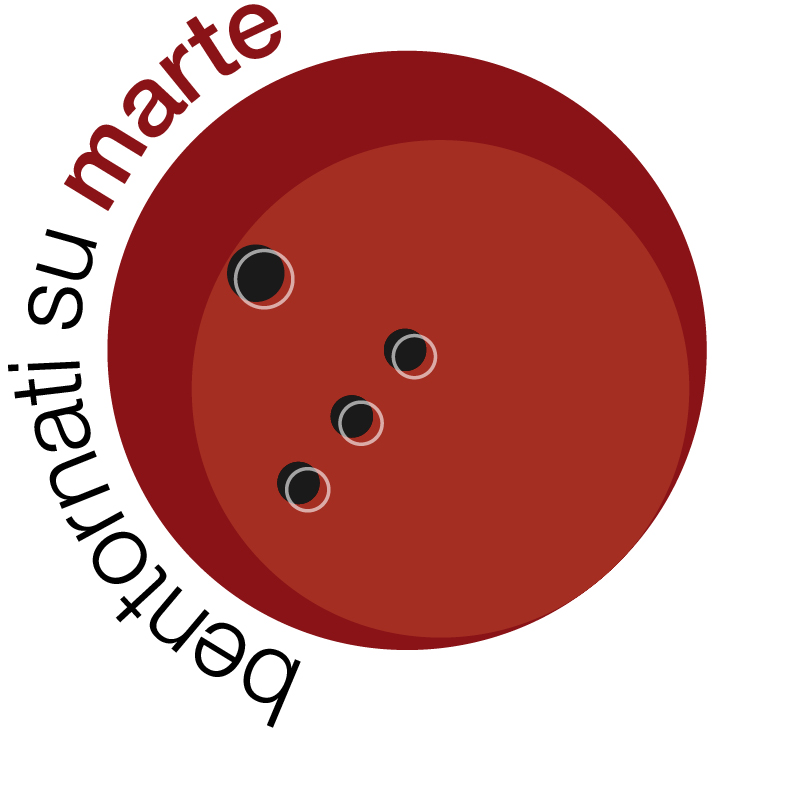“Perché poi la gente si ostini ad andare su Marte è una cosa che non mi entra in testa. È piatto, freddo, pieno di miserabili piante rachitiche che sembrano uscite da un incubo di Edgar Allan Poe. Ci abbiamo buttato miliardi per non ricavarne neanche un centesimo. Io dico che chi ci va senza esserci mandato, dev’essere un po’ tocco nel cervello”.
Arthur C. Clarke, Le sabbie di Marte
Nel settembre del 2016 l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha organizzato in tutti i paesi membri un workshop aperto ai cittadini per raccogliere le loro opinioni sulla futura strategia spaziale europea. Rispetto alla sua più nota omologa americana, l’ESA offre un’immagine dell’impresa spaziale molto meno avventurosa, fatta di satelliti per l’osservazione della Terra e per la navigazione satellitare, rassicuranti storie sui benefici di questi sistemi per la vita quotidiana di noi europei, astronauti che sembrano piuttosto degli zelanti impiegati pubblici che giungono alla Stazione Spaziale Internazionale a bordo di autobus aziendali (le navette Soyuz, da quando gli Shuttle sono stati dismessi). Ogni tanto l’ESA riesce a catturare l’attenzione dell’opinione pubblica con imprese di esplorazioni più ambiziose, come Rosetta, la sonda inviata ad analizzare una cometa, o ExoMars, per l’esplorazione di Marte, sebbene in entrambi i casi l’atterraggio dei rispettivi lander sia finito in uno schianto. Ma, per quanto non sia il segmento preponderante del business aerospaziale, l’esplorazione resta la dimensione più tipica dell’immaginario comune associato allo Spazio. Pertanto, anche al workshop con i cittadini italiani organizzato dall’ESA a Roma si è finito per parlare soprattutto di Marte, anziché, per dire, delle politiche di gestione dei dati sensibili raccolti dai satelliti di telerilevamento. Dobbiamo “colonizzare” Marte? E, analogamente, dobbiamo “sfruttare” le risorse dello Spazio, in particolare quelle degli asteroidi? Domande su cui a un certo punto si è sfiorata la rissa, tra chi proponeva una visione legata ai temi dello sviluppo sostenibile, a difesa dell’ecosistema spaziale e marziano, per non “esportare” anche fuori dall’orbita terrestre la nostra logica predatoria, e chi invece sosteneva che la conquista di Marte fosse solo una questione ingegneristica, nulla a che vedere con l’ideologia politica, perché dopotutto si tratta di un pianeta morto, e non ci sono nativi americani da sterminare.
Si poteva a un certo punto credere di trovarsi al workshop che nel romanzo Il verde di Marte (1993), secondo volume dell’ambiziosa e imponente trilogia di Kim Stanley Robinson, divide i coloni terrestri nell’anno 2104. Bisogna terraformare Marte o preservarne l’ecosistema geologico? Trasformarlo in un mondo indipendente dalla Terra o renderlo una colonia per la dilagante sovrappopolazione della madrepatria? Restare nelle mani delle grandi corporations che governano il pianeta o tentare di costituire un’esperienza di autogoverno innovativa, fondata su princìpi nuovi? Se si depura la trilogia di Robinson dall’azione, dagli intrighi e dalle vicende personali dei suoi protagonisti, ci si ritrova con una sorta di ampio trattato politico sul futuro umano su Marte. Ed è proprio quello che manca oggi a noi terrestri, ora che l’idea di “conquistare” il Pianeta Rosso sta cominciando ad assumere forma e consistenza: un serio, ragionato dibattito sul perché e sul come insediarci su di esso.
 Le immagini nell’articolo sono NASA. Invitano ad arruolarsi in future spedizioni su Marte. Titolo: Be a Martian!
Le immagini nell’articolo sono NASA. Invitano ad arruolarsi in future spedizioni su Marte. Titolo: Be a Martian!
Il colonialismo nell’epoca della sua riproducibilità tecnica
Nella recente docu-fiction Mars (2016) prodotta e trasmessa da National Geographic, a un certo punto ascoltiamo l’intervista di una dirigente della compagnia aerospaziale americana SpaceX: “L’uomo può andare su Marte, vi può fondare colonie, può diventare una specie interplanetaria”, afferma. “È solo un problema di ingegneria, come tanti altri”, precisa. “Solo un problema di ingegneria”, ossia calcolare le orbite, costruire strutture schermanti per la radiazione spaziale, motori in grado di risparmiare carburante, trovare il modo di inviare in anticipo le scorte alimentari sul pianeta, individuare le soluzioni tecniche per la realizzazione degli habitat permanenti. Non è stato così anche per la Luna, dopotutto? Ma davvero una colonizzazione può essere solo un problema di ingegneria, “come tanti altri”?
Ancora da Mars: Peter Diamandis, influentissima incarnazione dell’ideologia della Silicon Valley e del suo spirito imprenditoriale applicato alle grandi imprese, tra cui l’avventura spaziale, paragona la conquista di Marte a “la colonizzazione del Nuovo Mondo, la ferrovia, l’apertura verso il West”. Newyorkese di nascita, ma nato da genitori greci, Diamandis ha assimilato fino in fondo l’immaginario americano della frontiera, e lo ha esteso alle stelle. Nel suo libro Abbondanza, lo ammette chiaramente: “Certo, ho desiderato aprire la frontiera spaziale sin dall’infanzia” (Diamandis, Kotler, 2014). Tutti i suoi progetti – Space Adventures, Planetary Resources, l’International Space University, la Rocket Racing League, Zero Gravity, fino al recente X Prize che punta a premiare la prima compagnia privata che sarà in grado di mandare un rover sulla Luna – sono protesi oltre l’orbita terrestre. D’altronde, se lo sviluppo storico del capitalismo industriale è stato possibile grazie alla disponibilità di spazi enormi da colonizzare, e di popolazioni tecnologicamente inferiori da rendere subalterne (da impiegare come manodopera o come mercato di sfogo della sovrapproduzione), ne deriva che lo sviluppo del tardo-capitalismo post-industriale ha bisogno di nuovi spazi, di Spazio.
Ecco allora spiegata la corsa di compagnie ambiziose come Planetary Resources, fondata da Diamandis e da Eric Anderson (che con Space Adventures fin dal 2001 ha venduto costosi biglietti per la Stazione Spaziale Internazionale), o dell’omologa Deep Space Industries, per accaparrarsi i diritti di sfruttamento delle risorse minerarie degli asteroidi, intorno alla Terra o più oltre, nella fascia tra Marte e Giove. Sappiamo da tempo che gli asteroidi conservano al loro interno minerali preziosissimi, presenti solo in tracce sulla Terra, come quelli del gruppo platino, fondamentali tra l’altro per l’industria dell’alta tecnologia. Superare le pastoie burocratiche (in particolare un Trattato internazionale del 1967 che limita le attività nell’Outer Space a sole finalità scientifiche) è il primo obiettivo di queste startup, allo scopo di ottenere generose “concessioni minerarie” e poter fondare nuove Compagnie delle Indie Spaziali, con il beneplacito di interi governi, come quello del Lussemburgo, che si è dotata della più avanzata legislazione in materia per poter beneficiare per prima dei vantaggi dello sfruttamento spaziale.
Marte è destinato allora a diventare meta di una nuova espansione coloniale, sotto la pressione dell’esigenza di “nuovo spazio vitale” (la stessa che, detto en passant, ha provocato la gigantesca mattanza della Seconda guerra mondiale)? A prestar fede ai discorsi che girano, sì. Su Marte ci saremmo potuti andare già molto tempo fa, se avessimo avuto come unico obiettivo quello di piantarci una bandiera a stelle e strisce prima di quella dei sovietici. Ma, alla NASA come all’ESA, il mantra è sempre lo stesso: se si va su Marte, è per restarci. E vale davvero la pena spendere cento miliardi di euro, nel migliore dei casi, per impiantare una o più stazioni scientifiche su un pianeta (apparentemente) morto, trasformando Marte nella nuova Antartide? La risposta, ovviamente, è negativa. Il gioco vale la candela solo se l’obiettivo è “colonizzare” Marte.
Astrognostico, stadio supremo del tecnognostico
Nel corridoio che porta all’ufficio di Elon Musk, l’ambiziosissimo enfant prodige californiano fondatore di SpaceX, prima compagnia spaziale privata ad aver inviato navette alla Stazione Spaziale Internazionale e, a breve, anche astronauti in orbita, ci si imbatte, racconta il suo biografo Ashlee Vance, in “due giganteschi poster di Marte affissi fianco a fianco”: il primo rappresenta Marte com’è oggi, il secondo lo stesso pianeta ma “con un’omogenea massa continentale verde circondata dagli oceani”, dopo un adeguato processo di terraformazione (Vance, 2015). Quest’immagine è la stessa che ricorre nelle copertine della trilogia di Kim Stanley Robinson, giacimento di immaginario dal quale Musk ha attinto a piene mani per costruire il suo sogno marziano. Tutti i suoi progetti miliardari, dalla produzione di auto elettriche Tesla ai pannelli solari ad alte prestazioni di Sun City, dalle nuove batterie elettriche per l’autonoma energetica delle abitazioni ai trasporti a 1.000 km/h con il sistema pneumatico-fotovoltaico di Hyperloop, sono diretti a un unico, grande obiettivo: Marte. Come racconta Vance, tutti i dipendenti delle aziende di Musk sono consapevoli che il loro lavoro fa parte di una visione più ambiziosa, quella di portare il loro capo su Marte per fondare una colonia, con lo scopo di trasformare l’umanità in una “specie interplanetaria”.
Al momento il loro lavoro consiste nel realizzare razzi per l’orbita terrestre, ma sanno bene che presto sarà chiesto loro di rimboccarsi le maniche sul progetto Red Dragon, la navicella in grado di atterrare in autonomia su Marte (ma eventualmente anche portarvi fino a sei astronauti), punto di partenza per la realizzazione del sogno di Musk. Il piano è stato illustrato per la prima volta lo scorso anno durante il 67° International Astronautical Congress a Guadalajara, in Messico, con i leader di tutte le agenzie spaziali a bocca aperta di fronte al vero e proprio film di fantascienza che Musk, in perfetto stile Steve Jobs, ha mostrato loro per sostenere la sua vision: il Mars Vehicle progettato dai suoi ingegneri prevede di mandare su Marte da 100 a 200 persone alla volta, in un’astronave enorme rispetto a quelle concepite finora dalla prudentissima NASA, che sarà rifornita di combustibile in orbita e sarà dotata di gigantesche vele solari. L’astronave sarà riutilizzabile, il che vuol dire che, una volta atterrata su Marte, potrà fare ritorno sulla Terra (portandosi indietro anche eventuali coloni che abbiano avuto ripensamenti) ed essere impiegata per nuove spedizioni. In tal modo una piccola flotta sarebbe più che sufficiente per realizzare una colonia di 80.000 persone nel giro di un secolo.
E poi? Sul dopo, nessuno dice nulla. Il problema ingegneristico sta tutto nel mandare e far sopravvivere degli astronauti su Marte, come del resto ben ci illustra la nuova generazione di film sul tema, da The Martian del 2015 (realizzato non a caso con l’assistenza della NASA) che mette in scena una riproposizione di Robinson Crusoe in chiave marziana in grado di far andare in visibilio il nerd che c’è in ogni ingegnere, al più onirico Approaching the Unknown (2016), anche qui con un solo protagonista alle prese, in questo caso, con un difficilissimo viaggio di sola andata verso Marte (Musk vuole mandarcene un centinaio alla volta, qui addirittura ne parte uno solo, un lupo solitario come ai tempi dei pionieri). Nel mezzo c’è, ancora, la docu-fiction Mars, dove i protagonisti devono continuamente affrontare problemi e contrattempi nel loro tentativo di creare una base permanente sul pianeta, ogni tanto disobbedendo anche agli ordini da Terra, ma fondamentalmente comportandosi da bravi yes-men.
Terraformati o non terraformati: questo è il problema
Ma se Marte lo si vuole davvero colonizzare, bisogna abbandonare l’idea che si tratti solo di “un problema di ingegneria, come tanti altri”, e pensare al dopo. Cosa succederà quando avremo un insediamento abitato da centinaia o migliaia di persone sul Pianeta Rosso, una colonia lontana mesi e mesi di viaggio dalla madrepatria? È uno scenario totalmente inedito di cui nessuno parla. Eppure Musk ha letto e riletto la trilogia di Kim Stanley Robinson (tant’è che ha addirittura previsto che i primi astronauti a scendere sul pianeta siano non meno di cento, come i Primi Cento di Red Mars) e si sarà imbattuto, a un certo punto, in un capitolo intitolato “Ingegneria sociale”. È il punto centrale dell’intero affresco del futuro interplanetario tracciato dallo scrittore americano: una volta che la colonia marziana è fiorente, i coloni intendono liberarsi dal giogo della madrepatria e ottenere l’indipendenza per affrancarsi dal vecchio modello tardo-imperialista delle multinazionali (nel romanzo, “metanazionali”) che, dopo aver assunto il controllo di intere nazioni sulla Terra, puntano ora a spartirsi Marte.
Il dibattito sulla terraformazione assume, in questo senso, una sfumatura tutta politica. Se Marte viene terraformato, tutti vorranno trasferirvisi per liberarsi dal clima asfissiante di un pianeta, il nostro, rovinato dal cambiamento climatico, dalla sovrappopolazione e dall’esaurimento progressivo delle risorse; se lo si mantiene com’è ora, il suo appeal sarà invece molto ridimensionato, cosicché i coloni marziani avranno più possibilità di essere lasciati in pace a costruire la loro utopia. Su questi temi lo scontro tra i Primi Cento si fa presto acceso, e i problemi di ingegneria spicciola lasciano il passo a quelli di ingegneria sociale. Bisogna, dice a un certo punto Hiroko, l’invasata sostenitrice della nuova utopia marziana, non terraformare Marte, ma areoformare la Terra, cioè rendere il nostro pianeta più simile alla logica etico-politica dei coloni marziani.

Areofanie prossime venture
Nel romanzo-cult di Robert Heinlein, Straniero in terra straniera, del lontano 1961, Valentine Michael Smith è l’unico superstite di una sfortunata missione su Marte, adottato dai marziani (sì, gli alieni, che ai tempi di Heinlein erano ancora protagonisti indiscussi della fantascienza) e ritornato poi sulla Terra col preciso scopo di areoformarla, sebbene non usi queste parole. Fonda un suo movimento, che poi diventa una Chiesa, e pratica il sesso libero, il comunismo dei beni, il superamento delle convenzioni sociali per rendere la società terrestre più simile a quella marziana, dal sapore chiaramente utopico. Ma era questo, d’altronde, anche il messaggio che dieci anni prima Ray Bradbury affidava ai racconti delle sue Cronache marziane (1950): quando, al termine della storia, la famiglia di coloni apprende della distruzione della civiltà umana sulla Terra e si specchia nelle placide acque di un canale, il capofamiglia rivela loro che quelli riflessi nell’acqua sono i volti dei veri marziani. I marziani siamo noi: gli esseri umani che, conquistato il Pianeta Rosso con l’obiettivo di trasformarlo in una nuova Terra, vengono alla fine trasformati a loro volta, non solo fisicamente (anche per la gravità marziana più bassa) ma psicologicamente, diventando non più terrestri, ma marziani, alieni. Per parafrasare Orazio: Mars captus ferum victorem cepit.
Questo tema resta sottotraccia in tutta la fantascienza che gravita intorno a Marte, sebbene ceda quasi sempre il passo a tòpoi di maggior successo, come quello dei marziani alieni conquistatori; siamo rimasti legati all’immaginario di Marte culla di civiltà aliene anche quando, a partire dalle sonde Viking, le speranze di trovarvi vita intelligente si sono praticamente azzerate, e ancora nei primi anni Duemila il rilancio del capitolo Marte nei programmi di esplorazione di NASA ed ESA è stato accompagnato da film che hanno messo in scena nuove evoluzioni dello stesso tema (in Mission to Mars (2000) di Brian De Palma, troviamo ancora un’antica, avanzatissima civiltà marziana distrutta da un’apocalisse cosmica, ma responsabile della nascita della vita sulla Terra; nel debolissimo Pianeta rosso (2000) di Antony Hoffman, la vita su Marte assume le sembianze di orribili e famelici scarafaggi; nel più inquietante Fantasmi da Marte (2001) di John Carpenter, i coloni terrestri finiscono posseduti dagli spiriti degli antichi marziani rimasti dormienti nelle viscere del pianeta). Oggi non ci facciamo più molte illusioni: il celebre volto umano su Marte fotografo da Viking 1 nel 1976 si è trasformato, nelle fotografie a più alta risoluzione dei decenni successivi, in un banale gioco di luci e ombre su un’altura, e le piramidi che sorgevano sulla piana di Cydonia si sono rivelate essere semplici formazioni geologiche. Ogni tanto spuntano, sui forum degli ufologi, presunte foto di ossa o di cucchiai rivenute dai rover marziani, ma sono gli ultimi colpi di coda della pareidolia che continua a giocare brutti scherzi. Come spiega nel documentario Mars lo storico della NASA Roger Launius: “Non abbiamo abbandonato l’idea che ci sia vita [su Marte]. C’è quasi una credenza religiosa che continuando a cercare alla fine la troveremo, e si basa sulla fede piuttosto che sulla conoscenza, nello stesso modo in cui la religione si basa sulla fede e non sulla conoscenza”. Nell’ultima scena della docu-fiction del National Geographic, i coloni scoprono infine forme elementari di vita, riuscendo così a ottenere un’estensione permanente della missione sul pianeta, orientata ora alla ricerca scientifica. Certo, scoprire che su Marte sia avvenuta, in epoche remote, un’altra Genesi, sarebbe di per sé un’ottima ragione per investire miliardi di dollari nell’impresa, perché aprirebbe scenari inediti nello studio sull’origine della vita nell’universo. Ma dobbiamo fare i conti con il fatto che, fino ad ora, tutte le ricerche in questo senso hanno fatto fiasco.
Un chiaro oggetto del desiderio: la vita su Marte
Cosa accadrebbe, d’altro canto, se trovassimo invece vita su Marte? Per esempio, nel 1996 fece il giro del mondo la notizia che particolari concrezioni scoperte in una meteorite marziana precipitata in Antartide in epoche remote potessero essere in realtà batteri alieni fossilizzati. La scoperta fu poi ritrattata, anche se il dibattito al riguardo resta ancora aperto; batteri fossili o ancora vivi sotto la superficie sarebbero un motivo sufficiente per arrestare il processo di colonizzazione e terraformazione di Marte? Oggi le agenzie spaziali mondiali si attengono al principio della “planetary protection”, il cui obiettivo è la rigorosa sterilizzazione di tutte le sonde inviate su altri corpi celesti per impedire che l’habitat alieno venga invaso da aggressive forme di vita terrestri (con l’eccezione, non di poco conto, degli stessi esseri umani). Il Marte della trilogia di Kim Stanley Robinson è morto biologicamente, anche se vivo geologicamente. La sua terraformazione non presenta particolari ostacoli etici, se non per un pugno di estremisti che vorrebbe conservare il pianeta così come la natura ce lo ha donato. Ma certo la questione assumerebbe ben altri toni se scoprissimo forme di vita passate o presenti su Marte. #MakeMarsHome, l’hashtag lanciato in occasione della messa in onda di Mars (con tanto di sito della International Mars Science Foundation, l’organizzazione fittizia che nella trasmissione coordina la missione Dedalus), diventerebbe uno slogan difficile da accettare se trasformare Marte nella nostra casa implicasse, inevitabilmente, la distruzione di una sua eventuale biosfera.
Il COSPAR, il Comitato internazionale per la Ricerca spaziale, ha definito alcuni anni fa la nozione di “regioni speciali marziane” (Mars Special Regions), dove peculiari condizioni ambientali rendono più plausibile l’esistenza di forme di vita indigene, imponendo quindi più stringenti standard di protezione dalla contaminazione terrestre. È difficile dire se un piano di terraformazione possa consentire anche la sopravvivenza di queste regioni speciali; ma di certo l’idea non è poi molto lontana da quella delle riserve indiane, e torniamo quindi al paragone di Diamandis tra la conquista di Marte e quella del Far West. Quel vecchio Far West così affine al Pianeta Rosso che la fantascienza avventurosa delle origini nella sua ingenua visionarietà ne aveva già colto le affinità, spedendo su Marte l’ex soldato sudista John Carter su tramite Edgar Rice Burroughs (missione ripetuta nel 2012 da Andrew Stanton nell’omonimo film).
La letteratura della conquista
Si tratta di un parallelismo, questo, ben incuneato nel nostro immaginario riguardo la colonizzazione di Marte. Già nel romanzo di Arthur C. Clarke Le sabbie di Marte, del 1951, si immagina che la conquista del pianeta proceda di pari passo con la recisione del cordone ombelicale con la Terra: “Siamo in guerra con Marte e con tutte le sue forze ostili: il freddo, la mancanza d’acqua, la mancanza d’aria. E siamo in guerra con la Terra. Una guerra burocratica, si capisce, ma che ha ugualmente le sue vittorie e le sue sconfitte”, spiega Warren Hadfield, direttore esecutivo dell’insediamento terrestre sul Pianeta Rosso, e poi primo presidente di Marte (Clarke, 2014). Con il Progetto Aurora, Hadfield porta a termine le procedure d’avvio per un piano di terraformazione radicale senza coinvolgere il governo della Terra, strappando così l’indipendenza del pianeta dalla madrepatria.
Lo scrittore britannico Ian McDonald in Desolation Road del 1988 ambienta le vicende in una sorta di avamposto di frontiera della colonizzazione marziana in tutto e per tutto simile agli avamposti di frontiera del Far West, con tanto di stazione ferroviaria. Marte è in fase avanzata di terraformazione, il che comporta non solo l’adeguamento dell’habitat del pianeta a quello terrestre, ma anche l’omogeneizzazione delle strutture sociali, politiche ed economiche delle colonie marziane ai modelli terrestri. “Profitto, Impero, Industria. Che importanza potevano avere un lago morto, qualche fiume inquinato, un po’ di colline di scorie?”, si chiede uno dei dirigenti della Compagnia che controlla il pianeta. “Priorità, si trattava solo di questo. Priorità e Progresso” (McDonald, 2014). Lo stesso progresso che lo ha convinto a sostituire i suoi dipendenti con robot per triplicare la produzione (salvo poi essere sostituito a sua volta); finché nell’avamposto di Desolation Road non scoppia la rivolta che porterà al rovesciamento dell’ordine esistente.
È così anche nel romanzo firmato nel 1999 da Brian Aldiss e del matematico Sir Roger Penrose, White Mars (in italiano Marte pianeta libero), fin dal titolo una chiara replica alla Trilogia Marziana di Robinson. Il protagonista si chiama Tom Jefferies, naturalmente un omaggio a Thomas Jefferson. In questo romanzo, la Terra è collassata sotto il peso delle sue crisi e la società marziana deve cavarsela come può; non si tratta solo di rendere Marte autosufficiente, ma di impedire che la civiltà umana su Marte ricada negli stessi errori commessi sulla Terra, il che implica la graduale costruzione di una società utopica molto simile a quella immaginata da Heinlein nel suo romanzo (il sottotitolo di White Mars è infatti The Mind Set Free, e suggerisce una liberazione dalle costrizioni mentali della nostra società). Influenzato dalle teorie di Penrose, il romanzo immagina che su Marte un ambizioso progetto di ricerca sulla fisica delle particelle simile a quello del CERN (che non avrebbe scoperto, come invece accaduto nel 2012, l’atteso bosone di Higgs) s’imbatta in un misterioso fenomeno che collega la fisica quantistica alla coscienza umana, innescando un processo di trasformazione che da Marte si diffonderà sulla Terra. Di nuovo, insomma, il concetto robinsoniano dell’areoformazione.
Sacrosanti motivi per lasciare la Terra
In un recente saggio firmato da un gruppo interdisciplinare di ricercatori della University of Information Technology and Management di Rzeszow, in Polonia, che esplora le questioni politiche e giuridiche legate alla conquista di Marte, l’idea che una colonia finisca inevitabilmente per affrancarsi dalla madrepatria è data per scontata: “Sembra ovvio che le generazioni nate su Marte possano avere un altro approccio rispetto a quello dei primi coloni della Terra”, scrivono gli autori, arrivando a suggerire che “un buon strumento culturale potrebbe essere una nuova religione marziana” (Szocik et al., 2016). Una simile religione, sostengono, “sottolineerebbe il senso e la finalità di questa missione [su Marte], in particolare attraverso la giustificazione delle difficili condizioni di vita. Il ruolo strategico di questa religione consisterebbe nel rafforzamento della cooperazione e della percezione di un senso sociale ed esistenziale della vita [sul pianeta]” (ibidem).
In realtà una religione c’è già, ed è persino di tipo escatologico. È quella che sostiene che la conquista di Marte sia un obiettivo imprescindibile per rendere la nostra civiltà immune da catastrofi in grado di condurci all’estinzione (al riparo cioè dai cosiddetti “rischi esistenziali”). Tenere tutte le uova in un solo paniere non è ragionevole: dividerle in due panieri ci garantisce che, se qualcosa va storto, resteranno abbastanza uova per farci una frittata. Negli ultimi decenni abbiamo scoperto che ci sono molti modi perché le cose vadano storte, sulla Terra; in alcuni casi la colpa viene dal cielo, sotto forma di asteroidi, comete, esplosioni di supernove ravvicinate o lampi di raggi gamma orientati esattamente verso la Terra. In altri casi, più probabili, le colpe sono nostre: guerre termonucleari, cambiamenti climatici, pandemie di origine naturale o biotecnologico, effetti collaterali imprevisti di nuove tecnologie o dell’ingegneria genetica, e via discorrendo. Marte diventa allora il “piano B”, la scialuppa di salvataggio dell’umanità. Tutto molto giusto, ma la fede nella civiltà multiplanetaria che sorregge i piani di Musk per la colonizzazione di Marte implica anche la rinuncia a rendere il nostro pianeta immune dai rischi esistenziali. Perché darsi pena di azzerare il rischio naturale, mitigare il cambiamento climatico, prevenire effetti collaterali dello sviluppo tecnologico, realizzare sistemi in grado di dirottare corpi celesti in rotta di collisione con il nostro pianeta (sono già in uno stadio avanzato di sviluppo, peraltro), o di consentire la sopravvivenza della nostra specie in caso di più ampie apocalissi cosmiche, quando abbiamo un pianeta di riserva da sfruttare?
È la vecchia storia dei critici dei programmi spaziali: perché spendere tutti questi soldi per lo Spazio, invece di utilizzarli per risolvere i problemi sulla Terra? Non è mai stata per la verità molto convincente (si spende di più e ancor più inutilmente per gli armamenti, tanto per dire), ma acquista qualche grado di ragionevolezza quando si riflette per esempio sul fatto che, come fanno notare Andrew Russell e Lee Vinsel in un articolo sulla rivista Aeon, Elon Musk ha preferito spendere i suoi soldi per festeggiare i trent’anni affittando un castello inglese e giocando a nascondino con i suoi venti ospiti fino al mattino. Il problema, sostengono i due studiosi, non è il modo in cui Musk spende i suoi soldi (anche lui, come tanti miliardari, fa beneficenza), ma le priorità che costituiscono la sua agenda. Un futuro più equo e inclusivo non costituisce, per Musk, una priorità su cui investire; il biglietto per andare su Marte costerà inizialmente qualche milione di dollari, poi qualche centinaio di migliaia negli anni successivi grazie alla legge dei rendimenti di scala. Non ci andremo tutti quanti, su Marte; solo un milione di persone, nei piani di Musk. Quel milione di persone che potrà permetterselo. Per tutti gli altri, come tratteggia Robinson nella sua Trilogia, non c’è che la Terra con il suo corollario di catastrofi.
Parola d’ordine: Occupy Mars
In un articolo sulla rivista intellettuale socialista Jacobin, dall’eloquente titolo Keep the Red Planet Red, Keith Spencer si lancia in un attacco contro lo storytelling della conquista di Marte presentata dalla nuova “tecnocrazia interplanetaria”: “Per quanto ho potuto cercare, nessuna delle riviste che hanno coperto l’annuncio di Musk ha menzionato questo metatema, e cioè che una colonizzazione pubblica e democraticamente organizzata di Marte non avverrà mai. Nessuno ha messo in questione la premessa che dobbiamo lasciare decidere ai miliardari come e quando andare su Marte; o che sia l’unico modo possibile per arrivarci” (Spencer, 2017). L’autore fa notare che l’insediamento di una colonia su Marte comporterebbe una serie di questioni politiche e sociali su cui non si è ancora iniziato alcun dibattito, per esempio “che tipo di restrizioni riproduttive esiteranno su un pianeta di risorse scarse? In che modo i coloni razioneranno cibo e attività? Che dire della privacy personale? Se i cittadini marziani si troveranno a lavorare in una situazione di vita o di morte, i lavoratori possono scioperare?” (ibidem). In un’economia della scarsità come sarà quella marziana prima di un’eventuale terraformazione, emergeranno ben presto diseguaglianze in termini di lavoro, abitazioni, cibo e accesso ad altre risorse. Una colonizzazione guidata da capitali privati farà sì che chi ha di più possa permettersi maggiori risorse di chi ha di meno. Andremo su Marte solo per replicare, accentuandole, le forme del tardo-capitalismo terrestre. Sono idee, queste, piuttosto radicali e minoritarie nel panorama degli entusiasti dell’avventura umana nello Spazio; ma sono idee su cui bisogna iniziare a discutere, se davvero il momento dell’atterraggio sul Pianeta Rosso si sta avvicinando come tutto lascia supporre.
Non possiamo insomma lasciare ai tecnocrati il potere decisionale sul nostro futuro marziano, così come sul nostro futuro tout court. Oggi quella rappresentata dalla Silicon Valley sembra l’unica narrazione possibile del futuro: è abbagliante, seducente, convincente, ci assicura servizi digitali più efficienti, economia condivisa, disintermediazione, affrancamento dai lavori routinari e altro ancora. Ma non prevede nessun reale superamento delle strutture sociali contemporanee e, nel suo sguardo verso Marte, non fa che proiettarle sic et simpliciter sul Pianeta Rosso. Occupy Mars, lo slogan che campeggia sulle t-shirt indossate da Musk e dai suoi collaboratori di SpaceX, non ha nulla a che vedere con Occupy Wall Street: il concetto di “occupare” è depoliticizzato, usato solo come sinonimo di “colonizzare”. Eppure, come l’antropologo Arjun Appadurai ha scritto con grandissima efficacia in un suo vasto studio, “il futuro non è uno spazio vuoto su cui incidere la rivelazione tecnocratica o le oscillazioni di lungo termine della natura, ma è lo spazio di un progetto democratico che deve iniziare dal riconoscimento che il futuro è un fatto culturale” (Appadurai, 2014). Questo vuol direi integrare la visione muskiana della conquista di Marte con una dimensione pluralista che tenga conto delle aspirazioni di tutta l’umanità nei confronti del futuro multiplanetario che ci attende; Kim Stanley Robinson lo ha evidenziato con grande lungimiranza nella sua epopea, che cerca in tutti i modi di affrancarsi da uno sguardo inevitabilmente occidentalocentrico. Andare su Marte e “occuparlo” ha senso solo se questa grande impresa può servire per trasformare radicalmente la nostra società, rendendola più inclusiva nei confronti delle aspirazioni di ciascuno verso il proprio futuro; ha senso solo se, contemporaneamente alla terraformazione del pianeta, riusciremo ad areoformare noi stessi.

- Brian Aldiss, Roger Penrose, Marte pianeta libero, Mondadori, Milano, 2001.
- Arjun Appadurai, Il futuro come fatto culturale. Saggi sulla condizione globale, Raffaello Cortina, Milano, 2014.
- Arthur C. Clarke, Le sabbie di Marte, Mondadori, Milano, 2014.
- Peter H. Diamandis, Steven Kotler, Abbondanza. Il futuro è migliore di quanto pensiate, Codice, Torino, 2014.
- Robert Heinlein, Straniero in terra straniera, Fanucci, Roma, 2016.
- Ian McDonald, Desolation Road, Zona42, Modena, 2014.
- Kim Stanley Robinson, Il rosso di Marte, Fanucci, Roma, 2016.
- Kim Stanley Robinson, Il verde di Marte, Fanucci, Roma, 2016.
- Kim Stanley Robinson, Il blu di Marte, Fanucci, Roma, 2017.
- Andrew Rusell, Lee Vinsel, Whitey on Mars. Elon Musk and the rise of Silicon Valley’s strange trickle-down science, Aeon, 1 febbraio 2017, https://aeon.co/essays/is-a-mission-to-mars-morally-defensible-given-todays-real-needs.
- Keith A. Spencer, Keep the Red Planet Red, Jacobin, 5 febbraio 2017, https://www.jacobinmag.com/2017/02/mars-elon-musk-space-exploration-nasa-colonization/.
- Konrad Szocik, Kateryna Lysenko-Ryba, Sylwia Banas, Sylwia Mazur, Political and legal challenges in a Mars colony, Space Policy, n. 38, maggio 2016.
- Ashley Vance, Elon Musk. How the Billionaire CEO of SpaceX and Tesla is Shaping Our Future, Ebury Publishing, Londra, 2015.
- John Carpenter, Fantasmi da Marte, Columbia Tristar Home Entertainment, 2001 (home video).
- Brian De Palma, Mission to Mars, Touchstone Home Entertainment, 2010 (home video).
- Antony Hoffman, Pianeta rosso, Warner Home Video, 2005 (home video).
- Mark Elijah Rosenberg, Approaching the Unknown, Vertical Entertainment, 2016.
- Ridley Scott, Sopravvissuto – The Martian, 20th Century Fox, 2016 (home video).
- Karen Wakefield, Mars, National Geographic, 2016.