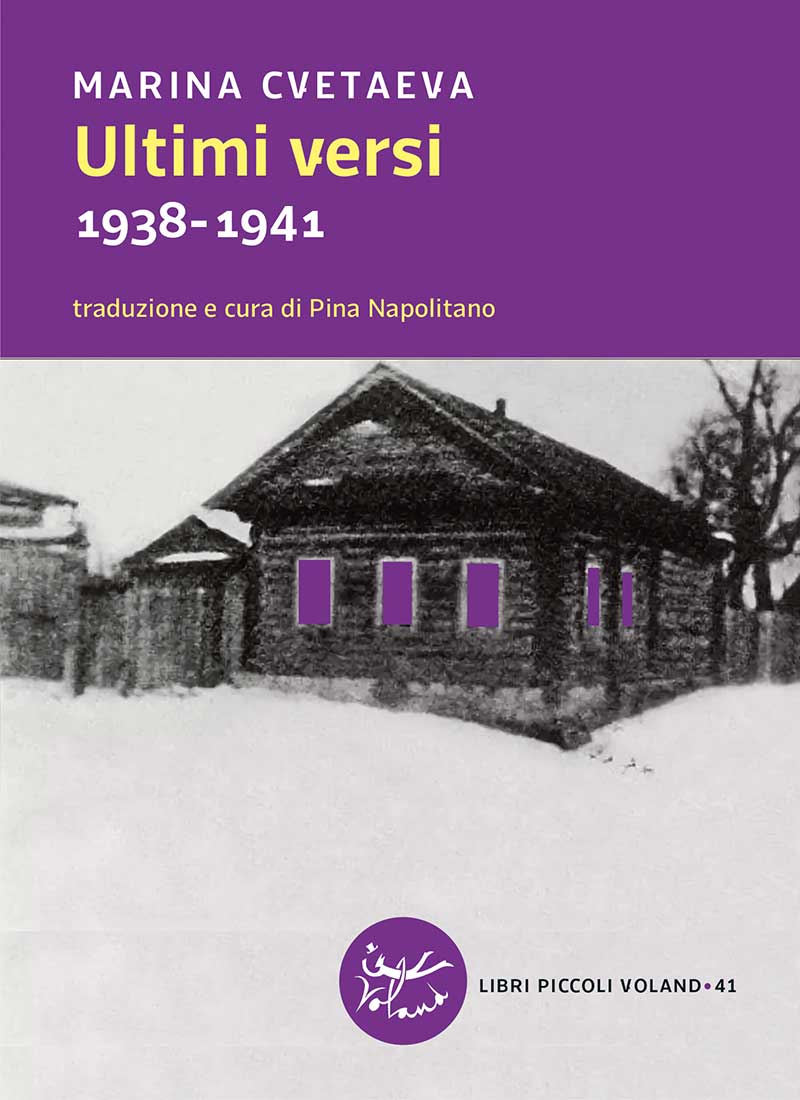Leggere Marina Cvetaeva è sempre un po’ come rivivere sulla propria pelle quell’antitesi acuminata a cui Giorgio Caproni ci costringe: “Errata / Non sai mai dove sei / Corrige / Non sei mai dove sai” (Caproni, 2006).
Marina Cvetaeva la immagini così, con quella frangia allineata e composta, quel viso atteggiato a un gesto di garbo, quel suo sguardo volto di là, e vedi in lei una donna mite, esitante, nel mezzo delle cose, mai un passo oltre. Poi ne leggi un solo verso, il primo di qualsiasi sua raccolta, e ti ritrovi al limite. Lo strapiombo è prossimo, eppure resisti tra quelle parole, mentre sai di franare pian piano lungo il loro capriccio, senza alcuna lanterna, senza una sola sentinella.
Quanto la rende immensa è proprio questo scivolare con lei e, però, sentirsi dentro un innesto di vita, la sua, la tua, anche dopo averne conosciuto gli schianti, i frantumi, le sbucciature, il freddo, le radure. Un innesto di vita che cresce e si dibatte tra il non sapere mai e non essere mai, ciononostante voler sapere e voler vivere. Un innesto di vita malgrado la data disobbediente del 31 agosto 1941, il suo suicidio. Perché Marina Cvetaeva, dopo ogni abbandono, uno dietro l’altro, sanguinando ricostruisce sempre tutto, mentre sta lì a ripetersi, “Casa è il cuore. –Letteratura!” (Cvetaeva, 2019).
A ottanta anni dalla sua dolorosa scomparsa, le edizioni Voland si sono arricchite di Ultimi versi. 1938-1941, raccolta preziosa per raccontarne il retroterra psicologico degli anni di fuga da Parigi all’Unione Sovietica. Tra illusioni prive di sapore e fiammate istantanee, la sua epigrafe è nella trama di versi affrettatisi a essere tutta la sua casa e il suo vorticoso cuore, soprattutto nell’assenza di un ordine e nella volontà di non soccombere. L’incanto della lettura nasce proprio da questo reclamare una radice nel periodo informe della sua emigrazione.

Come già ripercorso in queste pagine, Marina Cvetaeva vive nella cornice delle vicende politiche di suo marito Sergej Efron, ufficiale volontario nell’Armata Bianca, prima, esule poi, convinto che la Rivoluzione abbia messo al muro gli ideali del popolo stesso. È il 15 maggio del 1922 quando lei, con la sola figlia rimastale, Ariadna, dopo anni di vuoto nello stomaco, quaranta gradi sotto zero, la perdita di Irina, figlia troppo debole per resistere a una vita intera, parte dall’Unione Sovietica per raggiungere il marito a Berlino, seguirlo a Praga, dove nasce il figlio Georgij chiamato “Mur” dalla madre (in memoria de Il gatto Murr, il racconto di E.T.A. Hoffmann), trasferendosi a Parigi nel 1925.
Un amore masticato a fatica, quello verso Sergej Efron, fatto di frammenti di sé a lui e di lui a sé, il resto confinato nelle inquietudini di rivoluzioni personali e mai veramente consonanti. Lui, quella della grande Storia, lei quella della sua storia. L’una per l’altro presenti, ma non sempre; assenti, ma non a lungo. Così, pur accettando la claustrale fuga a cui lui la costringe, lei accende la penombra con braci di amori assoluti, ogni volta nuovi, pur vibranti, smisuratamente vibranti, al punto da chiudersi sempre nella sassaiola sfiancante e costernata della delusione. Del resto, i vuoti dell’anima ciascuno li fronteggia come può. Gli incommensurabili, con l’incommensurabile. E, dove questo fuori di sé non c’è, tanto vale immaginarselo tale con un salto della mente, rivederlo in chi sembra almeno conservarne una traccia, figurarselo in chi ci ha trascinato anche solo per un breve spazio di sogno oltre la solita tangibile frontiera.
Cvetaeva non ha mai saputo amare senza inventarseli almeno un po’ questi suoi amanti nella pagina scritta. Tutti mai all’altezza di una profondità, la sua, rispetto a cui ogni misura umana appare ingenerosa, oltraggiosa, ristretta ai limiti dell’irriverenza. Soprattutto, tutti predatori di una parte di sé che lei interpreta come irrimediabilmente persa, a ogni mano allontanata, e nuova ragione di vita, ad ogni vicinanza. La letteratura le rimane unica rispondenza in un mondo di disfoniche relazioni. “Ho un terribile desiderio di scrivere” (Cvetaeva, 1989), non a caso confermerà in una lettera del 1934 dalla Francia, mentre intorno è tutto cieco.

Pazientare e andare avanti, in ambienti dove le è difficile essere ben accetta dai parigini, per il sospetto di connivenza con i sovietici, dagli altri emigrati russi, perché così poco votata all’odio per i bolscevichi.
Sono anni in cui il marito si ammala ogni giorno di più, la figlia guadagna cinque franchi per sostenere tutti loro e lei ingoia il disonore di implorare un sussidio dall’amica Salomeja, e con lei dalle autorità ceche, in lettere scritte con le dita incenerite dal carbone, umide delle pozze impiastricciate dal bucato. Lo stanco rituale di mendicare a Salomeja calze più pesanti, scarpe un po’ più grandi, si placa nell’attesa di salvarsi ancora una volta con la scrittura, con le sue traduzioni, con le sue poesie, pur vendute a pochi franchi. Ma non basta a rammendare quella crepa di ogni giorno che costringe alle spalle contorte, al respiro corposo, all’urlo soffocato ma feroce contro un destino fatto di pietre mattoni macigni. In un’altra lettera scritta in Francia nel 1933, dirà:
“Né con gli uni né con gli altri, né con i terzi, né coi centesimi, e non solo coi «politici» – anche con gli scrittori io non sono: con nessuno, da sola, tutta la vita, senza libri, senza lettori, senza amici, – senza una cerchia, senza un ambiente, senza la difesa della complicità, peggio di un cane, e in compenso: In compenso – tutto” (Cvetaeva, 1989).
Il tutto, rimane la sola fedeltà possibile alla sua parola. La parola scritta resiste all’abrasione e all’insensato, raffina dal materico qualsiasi occasione Marina Cvetaeva ascolti come degna e totalizzante. Non a caso, tutti i suoi amori troveranno soluzioni imprevedibili solo trasfigurati nella scrittura. Spogliati di questa, si avviteranno nella loro stessa sgranatura. La pagina della Cvetaeva presenta una libertà espressiva che contraddice i legami della sua vita. Si compone di pause di respiro, rimandi raffinati, sonorità preziose, parallelismi e variazioni, quasi nell’intenzione di profanare i morsi della quotidianità, almeno lì, nell’unica insolita sosta concessale, così che anche l’amaro recuperi nobiltà nel verso.
“La visiera calata, / con tutto – in lotta, ormai pochi mi restano / sorrisi – per me […] / Molti ancora mi restano / sorrisi per gli altri”.
Si apre con una corrispondenza che è anche contraddizione la raccolta Ultimi versi. 1938-1941, come lo è la provocazione di ciascuna dimensione cvetaeviana. Marina Cvetaeva si muove compulsiva tra le lotte liminarie a sguardi nascosti e sorrisi negati in uno specchio, mentre guardiana di sé si impone e impone al mondo l’estrema bellezza del suo sorriso, seppur nomade. Incalza poco dopo:
“Nulla dunque mi è stato dato, / per la festa da me donata. / Così il melo – fino all’ultimo / regala via i suoi fiori a maggio!”.
Alla sua porta mai un suono, dalla sua casa tutti spariti, a nominarle una destinazione rimane l’energia infaticabile dei polpastrelli, quella per sollevare i sassi dai ricordi e svelare il colore di maggio. Amore è anche per i luoghi. La Boemia, prima di ogni altro. Cantata con le lacrime trattenute per quell’amara annessione dei Sudeti alla Germania di Hitler nel 1938, come da accordi di mezza pazza Europa. Lei, tra i suoi spostamenti, era approdata in un villaggio marginale della Boemia, dove la voracità di un posto incolto le aveva restituito una certa padronanza di sé.
“La amo di un amore disinteressato e non corrisposto, così come si deve amare. E – forse- anche senza speranza, perché: la rivedrò mai?”.
È quanto confessa in una lettera ad Anna Teskovà nel 1935. Una terra di anni “trecento di schiavitù, / venti di libertà”, quasi schiodata come lei dalla possibilità di un mattino diverso durato il tempo di un canto, il tempo del suono congiunto da più idiomi, “di fuoco e focolare – / a tutti. Di gioco, di studio – / a tutti. Di lavoro – a chiunque – / avesse due braccia”. Il fuoco d’artiglieria tedesca contesta, con pari incalzare, con l’anaforico “a tutti” in un insistente enjambement, cassa di risonanza della stretta “di un popolo solo” tra nubi stracciate. Per due decenni, quelli nell’intervallo tra l’Impero asburgico e l’occupazione tedesca, si leva vivace il tripudio di chi pensa e canta “come in nessun altro luogo”. Del resto, malgrado il degrado di quelle fughe ad ogni stagione, era nato lì il suo Mur, l’unico uomo a non averla mai colpita alle spalle, suo figlio.
“Queste montagne sono / la patria di mio figlio”, reclama, quasi qualcuno la ascolti oltre la pagina. Allora, la scrittura si fa ossessiva, famelica, smaniosa in un recupero di valli, specchi d’acque, neri boschi, pascoli di daini, stormi d’oche, quasi a sagomare “tutti i doni della natura, / tutti –nessuno escluso! / più generoso della patria / del Figlio – Mio!”.
Il figlio recupera l’onore della maiuscola, quasi a dirlo martire come ben altro Figlio. In un rinnovato scenario di passione tutta terrena, eppure sovraumana, la Cveateva si fa carico di quanto invisibile a troppi, della sua vita e di quella di un popolo a lei tanto caro quanto solo il possessivo “mio” può significare. Sì, perché nell’attenzione alle facce e alle storie altrui, lei aggiunge sempre l’entroterra della propria personale paura e della speranza che si avveri “oltre la notte della schiavitù – / il pieno giorno della libertà”.
Il nemico viene rievocato ancora in termini biblici, è Giuda omaggiato dalle piaghe dei sepolti vivi, dai carri corazzati sulla segale delle fatiche altrui, dal “supplizio della croce”, a cui replica l’altro suono, quello di chi cerca sulla carta il proprio onore senza patria. Gli echi testamentari riconsegnano il velo nero di chi patisce sotto la croce e il volto violaceo di chi quella croce la abita. Entrambi contigui nell’assonanza “addio” e “mio” a ripetersi in versi inanellati, dove lo iato amplifica il tempo del lamento ma anche quello dell’orgoglio.
Cambia la data, è il 1939, Marina Cvetaeva oppone il rifiuto alla stretta della Storia.
“È ora – è ora – è ora / di restituire il biglietto al creatore. / Mi rifiuto di esistere”.
Ora è pronta a ripartire per Mosca, ancora una volta a inseguirne le ideologie presto rovesciate di un marito diventato filosovietico insieme ad Ariadna. Di fatto, in una dacia nei dintorni di Mosca, le si offrono altra aria soffocata dagli stenti e muri di pietra. Dopo pochi mesi dal suo arrivo, viene imprigionata prima la figlia e poi il marito, accusati di spionaggio. Sergej morirà fucilato e Ariadna verrà confinata per anni in un campo di lavoro.
L’erranza con Mur prosegue tra alloggi di fortuna, camere grige, bauli come letto. Prosegue anche quel tentativo di vivere attraverso amori nuovi, sempre più fiacchi. Ora il critico letterario Evgenij Tager, avvicinatosi a lei in un pasto alla Casa di riposo degli scrittori, ora Arseneij Tarkovskij (il padre del futuro regista Andrej). Per loro, gli ultimi versi di passione. Al primo rivela:
“quando questa cosa non c’è, io la dimentico, ne faccio a meno, la dimentico come se non fosse mai esistita (sempre, al posto di «cosa», leggete: il vivo amore), e addirittura nego la sua esistenza, e dimostro ad ognuno, come 2 + 2 = 4, che è una sciocchezza, ma quando c’è, e cioè quando di nuovo cado nel suo vivo alveo – io so che solo essa esiste, che solo se essa esiste io esisto, che qualsiasi mia altra vita è illusoria: vita delle ombre dell’Ade che non hanno bevuto sangue: non-vita”.
Alla partenza di lui per seguire la moglie, Marina Cvetaeva si sente senza un posto per lei ancora una volta: nel mondo come nel cuore degli altri. “Gesso –ogni cosa / verso cui mi tendo”. Aveva preparato le date, gli incontri, le mani, per sentirsi da lui cadenzare la preghiera inspiegabile e brusca a non prestargli più attenzione. Ipertrofica nella passione quanto nella scrittura, Marina Cvetaeva gli restituisce un addio fatto di sonno, costole cocenti, di bellezza e dolore per non aver capito, per non capire mai.
“Tutti i miei amici uomini hanno preferito – a me – le loro mogli, perché «io non vado bene per la vita»” (Cvetaeva, 2011), era stata riflessione rauca di anni prima. Con Tarkovskij, sua ultima infatuazione, siede ad un tavolo immaginario. Per sei la tavola ho preparato era un componimento dello stesso scrittore dedicato ai suoi familiari scomparsi, ripreso dalla Cvetaeva con l’aggiunta di sé medesima: “Hai dimenticato uno – il settimo”. Sette, se esiste lei, una di famiglia, ma non invitata, a cui Tarkovskij non ha riservato neppure un angolo di quel tavolo. Nessun posto tra i vivi, nessuno posto tra i non vivi. Rovesciare un bicchiere non serve, neppure versare il sale, il sangue, i rivoli di rivolta al banchetto in cui ciascuno siede dove gli è dato, eccetto lei.
Tanto vale “spegnere la lanterna sul portone”.
- Giorgio Caproni, Tutte le poesie, Garzanti, Milano, 2006.
- Marina Cvetaeva, Deserti luoghi. Lettere 1925-1941, Adelphi, Milano, 1989.
- Marina Cvetaeva, Le notti fiorentine, Voland, Roma, 2011.
- Marina Cvetaeva, Sette poemi, Einaudi, Torino, 2019.