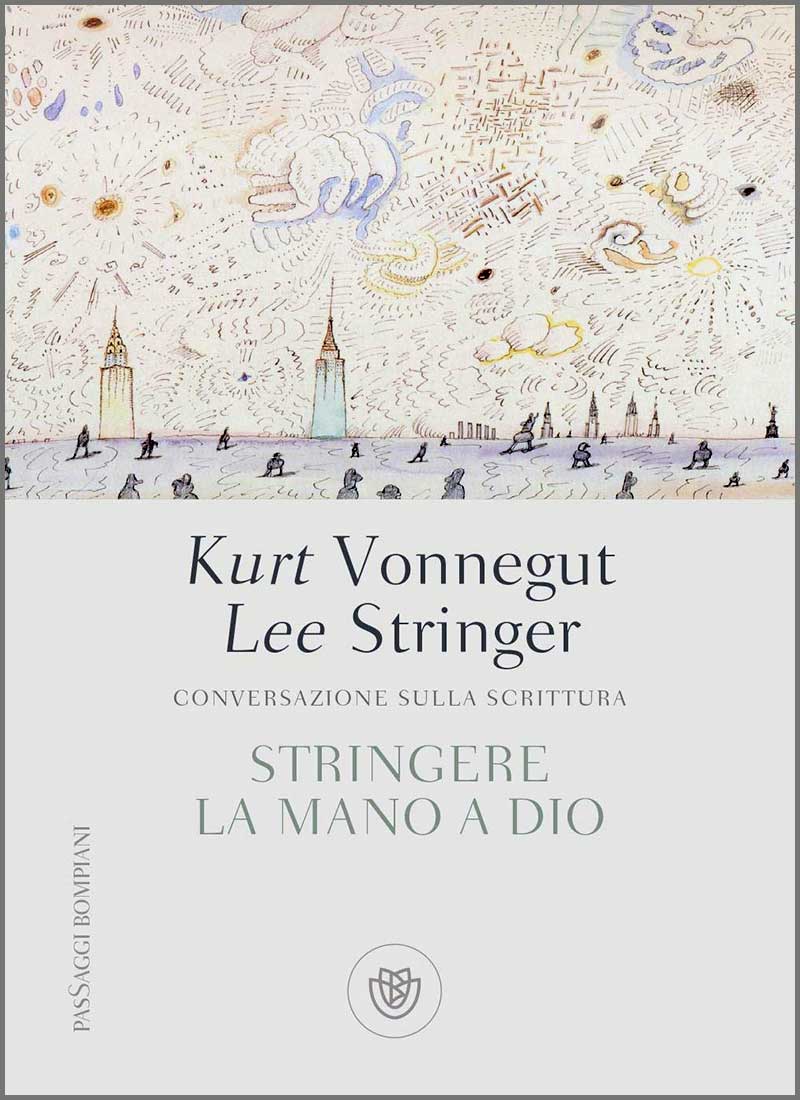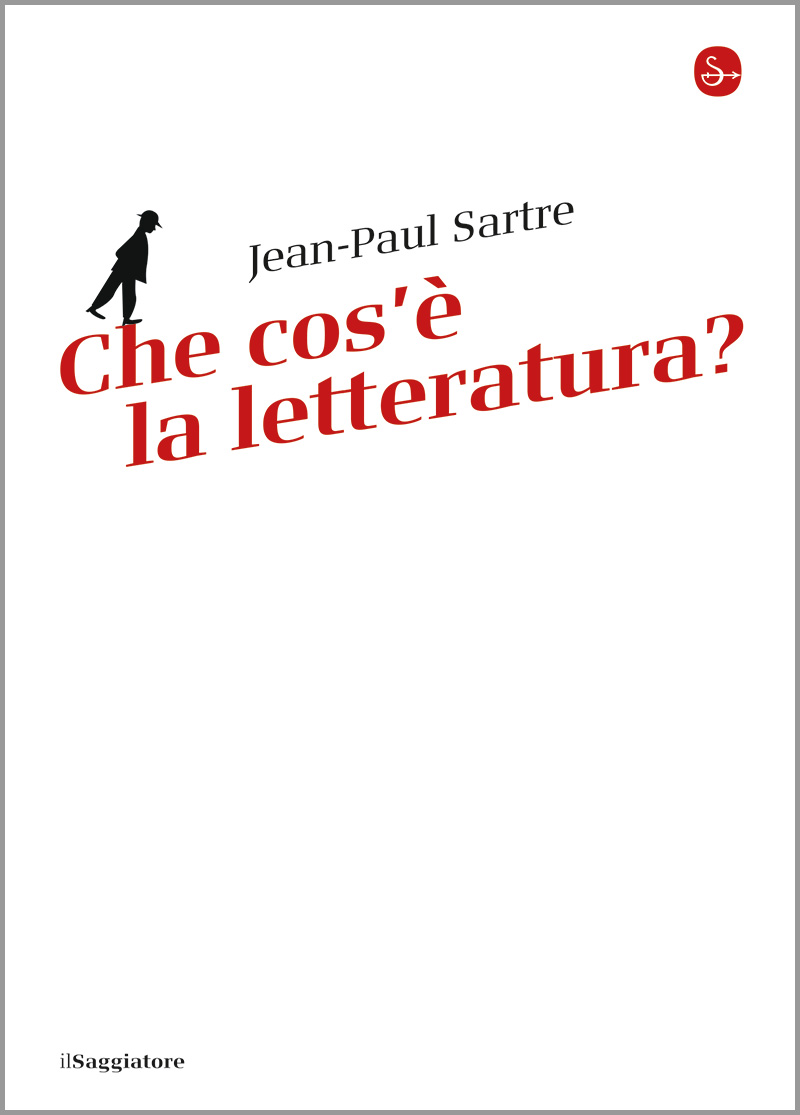“Si scrive un libro quando non si ricorda l’inutilità di scrivere libri. È una fortuna: senza questo, addio storia della letteratura che – strana sorte – è pure una cosa utile anche se è fatta di cose inutili”
(Bontempelli, 1987).
Cosa appare nella mente quando si sentono, o si leggono, le parole “immaginario collettivo”? Quale visione suscitano? Un enorme schermo panoramico su cui viaggiano come flash impazziti fotogrammi, videoclip e slogan in qualsiasi idioma si possa sognare? Un cielo notturno limpido e calmo trapunto di icone a tutti conosciute, da tutti vissute come proprie?
Un’enorme biblioteca dove volumi di ogni lingua sono immediatamente comprensibili a qualsiasi essere umano voglia accedervi? Oppure un colossale archivio lindo e asettico di supporti digitali (finalmente) consultabile da ogni dove, a cominciare dalla propria testa?
Una vertiginosa discarica di qualsivoglia materiale culturale, dove tutto si ricicla fino all’annullamento?
O, infine, una miniera nelle viscere della terra, vasta come il mondo, dove solerti e cocciuti minatori picconano e scavano per riportare alla luce quanto di bello e di brutto il resto del mondo ha preferito non vedere e seppellire?
Ancora oggi, l’unità di scambio più equa e paritaria tra due immaginari individuali (uno emittente, l’altro ricevente) è il libro: di narrativa, di poesie, di teatro. Così ce lo presenta Jorge Luis Borges, in un discorso interamente dedicatogli nel 1978:
“Fra i diversi strumenti dell’uomo, il più stupefacente è, senza dubbio, il libro. Gli altri sono estensioni del suo corpo. Il microscopio, il telescopio, sono estensioni della sua vista; il telefono è estensione della voce; poi ci sono l’aratro e la spada, estensioni del suo braccio. Ma il libro è un’altra cosa: il libro è un’estensione della memoria e dell’immaginazione”
(Borges, 1981).
Scrittori, poeti, drammaturghi, soggettisti e sceneggiatori di cinema e tv, autori di fumetti e di videogame. Golosi, avidi, spesso anche cannibaleschi: visionari sempre disposti a nutrirsi d’immaginazione (la propria, come l’altrui) per alimentare a loro volta chi non ne ha abbastanza, ma sente con urgenza la necessità di cibarsene. Oggi più che mai, gli addetti all’immaginazione altrui figurano nella maggior parte dei casi sul libro paga delle classi egemoni, tra gli “operai salariati” della borghesia, come li definirono Karl Marx e Friedrich Engels nel Manifesto del partito comunista del 1848. Sempre di meno sono coloro che riescono ancora a svolgere questo lavoro delicato, complesso e necessario anche per gli esclusi e i marginali, offrendo loro appigli, spessore e senso alla loro esistenza e individualità. Secondo Jean-Paul Sartre, la scrittura letteraria si sprigiona, innanzitutto, dal “bisogno di sentirci essenziali nei confronti del mondo” (Sartre, 2020).

Laddove quello di scrivere vicende immaginarie è un istinto, non appena si manifesta a chiare lettere, si trasforma in un impegno tanto individuale quanto a vantaggio di gran parte della collettività, se non di tutta: alla stessa stregua di un servizio sociale. Dopodiché, né più ne meno che in tanti altri ambiti e attività, anche in quello letterario capita spesso di trovare mescolate e confuse l’ambizione con la vocazione e la facilità esecutiva con la qualità, l’incisività, la pregnanza dei risultati.
Che ci fa uno scrittore con 7,78 miliardi di umani?
Ma in quale mondo, e su quale Terra scrivono oggi gli scrittori? Senza risalire al 1827 della dichiarazione sulla Weltliteratur di Johann Wolfgang von Goethe o al 1848 del Manifesto di Marx ed Engels (che ritroveremo più avanti), nel 1947, quando Sartre pubblicava Que-ce que la literature?, a due anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, la popolazione globale non superava i 2,45 miliardi di persone, secondo le stime dell’Onu. Nel frattempo, in oltre sessant’anni, il numero di esseri umani sulla Terra è più che triplicato: oggi siamo a quota 7,78 miliardi d’individui. Secondo i dati Unesco più recenti, anche i tassi di alfabetizzazione globale sono considerevolmente aumentati: in tutto il mondo l’86,4% degli individui – uomini e donne – risulta in grado di leggere e scrivere, anche se resta un esercito di oltre 750 milioni di analfabeti. Stime ufficiali – desumibili dal programma dell’International Symposium for Literacy, svoltosi nel lontanissimo settembre 1975 a Persepolis in Iran – attestavano al 55,7% il tasso mondiale di alfabetizzazione nel 1950, salito poi al 60,7% nel 1960 e al 65,8% nel 1970.

Ultima considerazione: anche la durata della vita media s’è andata via via prolungando (dai 52,57 anni in media del 1960 ai 72,56 del 2018), e con essa la disponibilità di tempo libero destinata a viaggi, letture (culturali e scientifiche in senso lato, finanche di narrativa/fiction e poesia) e fruizione di eventi musicali e teatrali e di mostre e rassegne d’arte.
Per quanto la deriva mondiale attuale sia inquietante, le memorie future del mondo non possono (e non devono) reggere sui messaggi e sui post di Facebook, PengYou o VKontakte, sui cataloghi-narcisi di Instagram, sui tweet di Twitter e Weibo. Per cui, al di là delle indubbie e radicate differenze e disparità/disuguaglianze di condizioni di vita sussistenti tra il Sud e il Nord del mondo, come tra l’Est e l’Ovest, è plausibile (e sperabile) ritenere che siano aumentati un po’ in tutto il globo non solo la propensione, ma anche il tempo dedicato a leggere romanzi, racconti e poesie, sia nella tradizionale versione cartacea che come e-book, o più genericamente sul web. E ci sono quindi ancora miliardi di vicende da raccontare, miliardi di storie da inventare, miliardi di libri da scrivere e leggere. Se possibile, libri come quelli auspicati da Franz Kafka in una lettera a Oskar Pollak del 27 gennaio 1904:
“Abbiamo bisogno di libri che agiscano su di noi come una disgrazia che ci fa molto male, come la morte di uno che era più caro di noi stessi, come se fossimo respinti dai boschi, via da tutti gli uomini, come un suicidio. Un libro dev’essere la scure per il mare di ghiaccio dentro di noi. Questo io credo”
(Kafka, 1964).
Dall’immaginazione alla comunicazione
L’immaginazione è una forma di conoscenza e di esperienza del mondo reale? Ne è fermamente convinto l’americano Philip Roth, grande lettore di Kafka, in un’intervista concessa alla sua biografa Hermione Lee e ripubblicata nel libro Perché scrivere? Saggi, conversazioni e altri scritti 1960-2013 (Roth, 2018):
“Considero (la narrativa) uno strumento per conoscere il mondo come altrimenti non potrebbe essere conosciuto. Si possono conoscere un sacco di cose sul mondo senza l’aiuto della narrativa, ma nient’altro può fornire il tipo di conoscenza prodotto dalla narrativa, perché nient’altro trasforma il mondo in narrazione. […] La narrativa dipende da uno strumento di conoscenza unico, l’immaginazione, e il suo sapere è inseparabile dall’immaginazione”
(Roth, 2018).
Chi lavora con i materiali dell’immaginario, impara a conoscere, a catalogare e ad affrontare nel tempo e con l’esperienza le intermittenze, i capricci e i dispetti dell’immaginazione. Moltiplicati anche dal fatto che l’immaginazione, poi, deve diventare comunicazione, come spiega nitidamente Raymond Carver:
“Ricordatevi che una poesia non è soltanto un atto di espressione personale. Una poesia o un racconto – qualsiasi opera letteraria che presuma di chiamarsi arte – è un atto di comunicazione tra lo scrittore e il lettore. Chiunque può esprimersi, ma quello che gli scrittori e i poeti vogliono fare nelle loro opere, più che limitarsi a esprimere sé stessi, è comunicare, giusto? C’è sempre l’esigenza di tradurre i propri pensieri e le proprie preoccupazioni più profonde in un linguaggio che li fonda in una forma – narrativa o poetica – nella speranza che il lettore li possa capire e possa provare quelle stesse sensazioni e interessi. Le sensazioni e le intuizioni del lettore accompagnano e integrano sempre un brano letterario. È una cosa inevitabile e anche auspicabile. Ma se il carico principale di quello che lo scrittore ha da dare rimane alla stazione di partenza, quel brano, a mio modo di vedere, è in gran parte fallito. Credo di essere nel giusto quando penso che quella di essere capito sia una premessa fondamentale da cui qualsiasi buon scrittore deve prendere le mosse o, piuttosto, una meta da prefiggersi”
(Carver, 2015).
Homo economicus e Weltliteratur
Certamente, è sempre molto difficile farsi ascoltare e capire su un pianeta dove a dominare è la vorace razionalità utilitarista dell’homo economicus. Eppure, a quasi duecento anni dalla sua prima, aurorale definizione, la civiltà letteraria mondiale è anche riuscita a fare qualche passo in avanti verso la realizzazione dell’antico sogno/auspicio (o constatazione/profezia?) di una Weltliteratur, come viene tratteggiata da una celebre dichiarazione di Goethe del 1827:
“Sono sempre più convinto che la poesia sia il possesso universale dell’umanità, rivelandosi ovunque e sempre in centinaia e centinaia di uomini. … Mi piace quindi guardarmi attorno in nazioni straniere e consigliare a tutti di fare lo stesso. La letteratura nazionale è ora un termine piuttosto poco significativo; l’epoca della letteratura mondiale è a portata di mano e tutti devono sforzarsi di accelerare il suo approccio”
(in Eckermann, 2008).
Visione e concetti sagacemente ripresi e ricentrati da Karl Marx e Friedrich Engels nel Manifesto del partito comunista del 1848:
“All’antica autosufficienza e all’antico isolamento locali e nazionali subentra un commercio universale, un’interdipendenza universale fra le nazioni. Ciò vale sia per la produzione materiale che per quella spirituale. I prodotti spirituali delle singole nazioni diventano bene comune. L’unilateralità e la ristrettezza mentale nazionali diventano sempre più impossibili, e dalle molte letterature nazionali e locali nasce una letteratura mondiale” (Marx, Engels, 2002).
Ma è proprio così, oggi? Sì e no. Per quanto la circolazione di libri di narrativa, di teatro e di poesia tra i diversi angoli del mondo sia in costante aumento, e (almeno in questo caso) la funzione del web sia straordinariamente benefica e favorevole all’opportunità di rafforzare i contatti tra scrittori e lettori (così come tra scrittori e scrittori, da un lato, e tra lettori e lettori, dall’altro, e in tutto il globo), molti sono ancora i vincoli e le barriere politico-culturali (al di là di quelle linguistiche) da superare per arrivare a un’effettiva federazione mondiale delle letterature nazionali. E, probabilmente, per certi aspetti deve rimanere così: il principio arcinoto della biodiversità delle specie animali e vegetali dovrebbe valere anche per quelle strane, particolari bestie articolatrici di linguaggi vecchi e nuovi e affabulatrici di nuove visuali del mondo, che sono gli scrittori, i poeti, i drammaturghi, gli sceneggiatori e così via.

L’anticamera della federazione
Secondo le stime recenti delle associazioni internazionali dei gruppi editoriali, nel 2019 la pubblicazione di libri nel mondo ha raggiunto il valore di 119 miliardi di dollari, mentre il mercato globale dell’entertainment (film, televisione e contenuti streaming) sia nei locali che a casa ha toccato i 101 miliardi di dollari (dati Motion Picture Association). Al di là dello stato di salute economico-finanziario, sempre difficile da diagnosticare (tanto più dopo l’ingresso nell’era digitale), un po’ in tutto il mondo lo sviluppo dell’industria editoriale regge, per sua natura, su equilibri precari e contraddizioni stridenti: a cominciare dal suo centro propulsivo. Nella seconda metà del Novecento, la futura federazione mondiale delle letterature – e, si potrebbe anche dire, dell’immaginario universalizzabile – ha continuato ad avere un epicentro: gli Stati Uniti, con l’inglese come lingua di riferimento e di appoggio. Così come l’industria dell’entertainment (cinema, tv, musica, videogame), anche il mondo editoriale americano ha funzionato spesso come polo d’attrazione prima, e forza centrifuga poi, per le energie degli addetti all’immaginazione non solo europei, canadesi, messicani o sudamericani, ma anche delle altre aree del mondo.
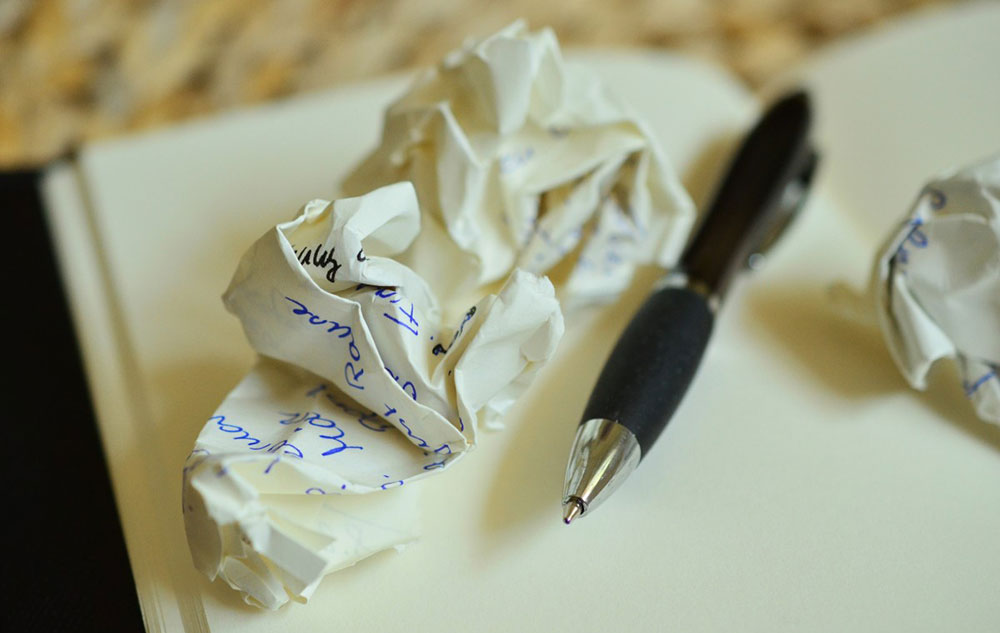
Come un enorme setaccio, e con tutte le inevitabili contraddizioni, ambivalenze, incomprensioni e defaillance del caso, l’imprimatur dell’establishment dell’industria culturale americana resta nevralgico per l’accoglienza e la diffusione nel resto del mondo di un prodotto editoriale e/o di entertainment di provenienza esterna all’area d’influenza angloamericana. Poter contare su una platea di 400 milioni di persone di madrelingua inglese e di 1,1 miliardi di angloparlanti è un vantaggio competitivo di non poco conto, rispetto agli altri Paesi e alle altre culture, che infatti, in molti casi, anelano a entrare nei circuiti editoriali angloamericani per vedersi assicurata una maggiore probabilità di conoscenza, diffusione, valutazione e affermazione.
La lingua del successo mondiale
L’assimilazione (o il rifiuto) del predominio culturale e immaginario angloamericano rimane una questione con cui molti scrittori (se non tutti) degli altri Paesi devono fare i conti. E resta difficile capire quanto tutto questo faccia da ostacolo o, invece, faciliti il percorso verso una Weltliteratur come quella auspicata da Johann Wolfgang Goethe e Marx ed Engels. Nell’apprendistato letterario di Murakami Haruki (un tenace cantore dello spaesamento delle menti globalizzate), alle origini del suo libro d’esordio Ascolta la canzone del tempo, c’è anche la singolare decisione di scrivere in inglese anziché in giapponese: un’autoimposizione che lo costringe a tenere da parte “un atteggiamento mentale ‘letterario’” (Haruki, 2017) e a mettere maggiormente a fuoco le vicende e la compattezza del racconto.
“Essendo nato in Giappone e cresciuto parlando in giapponese, la mia personalità era satura delle parole e delle espressioni della mia lingua. Di conseguenza, quando avevo provato a comunicare verbalmente le emozioni e le immagini che avevo dentro di me, tutto aveva preso a rimescolarsi senza sosta, facendo scoppiare il sistema. Scrivendo invece nel mio inglese rudimentale, quel problema era superato. […] Poi mi risedetti al tavolo e tradussi in giapponese quel primo capitolo”
(Haruki, 2017).
In un certo senso, Murakami Haruki ha pragmaticamente letteralizzato lo sforzo a cui tendono molti di quegli scrittori non angloamericani, e comunque fortemente export oriented, che aspirano per lo più a conquistare le platee di lettori anche al di fuori dei propri Paesi di origine (come nel caso dei giallisti scandinavi, ma non solo).
Un passo indietro: da scrittori a personaggi
Mentre nei mercati di massa in Europa, Asia, Oceania e Africa, l’industria statunitense dell’entertainment – tra Hollywood, tv ed etichette discografiche – è andata via via accentuando il processo di asfaltificazione e omogeneizzazione culturale del resto del mondo, in ambito letterario (dove i capitali da investire sono, in genere, considerevolmente più modesti rispetto alla produzione di blockbuster cinematografici o di super hit musicali), le case editrici, però, si sono dovute muovere, mediamente, con più cautela e più riguardi.
Tra le pratiche messe a punto con crescente perizia nell’esperienza plurisecolare dell’editoria angloamericana, continua a essere centrale quella della costruzione del culto dell’autorialità: tanto per i grandi scrittori dei generi letterari mainstream (da Raymond Chandler e Dashiell Hammett fino a Stephen King, Michael Crichton, Isaac Asimov, Ray Bradbury, Philip K. Dick e così via), quanto nell’ambito della narrativa di carattere e di ascendenza più programmaticamente letterari.

Soprattutto dalla seconda guerra mondiale in avanti, facendo tesoro dell’esperienza di Ernest Hemingway o di William Faulkner, la macchina editoriale americana ha imparato a presentare e a “imporre” al resto del mondo (prima ancora di “farne scoprire” i testi) non solo le opere, ma anche la vita e le abitudini degli autori letterari, trasformando in personaggi pubblici e mediatici a livello globale (e non solo americano) scrittori diversissimi tra loro, come, per esempio, Jack Kerouac, Jerome David Salinger, Saul Bellow, Philip Roth, Arthur Miller, Kurt Vonnegut, Truman Capote, Norman Mailer, Toni Morrison, Joseph Heller, Charles Bukowski, Raymond Carver, fino a Bret Easton Ellis, David Foster Wallace, Jonathan Franzen, solo per citare i più famosi al di qua dell’Atlantico. Molti lettori italiani, probabilmente, conoscono meglio le loro vite che non quelle di tanti scrittori connazionali.
Alla larga dalla tv, se ci si riesce
Tanto in patria e forse ancora di più all’estero, l’esposizione mediatica di un autore letterario resta una lama a doppio taglio, anche all’interno di una cornice di esaltazione della libertà e originalità dell’immaginazione e dell’indipendenza di pensiero: può funzionare per catturare l’interesse di nuovi lettori e avvicinarli a forme di conoscenza e di sensibilità più ampie e aperte, ma può rafforzare la convinzione di una larga fetta del grande pubblico della funzione vacua e inessenziale della letteratura nella vita contemporanea.
Sempre più spesso, l’attenzione di molti lettori s’è andata spostando dall’interesse e dalla conoscenza diretta dei contenuti delle opere di un autore all’impatto della sua presenza mediatica, a cominciare, per esempio, dalla risonanza, dall’efficacia e dalla coerenza dei suoi interventi in tv (gli Stati Uniti hanno fatto scuola, ma succede da tempo ormai anche in Italia: si pensi ai differenti casi delle apparizioni televisive di Alberto Arbasino negli anni Settanta e di quelle più recenti di Aldo Busi e Mauro Corona, soprattutto in relazione alla diversa portata delle loro opere).
A mali estremi, estremi rimedi. Così Kurt Vonnegut, peraltro da tempo all’apice del successo, affronta di petto la questione della tv (che oggi va allargata al web e ai social media) in una conversazione in pubblico, al fianco di Lee Stringer, autore dei racconti di Inverno alla Grand Central, riportata in Stringere la mano a Dio, pubblicato di recente da Bompiani:
“KURT: È importante anche tenersi lontani da tutta la baraonda televisiva e dalla convinzione che quello che sentiamo in TV abbia una qualche rilevanza e che non si possa fare a meno di parlarne. La letteratura è l’unica forma d’arte che esiga un pubblico composto a sua volta di artisti, naturalmente. Per fruirne bisogna saper leggere. E maledettamente bene, anche. Bisogna saper leggere talmente bene da cogliere l’ironia! Se io dico una cosa ma ne intendo un’altra, voi dovete essere in grado di capirlo. Aspettarsi che un gran numero di persone sia istruito è come aspettarsi che chiunque al mondo sappia suonare il corno francese. È molto difficile. Come dico in questo libro [Cronosisma]: pensare a che cosa voglia dire leggere… è impossibile. La letteratura si riduce a una serie di bizzarre combinazioni su linee orizzontali di solamente ventisei simboli fonetici, dieci numeri e all’incirca otto segni di interpunzione. Eppure esistono persone come voi, che sono in grado di guardare una pagina stampata e di dare vita a interi spettacoli mentali – la battaglia di Waterloo, santo cielo. Il New York Times dice che negli Stati Uniti ci sono quaranta milioni di persone che non sanno leggere abbastanza bene da compilare il modulo di richiesta per la patente di guida. Non è possibile che il nostro pubblico sia molto vasto, perché deve trattarsi di un pubblico altamente, incredibilmente dotato… Vi ringrazio per aver imparato a fare questa cosa: era praticamente impossibile. [Risate]”
(Stringer, Vonnegut, 2020).
Onorevoli colleghi, siamo amici o nemici?
Come un grande giocatore di basket, una star di Hollywood, un pilota di Formula 1, nel ruolo mediatico dell’autore affermato di romanzi, anche uno scrittore di largo seguito, quindi, può finire col sentirsi chiamato a raccontarsi in prima persona e a spiegare ai suoi lettori più affezionati le ragioni e il percorso della propria carriera letteraria.
Tra gli esempi più nitidi in questo senso, e di recente pubblicazione in Italia, troviamo Il mestiere dello scrittore del prolifico Murakami Haruki, che, rifacendosi ai modelli di comportamento di alcuni scrittori americani, s’è spesso dimostrato particolarmente abile a mantenere desta l’attenzione del proprio pubblico sulla propria opera, anche attraverso una calibrata focalizzazione sul proprio personaggio mediatico. La sua visione dei colleghi del mondo letterario giapponese (e, forse, non solo) non è particolarmente idilliaca:
“Talvolta sento parlare di scrittori legati da una sincera amicizia, ma onestamente non ci credo molto. Non devono essere rapporti tanto intimi e duraturi, tranne qualche caso eccezionale. Gli scrittori sono fondamentalmente delle persone egoiste, troppo orgogliose e con un forte spirito di rivalità. Se mettete insieme due scrittori, è piú facile che non vadano d’accordo piuttosto che il contrario. Io stesso ho fatto quest’esperienza non so quante volte” (Haruki, 2017).
Una visione agonistica degli ambienti letterari e del confronto diretto tra le doti e la potenza d’urto tra gli scrittori che riporta alla memoria un aneddoto su Hemingway, raccontato dalla sua biografa Lilian Ross:
“Hemingway paragonava la propria scrittura a quella di grandi figure del passato, impiegando metafore del mondo dello sport. Un romanziere era come un lanciatore iniziale senza rincalzi nel bullpen (area di gioco del baseball, ndr), sosteneva. «I romanzieri devono andare fino in fondo, anche se questo li uccide». Durante il suo anno a Parigi, disse, aveva perfezionato il suo lancio leggendo maestri francesi come «Mister Flaubert, che li ha sempre lanciati perfettamente diritti, tesi, alti e centrati… Mister Baudelaire, da cui ho imparato il mio lancio a effetto, e Mister Rimbaud, che non ha mai lanciato una palla veloce in vita sua». In uno scoppio di sbruffoneria, utilizzò la boxe anziché il baseball per rivendicare il suo posto in compagnia dei grandi scrittori di narrativa: «Ho iniziato in modo molto tranquillo e ho battuto Mister Turgenev. Poi mi sono allenato duramente e ho battuto Mister de Maupassant. Ho conquistato due pareggi con Mister Stendhal e penso di aver ottenuto un vantaggio nell’ultimo. Ma nessuno mi farà salire su un ring contro Mister Tolstoj, a meno che non sia pazzo o non continui a migliorare»”
(Ross, 1999, traduzione dell’autore).
Dalla scuola alla comunità letteraria
Ma tra gli scrittori che vivono e lavorano sotto lo stesso cielo e negli stessi spazi, è meglio allora che ci sia un sano clima di lotta e di rivalità oppure di rispetto e di coesistenza pacifica, al netto di ogni ipocrisia sociale e di eventuali opportunismi di carriera? Negli Stati Uniti, l’istituzione accademica delle scuole di scrittura creativa è servita anche a materializzare un’idea di comunità tra gli scrittori che è andata arricchendo e consolidando nel tempo anche un particolare senso di partecipazione diretta allo sviluppo della civiltà letteraria americana, come ben spiega Raymond Carver, che per anni ha condotto con scrupolo e dedizione corsi di creative writing in diverse università degli States, così come, tra gli altri, lo stesso Philip Roth e John Gardner.
“Per come la vedo io, l’unica differenza essenziale tra quello che facevano quei grandi scrittori e quello che facciamo noi qui a Syracuse è che noi siamo semplicemente impegnati in un’impresa più istituzionalmente strutturata. Tutto qui. Qui abbiamo tutte le caratteristiche necessarie per essere una comunità letteraria. Ogni corso di laurea in scrittura creativa del nostro Paese che si meriti questo nome ha un analogo senso di sé stesso, il senso di essere una comunità letteraria funzionante. Avrete senz’altro capito di che cosa sto parlando. (Ci sono pure un sacco di scrittori a cui questo senso di comunità non va affatto a genio. Va bene lo stesso).
In un corso del genere, dunque, esiste, o sicuramente dovrebbe esistere, questo senso di condivisione comunitaria, di persone tenute insieme da interessi e obiettivi abbastanza simili – una specie di legame di parentela, se volete. Se ci si trova in un corso del genere e si vuole approfittare di questo clima, è lì che vi aspetta. Ma anche il semplice fatto che nella stessa città ci sia un simile gruppo può alleviare il senso di solitudine, che a volte confina con un vero e proprio senso di isolamento, spesso provato da un giovane scrittore. Quando si entra nella stanza dove la creazione avviene, o non avviene, e ci si siede davanti alla pagina bianca, si è sempre in preda a una sorta di terrore eccitato. Il fatto di sapere che anche gli altri scrittori stanno facendo la stessa cosa, magari proprio in quel momento, non è che aiuti molto. Ma quel che è di aiuto, ne sono assolutamente convinto, è sapere che se poi dal tempo passato da soli in quella stanza esce fuori qualcosa, c’è qualcuno nella comunità che vuole vedere quello che si è fatto, qualcuno a cui farà piacere se si è scritto qualcosa di vero e di bello e che resterà deluso se non si è riusciti a farlo. In entrambi i casi, però, vi dirà quel che ne pensa – basta chiederglielo. Naturalmente, non è che basti solo questo, per carità. Ma può essere d’aiuto. Nel frattempo, i vostri muscoli si rafforzeranno, la vostra pelle s’indurirà e potrete cominciare a farvi crescere la folta pelliccia invernale che vi aiuterà a sostenervi nel freddo e difficile viaggio che vi aspetta. Con un po’ di fortuna, imparerete anche voi a tenere la rotta orientandovi con le stelle”
(Carver, 2015).

Dulcis in fundo, la classe di Pontiggia
Attualmente, con una veloce rassegna sul web si possono riscontrare 56 scuole di scrittura creativa negli Stati Uniti, 42 in Australia, una decina nel Regno Unito e in Italia. Qui da noi, con un approccio di particolare sensibilità umana – accostabile a quello di Carver, ma partendo da presupposti e modelli letterari decisamente diversi –, è stato Giuseppe Pontiggia a introdurre una simile pratica d’insegnamento della scrittura creativa e a coltivarla con un analogo senso d’incoraggiamento per i giovani aspiranti scrittori e una specifica volontà di trasmissione del sapere e degli accorgimenti del mestiere di scrittore, richiamandosi con maestria e ironia illuminista ai valori della civiltà delle lettere italiana ed europea, piuttosto che a quelli d’importazione angloamericana. Ma il magistero letterario di Pontiggia è rimasto un unicum e non ha creato un metodo, e neppure degli epigoni. Così rivendica e, allo stesso tempo, problematizza l’utilità di una scuola dello scrivere nel libro Per scrivere bene imparate a nuotare, appena ripubblicato da Mondadori.
“Chiedersi se scrittori si nasce è come chiedersi se Yehudi Menuhin sia nato violinista. E i maestri? E le prove, i progressi? Dove sarebbe se non avesse studiato musica? E poi: chi frequenta un conservatorio studia da genio? Viene bocciato se non è almeno Sibelius? O più semplicemente si ottiene qualche risultato: che al termine degli otto anni sappia suonare uno strumento, leggere e comporre partiture e avvicinare con maggior competenza il linguaggio musicale. Eccoci dentro il cuore del problema. Perché in Italia è normale frequentare il conservatorio e strano invece approfondire le tecniche della prosa? Si parte forse dal presupposto che a scuola si è imparato a scrivere? Scrivere è un verbo dalle curiose metamorfosi. Può avere una accezione alta, un’aura magica. Il giovane che, accennando al proprio futuro, confessa compunto: «Ho in mente di scrivere», sa a che cosa allude. Gli astanti no e forse per questo lo ascoltano con sgomento. La stessa confessione, fatta da una giovane ancora inedita, viene accolta con la solidarietà che una volta si riservava all’annuncio di una gravidanza clandestina. Mai come in questi casi il verbo scrivere è colmo di promesse irresistibili e di delusioni immancabili. Ma la sua fascinazione segreta non andrebbe mai dimenticata, pena la trasformazione dello scrivere in una professione. C’è infatti un’altra accezione del verbo scrivere, lo scrivere professionale. L’espressione cui generalmente si accompagna è «buttare giù». Devo buttare giù un risvolto. Oppure due cartelle. Oppure una prefazione. Assimilato in parte alla cottura della pasta, lo scrivere professionale richiede un corredo di competenze specifiche e comprende una variegata gamma di direzioni e di esiti: nei casi migliori approda a un linguaggio incisivo ed efficace e, nei casi più frequenti, a una prosa discretamente comunicativa, insidiata, quando il periodo si allunga, da improvvisi panici e slittamenti e cadute, ma capace di risollevarsi con dignità e riprendere una andatura composta. Lo scrivere professionale, a differenza dello «scrivere», lo si può imparare. E lo si può perfino insegnare. Il giornalista anziano che, nella redazione immaginaria di qualche film, ammaestra l’esordiente, gli insegna a scrivere un articolo. L’insegnante che non corregge – parola dopo parola, frase dopo frase – un testo (e lo capisco) evita di dare il contributo più prezioso al discente, anche se si risparmia una fatica tormentosa. Certo eccellere nella scrittura professionale richiede doti particolari. Ma per testi di media efficacia bastano doti medie e un apprendistato accanito”
(Pontiggia, 2020).
Folgorati e rianimati
C’è una celebre foto (sotto) che, forse, illustra meglio di ogni parola l’effetto che possono (o devono?) suscitare un buon romanzo, un bel racconto o una gran poesia a un lettore tramortito dall’inessenzialità e inautenticità della propria esistenza.

Si chiama Kiss of life, ed è stata scattata nel 1967 da Rocco Morabito a Jacksonville, in Florida, vincendo nel 1968 un premio Pulitzer. Ritrae J.D. Thompson, un elettricista addetto alla manutenzione delle reti ad alta tensione, che effettua un intervento di respirazione bocca a bocca per salvare il collega Randall G. Champion, in totale stato d’incoscienza per la scarica di un cavo ad alto voltaggio. Grazie allo sforzo acrobatico di Thompson per rianimarlo, Champion riprese i sensi e sopravvisse. Proprio come qualsiasi lettore: folgorato prima e rianimato poi, dalle parole del suo scrittore preferito.
- Massimo Bontempelli, Il Bianco e il Nero, Guida Editori, Napoli, 1987.
- Jorge Luis Borges, Il libro, in Oral, Editori Riuniti, Roma, 1981.
- Raymond Carver, Niente trucchi da quattro soldi. Consigli per scrivere onestamente, minimum fax, Roma, 2002.
- Raymond Carver, Il mestiere di scrivere. Esercizi, lezioni, saggi di scrittura creativa, Einaudi, Torino, 2015.
- Johann Peter Eckermann, Conversazioni con Goethe negli ultimi anni della sua vita, Einaudi, Torino, 2008.
- Murakami Haruki, Il mestiere dello scrittore, Einaudi, Torino, 2017.
- Franz Kafka, Epistolario 1902-1924, Mondadori, Milano, 1964.
- Karl Marx, Friedrich Engels, Manifesto del partito comunista, Editori Laterza, Roma-Bari, 2002
- Lilian Ross, Portrait of Hemingway, Modern Library, New York, USA, 1999.
- Philip Roth, Perché scrivere? Saggi, conversazioni e altri scritti 1960-2013, Einaudi, Torino, 2018.