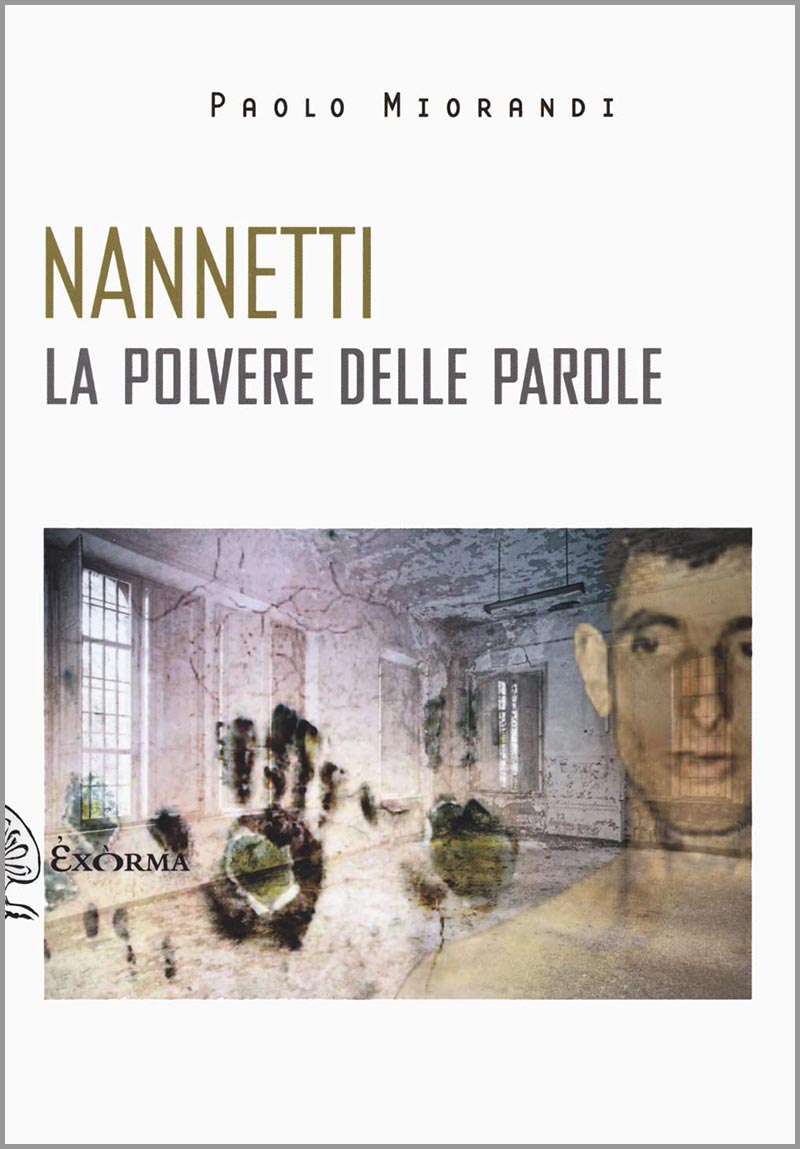La storia di Oreste Fernando Nannetti è la storia di un’autonoma possibilità di trasformazione, fuori dal disconoscimento istituzionale, di chi, ai margini del tessuto sociale, non rinuncia a essere latore di una dignità che corre in parallelo con il proprio universo, trascendendo i confini terrestri e della media dell’umana gente. Recupera questa storia fuori dall’ordinario e, in qualche modo, anticipatrice delle istanze fatte proprie da Franco Basaglia, attraverso le disposizioni normative con cui si poneva fine all’esperienza tragica dei manicomi in Italia, una recente pubblicazione di Exòrma: Nannetti. La polvere delle parole di Paolo Miorandi è un viaggio in due tempi (nel 2006 e nel 2021) nei luoghi in cui Nannetti trascorse, a partire dal 1958, molti anni della sua vita nel manicomio di Volterra dove venne condotto dopo un paio di anni di ricovero presso l’Ospedale Forlanini di Roma, non potendo scontare una pena inflittagli per oltraggio a pubblico ufficiale, perché prosciolto dall’accusa per vizio totale di mente, ma dovendo soccombere ad altra forma di prigionia all’epoca legislativamente prevista. Scrive l’autore, che si interroga anche su quanto sia rimasto di quell’atto rivoluzionario, intervenuto nel 1978 (Legge Basaglia), all’interno del sistema socio-sanitario attuale:
“I manicomi erano la rappresentazione materiale di un confine nella topografia della città e, allo stesso tempo, segnavano l’esistenza di una faglia che tagliava a metà lo sguardo dei cittadini: da una parte della fenditura ciò che sembrava chiaro, ragionevole, comprensibile, giusto, dall’altra parte l’oscuro, l’inquietante, il comunque fuori posto”.
Dunque, l’ospedale psichiatrico giudiziario quale massima espressione di un processo di separazione che, nel contenimento, anche spaziale, della pericolosità sociale di una percentuale di membri lontani dal consesso societario di maggioranza garantisce illusoriamente la tranquilla stabilità del convivere quotidiano. Se esiste un luogo predeterminato in cui fare confluire ciò che destabilizza, altera i propri fragili equilibri, incute paura, intimorisce perché non spiegabile alla luce dei canoni ordinari della ragione, allora può essere facilmente rimosso anche ciò di cui la psicosi manifesta è un potente indizio: che lo scombinamento delle carte che ci offrono la garanzia di una rassicurante normalità non è la tara di una malattia che, nell’ottica del calcolo probabilistico, può investire un nucleo familiare piuttosto che un altro, ma l’abisso dietro l’angolo alla portata di tutti. Perché, come sosteneva Basaglia, la conversione concettuale della follia nello stadio più scientificamente semplicistico della malattia procede parallelamente al tentativo di ricondurre l’irrazionale negli angusti, ma più rassicuranti confini della dittatura della ragione concepita in termini assoluti, tenendo distinti il piano della nobiltà libera di vagare per il mondo dall’inferiorità reclusa e dimenticata.
 Le immagini del graffito qui inserite risalgono alla seconda metà degli anni Ottanta. Oggi dell’opera nannettiana rimane ben poco.
Le immagini del graffito qui inserite risalgono alla seconda metà degli anni Ottanta. Oggi dell’opera nannettiana rimane ben poco.
In fondo, la storia di Nannetti è principalmente una storia di profonda solitudine, non solo perché “era una di quelle cose per cui non c’è posto al mondo”, in una visione collettiva di accantonamento dell’alterazione nello schema sapientemente smontato da Basaglia, ma anche perché non ha nessuno al suo fianco, non si sa né si riesce a ricostruire nulla o quasi in merito alle sue origini familiari.
Oreste Fernando Nannetti sembra essere giunto dal nulla e le sagome familiari approntabili alla luce delle sue parole e delle sue lettere, prive di un indirizzo e rivolte a fantomatici destinatari, non hanno riconoscibile umana consistenza, ma sono il frutto del suo universo radicato altrove e non alle leggi terrene. Eppure le sue parole hanno in terra un testimone prezioso che le raccoglie, le tramanda, rendendo possibile oggi il ricordo del signor Nanof (come si firmava Nannetti): Aldo Trafeli, infermiere al manicomio di Volterra, dal passato di studi artistici, che, attirato dai graffiti che “il colonnello astrale” crea, avvalendosi di una cinghia di recupero, sulla parete esterna dello stesso, lungo un percorso di 180 metri di cui resta assai poco, come documentano le fotografie di Francesco Pernigo che arricchiscono il volume.
Trafeli comprende che quella storia merita di essere difesa, preservata dall’incedere del tempo e dal rischio della fragilità della memoria collettiva, dall’ostilità umana e dalla miseria dello scarto dell’inconcepibile razionale, merita di essere ascoltata e lasciata, per essere donata, integra ai posteri, facendosi fedele custode di una vita che ne racchiude un’infinità. Non fosse altro che per tutte le voci intercettate dall’«ingegnere astronautico minerario» e che nella sua opera d’arte si ricompongono in un’armonica legge universale che risponde a sottili coordinate idonee a congiungere la ramificazione del sapere per varcarlo: gli astri, gli Stati, i minerali fino all’universo siderale tutto. Superare le barriere, i confini della città-stato di Volterra, attraverso la trasmissione telepatica di voci che raccontano una storia, assai probabilmente più vera di ogni realtà storica razionalmente ricostruibile. Ma quale verità, ammesso che ne esista una?

Paolo Miorandi restituisce del signor Nanof una tale solida resistenza alla violenza dell’esterno che irrompe nelle stanze dell’ospedale di Volterra nelle forme del divieto e del controllo e una fedeltà a sé stesso, che si traduce in perseveranza e in una declinazione nuova di stabilità possibile, nell’avvio e nella prosecuzione di un’opera d’arte, riconosciuta solo dopo la sua morte ufficialmente come tale, che viene da credere che, se è mai esistito un depositario di verità nel corso del processo storico umano, questi non potrebbe essere che Nannetti lungo una linea immaginaria che non preclude accessi al misticismo e a ogni lecito approccio all’altrove. Dunque, seppure nell’impossibilità (o forse a causa di essa) di fornire un’interpretazione rigorosamente coerente alle logiche umane, persino dell’arte o, quantomeno, di quella sua percentuale che necessita di ancorarsi alla metodica comune del discernimento per offrirne una lettura, dell’opera, plausibile agli occhi degli storici, Miorandi non rinuncia all’idea che quello di Nannetti sia un mondo da esplorare, proprio nella sua enigmaticità.

Ora proprio il suo non appartenere a nulla che non sia sé stesso lo rende non solo il perfetto conduttore di insospettabili energie di provenienza non necessariamente terrestre, nell’ideale trasmutazione alchemica di voci in stimoli di un altrove, idonei a generare se non una o più verità, arte e bellezza nella correlazione tra segno tracciato, simbolo potenziale e mistero insoluto, ma anche il punto di congiunzione di più vite. Non solo la sua, ma anche quella di Aldo Trafeli che, nello sporgersi verso il signor Nanof, sa di potere rivedere qualcosa di sé, e di tutti quelli che sanno abbattere le strutture di difesa per inoltrarsi nel viaggio in un abisso atemporale in cui confluiscono e si ricompongono tutte le contraddizioni dell’esistere umano.
Non è casuale che Miorandi scelga una voce unica nella narrazione, quella di Nannetti che scivola naturalmente, con grazia e tocco lieve, nel racconto offerto da Aldo Trafeli, quasi i due fossero non due soggetti distinti, ma origine ed eco di un unico narratore che non cede, ancorato allo scrivere sulle pareti, allo sconcerto della dissoluzione che pure aleggia in ogni frammento del graffito a rammentarci lo scorrere impaziente e disordinato dei flussi sotterranei che copriamo egregiamente con le nostre presunte certezze. Recita un passaggio eloquente al riguardo:
“Il cortile, le recinzioni, le inferriate, l’intera storia di una disumana pratica di esclusione evocata e come trattenuta dal luogo, ecco l’abisso che era venuto a mancare, quello capace di accendere la terribile bellezza fiorita dal diuturno lavoro di un uomo intento a inventarsi la sopravvivenza dell’anima incidendo segni che aprissero varchi nella resistenza della materia, solchi profondi capaci di parlarci una volta ancora dell’ostinata volontà umana di testimoniare il proprio passaggio, perfino al di là della consapevolezza e dell’intenzione, di depositare una traccia, che è sempre, allo stesso tempo, anche una struggente dichiarazione di mortalità, e ciò pur nelle condizioni più ostili, in un campo di concentramento, in una prigione, nell’oscurità di una caverna alta poche decine di centimetri o nel vuoto pneumatico di un manicomio”.
Dunque, storia di Resistenza quella del “colonnello astrale” Oreste Fernando Nannetti, ma anche di denuncia (da un frammento del graffito: “10% deceduti per percosse magnetico-catodiche, 40% per malattie trasmesse, 50% per odio, mancanza di amore e affetto”), storia di esclusione e di isolamento, rispetto alla quale la dirompenza della forza vitale trova il modo di non spegnersi, si incanala nella forma della distorsione del tempo laddove lo spazio è offerto in una circoscrizione limitata e colma di solitudine. Se i confini spaziali non possono essere varcati, non resta che arredarsi lo spazio fisico assegnato, farlo parlare, dargli voce, riempirlo di sé, delle interconnessioni con altri mondi, dilatandolo in profondità, volgendo le coordinate temporali a proprio favore, non solo nel senso di una meccanica funzionale al progressivo compimento dell’opera, ma anche generando una sorta di buco nero in cui fare collassare il rigore della separazione del sapere e delle comode e non veritiere logiche terrene. È al di fuori di tutto questo che si affacciano le ombre, nel vuoto del componimento di un’armonia non canonica si muove il lato oscuro:
“Quando arrivano le ombre devo stare fermo, tenere giù la testa e infilarla sotto la coperta, non devo muovermi, devo fare finta di essere morto […]. Le ombre arrivano di notte, quando è tardi, quando le trasmissioni sono terminate e non sento più niente, in quel momento c’è silenzio dappertutto […]. Allora senti il freddo che inizia in mezzo al corpo e si allarga verso le altre parti del corpo e verso tutte le zone della pelle, senti che le cose che uno ha dentro il corpo iniziano a tremare […]. Le cose che ho dentro il corpo tremano e poi cadono giù in un buco, e non smettono mai di cadere, nemmeno dopo un bel po’ che trattengo il respiro, perché il buco in cui cadono non ha fondo”.
È nel margine notturno che il processo alchemico dell’ingegnere astronautico minerario subisce una battuta d’arresto e il peso dello stare al mondo irrompe nella dimensione della paura priva di consolazione, nell’assenza di un bacio materno e nella propria solitudine in cui darsi coraggio è solo un atto formale, provvisorio e fugace. Scrivere per Nannetti, ma anche per Miorandi, allora “assomiglia a cercare un posto dove posare cose ingombranti, in depositi che non stiano necessariamente dentro la nostra testa, che, come si sa, per funzionare ha bisogno di essere leggera e non troppo stipata di cose”: scrivere è la funzione, l’atto di liberazione, l’affronto poetico alla miseria del mondo.

Nel 1985 venne realizzato, per la regia di Paolo Rosa, un mediometraggio dedicato al nostro ingegnere dal titolo L’osservatorio nucleare del signor Nanof. Nel tentativo, narrativo e visivo, linguistico e fotografico, di ricostruzione della vita e del senso dell’opera compiuta da Nannetti, il film restituisce un’atmosfera atemporale della ricerca, un vento e una nebbia felliniana avvolgono gli indagatori, quasi una metafisica di necessario approdo a una conoscenza altra dove morire, lasciare andare le forme rassicuranti dentro cui ci imprigioniamo per sopravvivere all’abisso ai nostri margini, è il principio di una nuova vita. In una circolarità ancora da decifrare.
- Paolo Rosa, L’osservatorio nucleare del signor Nanof, Studio Azzurro Produzioni, 1985.