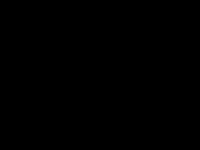“Nessuna lista di cose da fare. Ogni giornata sufficiente a se stessa. Ogni ora. Non c’è un dopo. Il dopo è già qui. Tutte le cose piene di grazia e bellezza che ci portiamo nel cuore hanno un’origine comune nel dolore. Nascono dal cordoglio e dalle ceneri. Ecco, sussurrò al bambino addormentato. Io ho te”.
Tutto qui, concentrato in poche righe. Il nucleo gelido e
disperato di La strada, l’ultimo romanzo
finora pubblicato da Cormac McCarthy (2007).
Il mondo
è ridotto al minimo: un uomo con suo figlio – o un
bambino con suo padre – di cui sono superflui anche i nomi,
appartenenti ad un passato di relazioni dimenticate, estinte, che
camminano nel nulla cinereo e nemico di una terra postatomica
semideserta e assolutamente ostile, sterile, agghiacciante. Miglia
(polverose) da percorrere e boschi (bruciati) da attraversare
– per citare Robert Frost – senza nessuna speranza
di poter davvero dormire, abbassare la guardia, recuperare dal freddo,
dalla fame, dal terrore, in un silenzio quasi assoluto, privo dei canti
degli uccelli, dei ronzii degli insetti, dello scalpitare degli zoccoli
dei cavalli.
Come nei versi di Fabrizio De André in uno degli Intermezzi di Tutti morimmo a stento (2002):
La polvere il sangue le mosche e l’odore
per strada fra i campi la gente che muore…
Solo che qui sono rimasti solo la polvere e la strada, anche
le mosche sono sparite o quasi, fa troppo freddo per sentire odori, i
corpi dei morti sono ormai già passati oltre la fase della
putrefazione…
Giusto, forse, una promessa
da mantenere, del protagonista alla propria compagna, sacrificata alla
catastrofe planetaria che fa da premessa al romanzo: portare in salvo
il bambino, regalargli la possibilità di diventare adulto.
Forse una speranza beffarda, vana, ma perseguita dall’uomo
con caparbia tenacia e ostinata determinazione lungo tutto il
romanzo.
La storia dei due – come la
strada del titolo – si snoda in uno scenario di neve putrida
e fangosa, di piogge luride di fuliggine, di erbacce putrescenti che si
sbriciolano al tocco, di polvere, sangue secco, brandelli di cadaveri
abbandonati nei canaletti di scolo di fianco alle strade – e
di polvere. Onnipresente, insidiosa, aliena.
Una Terra in cui
gli animali sono scomparsi, non solo i cani, i cavalli, i gatti, ma
anche i topi, gli scarafaggi, le bestie che fino
all’apocalisse avevano sfidato le condizioni più
avverse e dato lezione di sopravvivenza agli uomini. Rimangono pochi
esseri, una volta umani, ridotti a bestie feroci, o a larve sparute, in
un universo (sociale?) fatto di predatori e prede, selvaggi cannibali
da una parte e dall’altra subumani ridotti a schiavi o a cibo.
L’uomo
e il bambino vivono come animali braccati. Lerci, cenciosi –
senza speranze il padre, chiuso nella responsabilità di
salvare la salute mentale e la vita del figlio; animato dalle parole di
questi il bambino, e dall’illusione magica, sacrale, come
nelle fiabe, di “portare il fuoco” – ma
determinati ambedue a proseguire, a procedere nell’unica cosa
che possono fare: andare avanti cercando di sopravvivere, con
l’obiettivo di arrivare al mare, chissà alla
ricerca di cosa…
In viaggio lungo una strada che
assume la dimensione metafisica di un’ossessione, di una
coazione maniacale; unico spazio praticabile, unica dimensione
colonizzabile. Niente di più di una gabbia senza sbarre
evidenti estesa all’infinito.
Come avviene in La lunga marcia di
Stephen King (King, 2010), una parabola allucinatoria in cui ogni anno
un gruppo di cento persone deve percorrere a piedi la strada dai
confini del Canada fino a Boston per ottenere un
“Premio”, senza aiuto, senza mezzi. Una sfida
mortale, ossessionante, assoluta.
Non più quindi
una delle strade verso il futuro e l’avventura percorse da un
Jack Kerouac (Kerouac, 2006) o dagli hippies di Easy Rider
(Hopper, 2006), che aprivano alla speranza e alla ricerca, dove, in
fondo “la vera meta del viaggio è il viaggio
stesso” (ibidem), qui la meta è
essenziale, è l’unico motivo che può
spingere i due a continuare il cammino. Il mondo come lo conoscevamo si
è rovesciato su se stesso, è imploso,
è morto.
Il
mondo e l’epoca descritti da McCarthy sintetizzano i decenni
di narrazioni post apocalittiche inventate dagli scrittori di
fantascienza, riducendo il mondo del dopo alla sua dimensione nucleare:
freddo, intemperie, grigiore, sterilità, buio, violenza,
crudeltà.
Un pianeta indifferente alle sorti degli
umani – come sempre è stato, altro che
“Gea”, “Madre Terra” e tutte le
altre stupidaggini inventate da predicatori d’accatto come
guru televisivi, mistici new age o spacciatori d’ottimismo
come preti, filosofi, saggisti – che procede nel suo
“moto gelido e spietato di una terra morta senza
testamento”, mostrando così
“l’assoluta verità del mondo. Il vuoto
nero e schiacciante dell’universo” (McCarthy,
2007), un universo che se ne fotte di quell’effimero
incidente che è stata la comparsa, la crescita e la fine
dell’umanità, con il suo vaniloquente blaterare di
“civiltà”,
“cultura”, “mondo a misura
d’uomo”. L’universo sopravvive, e
può fare a meno anche della vita sulla Terra, basta che
questa continui a ruotare attorno alla sua stella per mantenere
l’equilibrio del sistema planetario di cui fa parte.
L’umanità
intanto è ridotta a branchi di selvaggi ottusi e feroci,
spietati nella loro lotta per sopravvivere, subumani rabbiosi alla
continua caccia di cibo, armi, rifugi, tornati ad una condizione
primordiale, forse quella dei primi ominidi, ma incancrenita
dall’esperienza di millenni di applicazione e
addestramento alla violenza, alla crudeltà,
all’indifferenza verso i propri simili. E anche al piacere di
praticare il Male…
Perché
questo è il punto: a differenza di chi già ne
aveva scritto, McCarthy non ha scrupoli, né peli sulla
lingua, e mostra il mondo postcatastrofe senza mediazioni di sorta. Non
ci sono buoni sentimenti, non ci sono speranze, non ci sono
prospettive. Non c’è – non ci
può essere – progetto: la Terra è
morta, figuriamoci Dio, ridotto a leggenda beffarda e stantia, a vaga e
lontana memoria, da ricordare con diffidenza e sospetto
– dopo essere stato per secoli una delle bandiere preferite
dai potenti per giustificare la sofferenza e il terrore, la
disperazione e il dolore.
Dolore e sofferenza: c’è una forte
assonanza fra la tenebrosa metafora orchestrata da McCarthy e le parole
di Alberto Abruzzese che riflettendo sul “destino
dell’umano nel mondo” scrive esplicitamente, a
proposito dell’esito della storia umana, di
“vicenda che […] può essere narrata in
altro modo: come nascita, trionfo e caduta dell’umano nel
mondo” (Abruzzese, 2011).
E ancora di
“unica realtà tangibile di cui disponiamo: quella
istintiva cognizione del dolore che la ragione sociale tende a
occultare” (ibidem), attribuita da
Abruzzese alla condizione umana in generale, certo, come spiega in
un’intervista concessaci (
www.quadernidaltritempi.eu/numero37):
“L’oggetto-soggetto di culto di questi processi alterni è stato l’individuo, l’essere umano come identità, divina e insieme mondana, posta al di sopra di qualsiasi altro essere vivente […]. Identità che è alla base di ogni sistematico fallimento dell’essere umano nella sua pretesa di distinguersi dalla violenza della natura, delle sue leggi fondate sulla potenza affermatrice e insieme mortale del più forte e sulla cecità del proprio destino […] al crepuscolo di una umanità affranta dalla crisi di ogni suo modello di sopravvivenza (si attualizza in) una sola logica, quella dello sterminio e del dolore”
che tuttavia conserva una dimensione esplicitamente politica ed economica:
“In sostanza si può dire che disuguaglianza, ingiustizia e alienazione del lavoro, dunque la sofferenza e infelicità della vita contemporanea non possono essere più considerate soltanto come dirette conseguenze dei tradizionali conflitti di classe […] ma ormai vanno definitivamente riconosciute come effetto del potere assunto da ceti dominanti che si sono formati in modo trasversale ai conflitti di classe scatenati dal capitalismo”
Così, che lo scenario immaginato da McCarthy in La
strada sia solo una metafora della condizione umana al tempo
del tardo capitalismo o una previsione del futuro che ci attende,
la verità è messa a nudo. Il destino
che attende l’umano è questo: non esiste domani,
non esiste dopo. “Il dopo è già
qui”, lercio, collassato, paludoso, eterno nel
suo orrore. Lo scrittore è spietato nella sua descrizione,
arriva ben oltre i limiti cui si erano spinti gli scrittori di science
fiction. Forse solo Friedrich Dürrenmatt ha guardato
così a fondo nell’abisso delle illusioni umane,
con un breve, lancinante racconto natalizio scritto nel 1942, in piena
barbarie nazista, Natale: “Era Natale.
Attraversavo la pianura. […] Nero il cielo. Morte le stelle.
Sepolta ieri la luna. Non sorto il sole. […] Vidi un corpo
disteso nella neve. Era Gesù Bambino. Bianche e rigide le
membra. […] Presi il bambino in mano. Gli mossi su e
giù le braccia. Gli sollevai le palpebre. Non aveva occhi.
Io avevo fame. Mangiai l’aureola. Sapeva di pane stantio. Gli
staccai la testa con un morso: Marzapane stantio. Proseguii”
(Dürrenmatt, 1988).
In questo orizzonte terminale
solo l’uomo e il bambino sembrano conservare un minimo di
quella che nel “prima” di questo mondo si chiamava
orgogliosamente “umanità”. Solo a loro
appartengono ancora sentimenti di amore, di affidamento, di fiducia, di
empatia, rivendicati dal bimbo, desideroso di compagnia e di
comunicazione, sacrificati e soffocati dal padre, ossessionato dalla
missione di salvare il figlio, in quelle rare volte che gli capita di
incontrare qualche essere vivente: un altro bambino, un cane
sopravvissuto all’estinzione delle specie viventi, massacrati
prima dall’apocalisse globale, poi dalla fame dei
sopravvissuti.
Nella parvenza di routine di vita quotidiana in
cui sono immersi i due viandanti (fuggiaschi? migranti?) quelli che una
volta erano rifiuti diventano cose preziose: barattoli di vetro,
lattine vuote, ma soprattutto accendini, cacciavite, pinze…
oggetti che da banali utensili – a volte usa-e-getta
– si innalzano al rango di tesori inestimabili, talismani che
permettono di rimanere vivi e non attraversare la soglia della morte.
Un barattolo di vetro per raccogliere acqua potabile, un cacciavite per
forzare una lattina di frutta sciroppata chissà come
sopravvissuta ai saccheggi, a riprova di come la vita sia cambiata, il
mondo si sia rovesciato: le banconote e le monete sono oggetti inutili,
arcaici, obsoleti, gli attrezzi da lavoro ne hanno preso il posto.
Tutto
si riduce al giorno per giorno, all’ora per ora. La vita,
l’identità, si restringono al loro nucleo
essenziale, io, tu, sopravvivere.
Ma a volte almeno l’adulto, desidera, si augura la fine. Come
quando, in uno dei rarissimi casi in cui ai due – e ai
lettori – Cormac McCarthy concede una pausa, l’uomo
e il bambino si imbattono in un rifugio antiatomico intatto, vi
penetrano, e conoscono un paio di giorni di pausa. Si lavano, dormono
tranquilli, mangiano, si trovano dei vestiti nuovi, asciutti, puliti,
caldi. Ma questo impatto con la memoria di un passato ormai svanito
è – sempre nella forma sfinita e sfiancante che
sembra informare tutto il comportamento dei due sopravvissuti
– devastante: durante il sonno, l’uomo sogna la
visita di creature che non riconosce. E si chiede, una volta sveglio,
che cosa significa la loro “visita”. Se sia stato
un modo, per il suo inconscio, di metterlo in guardia
contro… la speranza? un’illusione? la
vacuità del viaggio che ha intrapreso col figlio?
“Si voltò a guardare il bambino. Forse per la
prima volta capì che ai suoi occhi lui era un alieno. Un
essere venuto da un pianeta che non esisteva più. Le storie
che raccontava erano sospette. Non poteva ricostruire il mondo perduto
per compiacerlo senza trasmettergli anche il dolore della perdita
[…] non poteva riaccendere nel cuore del bambino
ciò che ormai era cenere nel suo. Anche ora, una parte di
lui rimpiangeva di aver trovato quel rifugio. Una parte di
lui continuava a desiderare la fine” (McCarthy,
2007; corsivo nostro).
E infatti, dopo un paio di giorni, i
due si rimettono in viaggio. Verso il mare. E, quando riescono a
raggiungere la costa, l’uomo cede, si concede o soccombe alla
fine. In qualche modo la sua “missione”
è compiuta. Non può fare di più.
Lascia la sua pistola al figlio, gli raccomanda prudenza, e spera che
il caso gli sia propizio. Il bambino sopravvivrà: incontra
un uomo, che dalle parole del romanzo, appare ancora capace di empatia,
di emozione, e che lo accoglie per condurlo fra la sua gente.
Chissà per quanto resisteranno. Forse tutti i
superstiti dell’apocalisse sono condannati allo sterminio.
Forse si massacreranno fra loro per un fucile, un cacciavite, una
scorta di viveri sopravvissuta. Forse, invece, il pianeta è
davvero morto, sterilizzato, come la Luna o uno dei tanti asteroidi che
ruotano silenti e ottusi nel vuoto del cosmo, e quindi non ha
più nulla da offrire ai sopravvissuti. Forse il tempo fermo,
fatto di giorni e sofferenze sempre uguali è destinato a
diventare eterno e rendere infinita una sopravvivenza primitiva,
elementare. O forse ripartirà il Tempo, ripartirà
la Storia…
Non è dato saperlo.
Forse “il dopo è già qui”.
ASCOLTI
— De André Fabrizio, Tutti morimmo a stento, Ricordi, 2002.
LETTURE
— Abruzzese Alberto, Il crepuscolo dei barbari, Bevivino, Milano, 2011.
— Dürrenmatt Friedrich, Racconti, Feltrinelli, Milano, 1988.
— Kerouac Jack, Sulla strada, Mondadori, Milano, 2006.
— King Stephen, La lunga marcia, Sperling&Kupfer, Milano, 2010.
— McCarthy Cormac, La strada, Einaudi, Torino, 2007.
VISIONI
— Hopper Dennis, Easy Rider, Sony Pictures Home Entertainment, 2006.