-
Foucault
di Paul Veyne
Garzanti, Milano, 2010
pagine 200, € 19,00
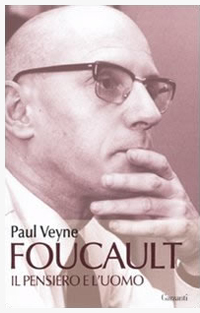
- Nelle foto sotto,
Michel Foucault, alcuni
dei filosofi citati nel testo (nell’ordine:
Francesco Bacone,
Edmund Husserl,
Michel de Montaigne,
Friedrich Nietzsche,
Gilles Deleuze)
e ancora Foucault.
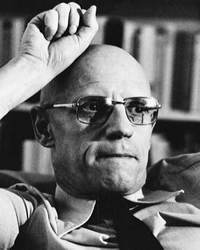






di uno scettico contemporaneo
di Livio Santoro
Diogene Laerzio, in
quell’ubertoso archivio che è Vite dei filosofi, descrive il greco
Pirrone, saggio peloponnesiaco vissuto tra il IV e il III secolo avanti Cristo,
utilizzando queste parole: “[Pirrone] diceva che niente è bello né brutto,
niente è giusto né ingiusto, e similmente applicava a tutte le cose il principio
che nulla esiste in verità e sosteneva che tutto ciò che gli uomini fanno accade
per convenzione o per abitudine, e che ogni cosa non è più questo che quello” (IX:
61). Enumerando le scuole di discepoli gemmatesi dal pensiero di Pirrone,
Diogene Laerzio annovera tra queste quella dei cosiddetti scettici, tali perché
“indagano (σκέπτεσθαι) [da cui scetticismo] e non trovano mai [la verità]” (IX:
70). Gli scettici, continua Diogene Laerzio l’archivista, nella loro dottrina
(che molti, a ragione, stenterebbero a definire dottrina) seguono il dettame di
dieci fondamentali tropi, ovvero dieci argomenti atti a negare ogni forma
di pensiero scaturito da un qualsiasi dogmatismo. Alcuni dei dieci tropi si
riferiscono alla percezione soggettiva degli individui che esperiscono ognuno a
modo proprio le cose del mondo. Altri dei dieci tropi si riferiscono allo stato
che gli enti assumono e che li rende differenti, mobili, insondabili ad un
qualsiasi sguardo, sia anche esso di per se stesso fisso e immobile (cosa da
parte sua chiaramente impossibile, almeno stando a quanto gli stessi scettici
sostengono). Altri tropi ancora si riferiscono a quelli che Francesco Bacone,
molti secoli più tardi, avrebbe definito idola theatri. Come in Bacone,
infatti, i dieci tropi costituiscono una gigantesca Pars destruens, vero
nucleo della filosofia scettica, da cui origina una Pars construens
incessante e monacale che ha le fattezze ininterrotte di quella indagine da cui
la scuola degli scettici prende programmaticamente il nome.
In questa sede, affiancati da una richiesta di indulgenza per la lunghezza e il tedio della citazione che si sta per proporre, basti riportare (quasi) per intero il quarto e il quinto della serie dei dieci tropi:
“Il quarto […] riguarda le disposizioni individuali e, in generale, il mutamento di condizioni, quali salute, malattia, sonno, veglia, gioia, dolore, giovinezza, vecchiaia, coraggio, paura, bisogno, abbondanza, odio, amore, calore, raffreddamento, oltre che la facilità o la difficoltà del respiro. La diversità delle impressioni è condizionata dalla diversa condizione delle disposizioni individuali. Neppure la condizione dei pazzi è contraria alla natura; perché essa dovrebbe riferirsi a loro più che a noi? Anche noi guardiamo il sole, come se stesse fermo. […] Il quinto tropo è relativo all’educazione, alle leggi, alle credenze nella tradizione mitica, ai patti tra i popoli e alle concezioni dogmatiche. Esso abbraccia i punti di vista su ciò che è bello e brutto, vero e falso, buono e cattivo, sugli dèi e sulla formazione e corruzione del mondo fenomenico. La stessa cosa per alcuni è giusta, per altri è ingiusta, o anche per alcuni è buona, per altri è cattiva. I Persiani non ritengono strana l’unione corporale con una loro figlia, i Greci al contrario la ritengono peccaminosa” (IX: 82-83).
Ritornando in questo modo ai giorni nostri, è chiaro che numerosi (non potrebbe essere altrimenti) sono i debiti che la filosofia contemporanea ha contratto con Pirrone e con la scuola degli scettici, basti pensare all’abusata e spesso fraintesa questione dell’epoché, recuperata tenacemente dalla fenomenologia di Edmund Husserl e poi polverizzata come lo sbuffo di un profumo esotico sulla filosofia, sulla sociologia e sull’antropologia di gusto relativistico di tutto il Novecento. Ma non è della pratica dell’epoché che s’intende discutere, né del rivolgimento verso una soggettività trascendentale a cui essa s’è dovuta piegare per mostrare la sua poco stabile attualità.
Si resti perciò sul quarto e sul quinto dei dieci argomenti dello scetticismo. Rileggendoli con una certa naturalezza, con una certa intensità, e con il tono della voce a sottolineare parole come condizione, pazzi, verità e dogmatiche, è difficile stupirsi del fatto che Paul Veyne, nel suo ultimo volume (2010), abbia sostenuto quanto da molto tempo, forse, avrebbe già dovuto far chiaramente mostra di sé. Ultimo degli scettici è stato un filosofo francese, morto di AIDS nel 1984 a causa delle usanze suggeritegli dalle pratiche della sua omosessualità: Michel Foucault. Costui ha aggiunto una voce inestinguibile a quel dibattito principiato con Pirrone quattro secoli prima di Cristo, continuato fino a Michel de Montaigne nel Millecinquecento, e poi violentemente amplificatosi alla fine del Milleottocento grazie alle parole di Friedrich Nietzsche. Ecco, Foucault è uno scettico. Tutto qui.
Il quarto tropo della scuola rappresenta quanto basta ad introdurre la prima grande opera del filosofo di Poitiers, quella Storia della follia nell’età classica che, per prima, rintracciò le strategie storiche valide nella formazione di un concetto (dove concetto non è un assoluto termine costruttivista) tanto scivoloso come la pazzia (Foucault, 2001). Il quinto tropo, invece, va bene per tutto il resto. Ecco, di nuovo, che Foucault non è nient’altro che uno scettico. Non uno strutturalista, né un teorico della de-istituzionalizzazione; chi voleva (e tuttora vuole) Foucault epigono dello strutturalismo contro ogni primato del soggetto, e chi lo immaginava (e tuttora lo immagina) come giustificatore etico-politico della promozione degli esclusi al banchetto del Signore o a quello del capitalismo commetteva (commette) in sostanza un grosso errore: per i primi l’errore consiste nel ridurre il mondo a un gioco dalle regole universali e universalmente valide, per i secondi l’errore consiste nel considerare universali non le regole, ma gli scopi (il riconoscimento dei diritti umani, per dirne solo uno). In entrambi i casi avveniva il nascondimento di un proposito furbescamente ontologico: trasferire l’Origine (quella maiuscola come maiuscolo è l’Essere che per primo fu detto da Parmenide) nelle regole della società oppure nei suoi compiti a questo punto diventati, per un motivo o per un altro, trascendentali, posti al di fuori dell’uomo e del mondo in cui quest’uomo, come attore privilegiato tra gli altri attori inconsistenti, vive. Foucault, invece, non ha proposto né l’una né l’altra cosa; Foucault, semplicemente, ha immaginato che “in ogni epoca, i contemporanei si trovano […] rinchiusi all’interno di discorsi come dentro a vasi falsamente trasparenti, ignorando che cosa siano quei vasi e perfino che essi esistano. Le false generalità e i discorsi variano nel corso del tempo, ma, in ciascuna epoca, sono considerati veri. Di modo che la verità si riduce a dire il vero, a parlare conformemente a ciò che si riconosce come vero e che un secolo più tardi farà sorridere” (Veyne, 2010, p. 21; primi due corsivi nostri). Tutto questo (sia detto al di là di qualsiasi presa di posizione valoriale) anche oltre quell’ethos esistenzialista dell’intellettuale illuminato che, a partire dagli anni Sessanta del Millenovecento, è diventato guida principale per l’eccitazione delle masse irrequiete. Ciò non significa, lo ricorda lo stesso Veyne, che, intimamente, Foucault non lottasse contro la pena di morte, per fare un solo esempio. Ma sempre come soggetto, mai come intellettuale. L’intellettuale deve restare al di fuori del dogma, qualunque esso sia.
D’altronde la chiarezza del proposito antidogmatico di Foucault rende la sua incontrovertibile evidenza già nelle prime pagine dell’Archeologia del sapere, allorché il nostro scettico afferma: “Non bisogna rimandare il discorso alla lontana presenza dell’origine; bisogna affrontarlo nel meccanismo della sua istanza” (2005, p. 35). Quello che vuol dire, in sostanza, rivolgersi alla singolarità. E qui, in questa affermazione, sta il dettame imprescindibile del lavoro del filosofo, di quello dello storico, dell’intellettuale se volgiamo, impegnato nel suo mestiere.
Il primato, ricorda Veyne, che la filosofia di Foucault ha sempre promosso non ha nulla di dogmatico, nulla di trascendentale, e nulla che, inoltre, sia ancorato al valore. L’unico a priori che essa abbia definito nella sua conformazione scettica, è proprio quello della storia, della singolarità del fatto storico. Certo, in questo modo lo scetticismo di Foucault appare mitigato: i singoli fatti storici (l’innocenza di Dreyfus, nel classico esempio) non sono passibili di dubbio, ma lo sono, e costantemente, tutti gli impianti di legittimazione che li sovrastano. Tutte le verità. La storia, allora, non è altro che un susseguirsi di singolarità, di momenti che hanno valore di per se stessi (e come tali devono essere presi, ormai dimentichi del problema dell’origine), ed in cui la verità si forma come un alone di determinazione del reale. E la verità stessa, con buona pace del filosofo e del sociologo impegnati nell’agone moderno della prescrittività, è il primo concetto da porre al vaglio dell’indagine scettica, con la stessa costanza con cui i Benedettini stringono la Regola al petto. Il ritratto della singolarità, dunque, porta con sé la sospensione preventiva della questione della continuità e, con essa, dell’immagine di una storia coerente che segue, quasi fosse un animale dotato d’anima, un suo scopo: “Bisogna dunque tenere in sospeso – sostiene ancora Foucault – tutte […le acquisite] forme preventive di continuità, tutte quelle sintesi che non vengono problematizzate e a cui si accorda pieno valore. Naturalmente non si tratta di rifiutarle definitivamente, ma di scuotere l’acquiescenza con cui si accettano” (ibidem).
Proprio a questo punto si concretizza l’insegnamento nietzscheano sempre presente nella filosofia del nostro scettico: il metodo genealogico. Fare una genealogia (o un’archeologia) vuol dire cartografare il campo strategico di formazione dei discorsi, dove anonimamente si afferma un ordine di verità, osservando come si deve che le singolarità storiche appaiano bene definite e con l’occhio attento a stanare continuamente le “quattro illusioni” caratteristiche dell’uomo e della scienza: l’adeguamento; l’universale; il razionale; il trascendentale (Veyne, 2010, p. 95). In questo modo il recupero della casualità viene tranquillamente da sé, e con Foucault si può sostenere che “… in ogni epoca l’universo storico non […è] altro che un caos di singolarità, prodotte da un caos precedente.” (ibidem, p. 90). Il caos, il maggiore dei figli legittimi di Nietzsche.
Fin qui lo scetticismo foucaultiano ha di che trovare accordi con chiunque decida di patteggiare la propria colpa (ovvero il proprio dogma), magari anche con quelle fenomenologie che sul trascendentale hanno posto le proprie fondamenta, magari anche con quegl’idealismi che all’universale hanno dato carta bianca. Ciò che invece risulta categoricamente precipuo nel foucaultismo (termine infelice, è vero!) come elemento distintivo impossibile da adeguare a qualsiasi altro ragionamento, è il ruolo dell’uomo in quella tragedia (o in quella commedia, fate voi) che è la storia che altro non è, a sua volta, che il mondo. A fronte di un cieco umanesimo fideistico Foucault oppone, come ricorda lo stesso Veyne, una forte presa di posizione sintetizzata nella potente e lirica chiosa del testo Le parole e le cose per cui lo studio futuro della natura umana avrà bisogno innanzitutto di dimenticare l’uomo, il quale sarà “cancellato, come sull’orlo del mare un volto di sabbia” (Foucault, 2004).
Se Pirrone ha promosso la fine del dogma, e se Nietzsche (2005) ha dichiarato contemporaneamente la fine della morale e la morte di dio nel trambusto profetico di Zarathustra, Foucault racconta della fine dell’antropocentrismo millenario, senza alcun proposito messianico e, per quanto sia complicato ammetterlo, senza sottrarre al soggetto quella sua intrinseca capacità di operare da sé, quel tratto caratteristico che prende il nome di estetizzazione, stile, ovvero lavoro del soggetto sul sé (con la lettera minuscola, si faccia ben attenzione). In effetti è proprio a questo dato, a questa supposta perdita, che gli irriducibili sostenitori dell’identità Foucault-strutturalismo – Veyne, tra l’altro, ricorda che il termine struttura non compare mai negli scritti di Foucault (Veyne, 2010, p. 111) – hanno in ultima ratio fatto appello al cospetto del tribunale della discussione filosofica. Per costoro i discorsi, data la loro formazione anonima, diffusa e onnicentrica, impediscono al soggetto un’azione attiva e indipendente. Ma l’indipendenza è una cosa, l’attività è un’altra. Indipendenza è, infatti, un termine in questo caso inadeguato, buono solo nella grottesca difesa tautologica di un solipsismo che certo non può esser condiviso. Ogni soggetto dipende sempre dal contesto (dal discorso in questo caso), e dal contesto dipende anche la sua libertà, con diversi gradi e diverse formazioni, è vero. Ogni soggetto, tuttavia, ha la capacità di conservare la spinta al lavoro su di sé, come capita fin dall’antichità classica, al modo in cui Foucault (2009) ha dimostrato nel suo più recente studio sulla sessualità. “Il soggetto non è costituente, è costituito, così come lo è il suo oggetto, ciononostante resta libero di reagire grazie alla sua libertà, e di prendere distanza grazie al pensiero” (Veyne, 2010, p. 109). Questa capacità del soggetto ha, come già s’è sostenuto, un nome: estetizzazione.
Ma per non scontentare nessuno Foucault pone, accanto all’estetizzazione, sull’altro piatto della bilancia (per restare sulla metafora sopra proposta del tribunale della discussione filosofica) la soggettivazione. Quest’ultima rappresenta appieno quanto gli apostoli delle versioni ipersocializzate del reale promuoverebbero freneticamente a categoria inalienabile dell’analisi sociale: il giogo imposto da un aggregato dai contorni opachi ad un singolo dai contorni, invece, ben definiti.
“Così come, senza un discorso, non ci sarebbero per noi oggetti conosciuti, non esisterebbe soggetto umano senza soggettivazione. Generato dal dispositivo della propria epoca, il soggetto non è sovrano, ma figlio del suo tempo; non tutti i soggetti sono possibili in ogni epoca. In compenso, si può reagire contro gli oggetti e, grazie al pensiero, prenderne distanza, dalla religione come da Chiesa e clero, per esempio” (ibidem, p. 117). In questo modo Veyne, con una delle sue usuali sottolineature sull’arbitrarietà di ogni forma religiosa (quella cristiana è la privilegiata nei suoi attacchi), chiude sulla libertà del soggetto, dicendo con altre parole ciò che del pensiero di Foucault ha detto anche Gilles Deleuze, perché estetizzazione e soggettivazione non sono altro che due accidenti di un evento, l’uomo, altrettanto accidentale: “Al di sotto dell’universale ci sono giochi di singolarità, emissioni di singolarità; l’universalità o l’eternità dell’uomo sono allora solo l’ombra di una combinazione singolare e transitoria portato di uno strato storico” (Deleuze, 2002, p. 121). Nessuno ha messo l’uomo dove si trova, e ciò che è successo, se così si può dire, è iniziato a capitare solo per caso. Niente ontologia, dunque, e nessun universale, ma un’incessante ricerca a partire dalla storia, questo sì, come un sigillo scettico messo a fuoco vivo sull’indagine genealogica.
Letture
× Deleuze G., Foucault, 1986, trad. it. Foucault, Cronopio, Napoli, 2002.
× Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, Laterza, Roma-Bari 2005.
× Foucault M., Histoire de la folie à l’àge classique, 1972, trad. it. Storia della follia nell’età classica, Rizzoli, Milano, 2001.
× Foucault M., Les mots et les choses, 1966, trad. it. Le parole e le cose, Rizzoli, Milano, 2004.
× Foucault M., L’archéologie du savoir, 1969, trad. it. L’archeologia del sapere, Rizzoli, Milano, 2005.
× Foucault M., Le souci de soi, 1984, trad. it. La cura del sé. Storia della sessualità 3, Feltrinelli, Milano, 2009.
× Nietzsche F., Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen, 1885, trad. it. Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno, Adelphi, Milano, 2005.
© quadernidaltritempi.eu no. 28 - 2010