BUSSOLE | QDAT 63 | 2016
LETTURE / ANTOLOGIA DI SPOON RIVER
di Edgar Lee Masters / ilSaggiatore, Milano, 2016 / 643 pp., € 24,00
Versi funamboli in tempi passeggeri
di Maria Cristina D'Alisa
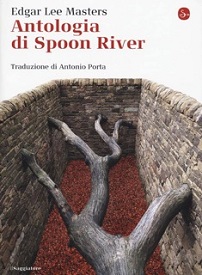
Per i tipi de ilSaggiatore è stato pubblicata una nuova edizione dell’Antologia di Spoon River di Edgard Lee Masters, nella traduzione di Antonio Porta, scrittore, poeta, traduttore tra i più versatili del nostro Novecento. Nel centenario della prima edizione integrale dell’Antologia, la casa editrice milanese intende proporre ai lettori italiani una pubblicazione con tre composizioni inedite, la Spooniade, pometto epico incompiuto a firma di un abitante del leggendario villaggio americano, Jonathan Swift Somers, la Genesi di ‘Spoon River’ e l’Epilogo, due scritti che rivelano il dietro le quinte di una trama e della sua ambientazione.
“… cominciai a sognare anch’io insieme a loro, poi l’anima d’improvviso prese il volo…”
Perché forse è così che conosciamo Spoon River. 1971, Non al denaro non all’amore né al cielo, un Fabrizio De André da noi tutti incontrato per la prima volta “col cuore ormai sulle labbra”, in una canzone sussurrata sulla nuda manciata di qualche accordo di chitarra. Non ce ne vorrà l’apollineo Platone se ci si permette un temerario accostamento, ma le parole si incrociano nei ricordi dei lettori più classicisti e un epigramma affiora, tra quelli che al filosofo è da sempre piaciuto attribuire senza troppe certezze, da noi così tradotto con piglio maldestro: “Nel bacio ad Agatone, sulle labbra sentii l’anima, che, malinconica, volle librarsi in volo”.
Ma tra lo snodarsi di un distico greco dell’avanti Cristo come si approda alla moderna melodia di una chitarra? Eh beh, nel mezzo c’è stata un’inaspettata America, c’è stato un avvocato del Midwest, Edgard Lee Masters, c’è stata, per l’appunto, l’Antologia di Spoon River (1915, prima edizione; 1916, edizione integrale), c’è stato un epigramma, in particolare, a ricongiungere un tempo classico ad uno moderno: “In quel pomeriggio di giugno, / al fianco di Mary / mentre la baciavo con l’anima sulle labbra, / l’anima d’improvviso mi fuggì”. È l’ultimo battito di Francis Turner, abitante della immaginaria Spoon River, nell’interpretazione della prima traduttrice italiana dell’Antologia nel 1943, Fernanda Pivano, colei che definì queste pagine il suo talismano e le tradusse rigandole con la commozione di più di una lacrima.
Ecco, allora, procediamo con ordine e chiediamoci come “un’anima in volo” abbia legato in un ordito unico il lirismo del Mondo classico, Masters, Pivano, De André, e perché la scelta di rieditare ancora oggi la traduzione dei versi in questione, assieme all’intera Antologia di Spoon River, con la prestigiosa sfraghìs di Antonio Porta. Non sarà perché i giorni affannosi di ogni epoca di transizione vivano la sotterranea e rischiosa esigenza di fissare sul fondo vuoto della quotidianità una sensazione o un sentimento, che ci rivelino il nostro passaggio e ci consentano di esistere oltre e durante la faticosa ricerca di un senso? Cogliere, attraversare, capire, trattenere l’attimo passeggero per recuperare il privilegio della presenza, prima che le nostre tracce sprofondino al di là delle rive del non-ricordo? Per riflettere su un’ipotesi simile bisogna partire da chi quegli epigrammi ha scelto di comporli o tradurli. Nella fattispecie, da Spoon River, dalle sue fonti, dalle successive interpretazioni.
“Avevo preso l’abitudine di appuntarmi le idee, o persino le poesie, sul retro delle buste, sui margini dei giornali, mentre mi trovavo in tram, o in tribunale, oppure a pranzo, o di notte quando ero già andato a letto” (Masters, 1933). E ce lo immaginiamo davvero come in questa sua descrizione, l’avvocato Masters, acrobata tra fogli in bilico, ad annotare febbrilmente una folgorazione poetica, dopo un biglietto vidimato, tra il brusio dei passanti, alla prima brezza calda da una finestra spalancata sulla notte, nell’incanto della Quinta di Ludwig van Beethoven.
Edgard Lee Masters nasce nel 1868, trascorrendo l’infanzia a Petersburg e l’adolescenza a Lewiston, in Illinois, sul fiume Spoon. Masters aveva studiato il greco ed il latino al Liceo, passione, questa per le Lettere, intralciata da quella carriera legale che suo padre imponeva a lui in eredità, suo malgrado. Decisamente, suo malgrado! Eppure, la frequentazione dei luoghi dell’avvocatura gli valse lo scorcio della diversità e dello stupore di incontri popolosi. Intanto, leggeva e tracciava versi sparsi, come poteva. Fino alla fuga verso la città, verso Chicago, dove Lee imparò a confrontare il vecchio e il nuovo, per accorgersi che gli abitanti dei villaggi di campagna del suo passato dolceamaro non sfiguravano poi mica tanto rispetto alla duplicata ma pur stereotipata popolazione dell’urbe. Senza troppe accelerazioni, freni e salti, l’intreccio narrativo di un villaggio gli appariva solo come riduzione in scala della stessa epica cittadina. Ma a questa esperienza mancava una forma geometrica, un po’ dantesca, che fissasse nella misura di unico racconto l’universalità umana del dolore come dell’allegria. Ed è qui che torna protagonista il mondo classico. Nel 1909 il direttore di un giornale di St. Louis passa al suo amico Masters un suggerimento di lettura, stravagante nella forma e nei contenuti per un tempo moderno, l’Antologia Palatina, un arpeggio affascinante di epigrammi greci dal I sec. a. C. al IX d. C., ospitati nelle biblioteca Palatina di Heidelberg in ben quindici volumi suddivisi per argomento, a raccogliere tutta l’umana sensibilità in pagine eterne di “fiori scelti” (non a caso un’antologia, dal gr., ánthos, fiore – légo, scelgo). Un’illuminazione per Lee. Una forma letteraria possibile. L’epigramma. Genere letterario che qualcuno paragonerebbe audacemente a un contemporaneo twitter, dai caratteri limitati e dall’arguzia come prerogativa imprescindibile di espressione. Una forma poetica più disinvolta di un poema, ma capace di accogliere in pochi versi la saggezza di chi ha molto vissuto o molto rinunciato.
Come suggerisce la parola stessa, l’epigramma all’atto di nascita venne registrato come iscrizione, funebre o commemorativa, su materiale durevole quale bronzo o pietra. Da questa destinazione ne mutuò la sua brevità specifica, mantenuta nei secoli avvenire, visto il successo riscosso dalla sua immediata fruizione. E, per brevità chiamato letteratura, l’epigramma si è moltiplicato nei secoli fino a diventare il ritmo di qualsiasi linea retta, curva, trasversale (e pure un po’ a zigzag) dell’esperienza umana. Difatti, si affrancò ben presto dalle venature scrostate di una lapide per approdare tra banchetti fastosi, sussurrati vaticini, descrizioni di magnificenze regali, ma soprattutto tra amori conturbanti e odi accesi. Insomma, guadagnò la speciale posizione di genere democratico per varietà tematica e perché sponda di chiunque potesse permettersi il fregio di eroe, al modico prezzo di un’incisione reale o figurata. Un genere da eroi, sì, ma comuni.
Ma William Marion Reedy era lettore eclettico e non si limitò allo sguardo esclusivo sul mondo antico, volle proporre un’altra lettura inusuale – e un po’ “macabra” – al suo amico Lee, Thomas Gray in Elegy Written in a Country Churchyard. Avanguardia della poesia cimiteriale inglese e non, anno 1751, Europa preromantica, fermo immagine al crepuscolo di una campagna viva nel solo lamento di un gufo verso le tombe di gente un po’ anonima, verso “un Milton ignorato” (Gray, 1751). “Molti fiori nascono per sbocciare non visti, e disperdono il loro profumo nell’aria deserta” (ibidem).
Ecco la malia di un’ispirazione su Masters e sulla sua fantasmagoria di personaggi in cerca di una trama narrativa che desse loro voce. Perché non dedicare, a quanti incrociati tra un passo e l’altro, sotto un insospettabile pseudonimo, un epigramma funebre in cui fermare le contraddizioni esistenziali e restituirle, a mo’ di esperienza formativa, a un ipotetico passante di un immaginario cimitero? Da qui spiegato anche il titolo, nell’eco grata a quella lontana e pur rivoluzionaria Antologia Palatina. Quell’opera che suggerì a Lee qualcosa che era “meno di un verso ma più della prosa” (Pivano, 2014).
Prende vita così l’Antologia di Spoon River, pubblicata sul Mirror di St. Louis, in poesie sparse, dall’aprile del 1914 fino al gennaio 1915, poi in forma di libro, nell’aprile 1915. Siamo alla prima edizione, che in un breve torno “chiunque in America sapesse leggere, aveva letto” (Pivano, 1962).
Edgard Lee Masters canta l’America di anni deliranti, tra fine Ottocento e inizi Novecento, quelli di Abraham Lincoln, primo presidente repubblicano, quelli della guerra di Secessione, dell’abolizionismo schiavista, del Puritanesimo, del Proibizionismo, dell’industrializzazione, dell’urbanizzazione, dell’espansione ferroviaria.
Canta questi anni con l’intento di mostrarci un’America a riflettori spenti, senza fanfara, senza troppi perbenismi di facciata, di chi quei mutamenti frenetici li ha spesso subìti, di chi vive la provincia con la sua crisi sociale ed economica e lavora la terra, pur con i calli delle proprie mani, per vivere la libertà che il sogno americano ha da sempre promesso. Non a caso, i versi di Masters sembrano volersi abbandonare alla fiducia di “un governo del popolo, dal popolo, per il popolo” in una Nazione unita e fondata sulla libertà, quale nel Discorso di Gettysburg del 1863 Lincoln rivendicava. Ecco perché l’Antologia diventa caleidoscopio di temi vari e quotidiani, dall’amore alla guerra e alla sottile critica sociale e religiosa, dall’amarezza del vivere alla necessità di cogliere il buono che c’è intorno, perfino animati da una qualche ironia. Si tratta delle medesime tematiche, traslate nei secoli, della Palatina, tra le cui pagine, verosimilmente, Masters si imbatté anche nel famoso epigramma pseudo(?)platonico di cui sopra, facendone eco nel personaggio di Francis Turner.
E la risonanza tra Spoon River e la Palatina non si ferma a questo epigramma. Ma, come proveremo a rintracciare, si intreccia in un ordito gravido di richiami, che sembrerebbero non smentire del tutto l’ipotesi abbozzata a inizio argomentazione: l’epigramma è un genere che la letteratura predilige nei momenti di precarietà e di rabbia. Del resto, qualcuno lo ha detto per noi, facit indignatio versum, l’indignazione genera versi (cfr. Giovenale, 1931, traduzione dell’autrice, ndr).
Masters immagina un cimitero sul fiume Spoon di un ipotetico paesino dell’Illinois. Per sua stessa ammissione, le storie delineate ripercorrerebbero tracce delle sue frequentazioni, tanto negli anni di Petersburg quanto in quelli di Lewistown, abbinando nomi di uni con cognomi di altri, ma di fatto poi guadagnandosi le inimicizie della contea tutta del Sangamon, nell’ineludibile riconoscimento di tanta parte di sé. Le categorie umane sono tutte passate in rassegna in uno schema minuzioso: 19 storie che coinvolgono 244 personaggi del libro, di modo che “i pazzi, gli ubriachi e i falliti vengano prima, le persone dall’animo singolare abbiano il secondo posto, e gli eroi e gli spiriti illuminati giungano per ultimi, in una sorta di Divina Commedia” (Masters, 1933).
Ma dove ravvisare la precarietà dei protagonisti di questa Divina Commedia d’Oltreoceano e senza redenzione? Perché non partire dalle parole di Serepta Mason, che tanto suonano simili a qualche verso sopracitato dell’Elegia scritta in un cimitero campestre di T. Gray?
“Il fiore della mia vita poteva sbocciare da ogni
lato
ma un vento aspro ha impedito la crescita dei miei petali
proprio sul lato che voi nel paese non riuscivate a vedere.
Dalla polvere levo la mia voce di protesta:
non avete mai visto il mio lato fiorente!”
(Masters, 2016).
Viceversa, Tom Beatty rilancerebbe che:
“… la vita è un giocatore
molto più in gamba di noi. […]
fissa una posta difficile da conquistare;
[…] mescola le carte per catturare la tua debolezza
e non incontrare la tua forza”
(ibidem).
E Johnnie Sayre confermerebbe, a distanza di qualche “passo”:
“Padre, mai potrai conoscere
l’angoscia che afflisse il mio cuore
per la mia disobbedienza, il momento che seniti
la ruota spietata della locomotive
affondare nella carne urlante della mia gamba.
Mentre mi portavano in casa della vedova Morris
sono riuscito a vedere la scuola nella valle
che marinavo per saltare di nascosto sui treni. […]
Fosti saggio a incidere per me:
«Sottratto al male futuro »”
(ibidem).
Perché un viandante-lettore come fa a non percepirlo, tra le pagine sfogliate e le orme lasciate sulla terra umida di fianco alle lapidi, un bisbiglio tra le anime di quella collina?
Anzi, c’è chi sentiamo quasi a richiamarci con impertinenza, come Griffy il bottaio:
“Il bottaio dovrebbe conoscere tutte le botti.
Ma io conoscevo allo stesso modo la vita,
e tu che indugi tra queste tombe
pensi di conoscere la vita.
Credi che il tuo sguardo comprenda un ampio orizzonte, forse;
in verità stai solo girando intorno
all’interno della tua botte. […]
Sei sommerso nella botte di te stesso
[…] dissolvi la magia
di credere che la tua botte sia la vita!”
(ibidem).
Ecco la ragione per cui Seth Compton preciserà:
“... non uno sa che cosa è il bene
che non sappia che cosa è il male;
… non uno sa che cosa è il vero
che non sappia che cosa è il falso”
(ibidem).
E, allora, l’imperativo non ammette alcun periodo
ipotetico di sorta a Spoon River. Vivere l’attimo!
Come nel ritornello a violino del suonatore Jones:
“La terra trasfonde vibrazioni continue
dentro il cuore, e questo sei tu.
E, se la gente scopre che sai suonare il violino,
ecco, sei costretto a suonare, per tutta la vita […]
Sono finito con i quaranta acri;
sono finito con un violino scordato
e una risata scordata, e migliaia di ricordi
e non un solo rimpianto”
(ibidem).
O come nella vertigine d’amore forse tra le più celebri dell’Antologia di Spoon River, quella di Lucinda Matlock:
“[…] ho incontrato Davis
Sposati, abbiamo vissuto insieme settant’anni,
per gioire, lavorare, allevare dodici figli […]
Ho filato, tessuto, curato la casa, nutrito gli ammalati […]
Che cos’è quel che sento adesso
di sofferenza e di stanchezza,
rabbia, scontento e speranze mancate?
Figli e figlie degeneri,
la vita è troppo forte per voi,
ci vuole vita per amare la Vita”
(ibidem).
D’altronde, in questo vivere, reclama diritto di cittadinanza perfino un amore clandestino, quello di Sarah Brown, affidato alla benedizione di un lembo di Cielo senza perbenismi e recessi:
“Maurice, […]
Va’ dal quel cuore gentile che è mio marito,
che rimugina su quello che lui chiama il nostro colpevole amore:
digli che il mio amore per te, non meno che il mio amore per lui,
ha plasmato il mio destino […]
In cielo non ci sono matrimoni,
ma l’amore sì”
(ibidem).
… e in questo stesso vivere, si annida prepotentemente l’ipnosi del male, gesti che grondano corruzione ed abuso sotterraneo, il vampirismo del potere, la macchia del Puritanesimo più ipocrita, la lacerazione dello schiavismo, come nella denuncia laminata di Sexsmith, il dentista:
“Voi credete che le odi e i sermoni,
e lo scampanare delle chiese e il sangue di vecchi e giovani
martiri della verità che hanno visto
con occhi luminosi per la fede in Dio
abbiano compiuto le grandi riforme del mondo?
Voi credete che l’Inno della Repubblica
si sarebbe udito se la ricchezza-schiavo
avesse coronato il dominante dollar
nonostante la sgranatrice Whitney per il cotone,
nonostante il vapore e i laminatoi di ferro
e il telegrafo e il libero mercato bianco del lavoro? […]
O forse credete che la sala da gioco
di Johnnie Taylor e il bar di Burchard
li avrebbero chiusi se il denaro perso
e quello speso per la birra non ritornava,
in seguito alla chiusura, a Thomas Rhodes? […]
In verità, un principio morale
è come un dente cariato
che bisogna otturare con l’oro”
(ibidem).
Eppure, l’uguaglianza della morte sgretola la prevaricazione spregiudicata dei rapporti umani, nella provocazione di Case Henry. D’altronde, come non lasciarci un sorriso compiaciuto su quella pagina-lapide? Il pareggio arriva sempre…
“In vita ero l’ubriacone della
città;
quando morii il prete mi negò sepoltura
in terra consacrata.
Ciò mi portò fortuna.
Perché i Protestanti comperarono questo pezzo di terra,
e ci seppellirono il mio corpo,
accanto alla tomba del banchiere Nicholas
e di sua moglie Priscilla.
Prendete nota, anime prudenti e pie,
delle controcorrenti del mondo
che dànno onore ai morti vissuti
nell’ombra”
(ibidem).
Ecco, a voler tornare all’ipotesi di partenza, quanto della Palatina vi è poi in Spoon River? Proviamo ad individuare una simmetria un po’ ardita, ma intrigante
(la traduzione dal greco dei frammenti citati è a cura dell’autrice dell’articolo, ndr).
… la scomparsa inattesa…
“Avevi appena diciott’anni, Carisseno,
quando tua madre
ti coprì col mantello funebre, dono compassionevole di Ades.
[…]
Non canti di nozze, ma di strazio i genitori gridavano
[…]”
(A.P. 7, 468 Meleagro).
… la “vita per amare la Vita”…
“Quando Protide, citareda figlia di citareda, si
accostò al talamo nunziale,
non partecipò più alle feste delle ragazze della
provincia beotica,
ma visse con il marito cinquant’anni sereni d’amore,
e, visti i suoi figli affermati tra i coetanei,
salpò con buona navigazione verso la sede dei
beati”
(58 A. B.Posidippo, in Austin, Bastianini, 2002
[traduzione dell’autrice, ndr]).
… il refrain del carpe diem, per cui da secoli paghiamo agli Antichi il tributo dei diritti Siae...
“Non consumarti, uomo, trascinandoti in una vita
vagabonda,
oscillando senza meta da una terra all’altra.
Non consumarti: ti accolga una capanna frugale,
riscaldata da un minimo di fuoco scoppiettante […]
e un granello di sale agrodolce”
(A.P. 7, 736 Leonida di Taranto).
… l’amore dolceamaro…
“Nulla è più dolce
dell’amore: quante dolcezze vi sono,
vengono dopo quello: (a confronto dell’amore) dalla bocca
sputo
anche il miele. […]”
(A.P. 5, 170 Nosside).
“Anima della mia anima, Eliodora, con la sua dolce
voce,
dentro al mio cuore la scolpì Eros in persona”
(A.P. 5, 155 Meleagro).
“Con Ermione un giorno scherzavo, matrona di cuori,
che aveva ricamata una cintura di fiori;
ed in oro la scritta «Mi devi amare tutta»,
senza afflizione all’idea che mi possieda anche un
altro”
(A.P. 5, 158 Asclepiade).
… la brutale leggerezza di una coppa di vino di troppo…
La vecchia Maronide, amante del vino, spugna delle botti,
qui giace, e sopra la sua tomba
troneggia la coppa attica nota a tutti.
Si dispera sottoterra, mica per i figli e per il marito,
che ha lasciato bisognosi dei mezzi di sopravvivenza?
No, per una sola ragione, ché la coppa è
vuota”
(A.P. 7, 455 Leonida di Taranto).
Regni ellenistici, IV / I sec. a. C., vista sul Mar Mediterraneo, orizzonte rosso-arancio nella fragranza seducente dell’ambra, quasi li vediamo aggirarsi, i suddetti poeti della Palatina, tra il clamore cittadino, le stanze dorate dei palazzi regali, dove la vita vibra di futile ambizione, oppure calcare zolle d’erba nei sentieri di campagna, per tracciarci l’emozione obliqua di una nuova società, in cui la democrazia greca è stata calpestata dagli squadroni assordanti di Filippo il Macedone, prima, e dei suoi successori, dopo. E, laddove, la libertà di parola, l’irrinunciabile parresìa, si trasfigura in valore vintage, perché strettamente saldata all’istituto delle assemblee democratiche interdette, rimane solo la disperata e febbricitante ricerca di una modalità d’espressione di un tempo diverso. Cosa fare se la libertà vigilata impedisce alla società di trasformare e trasformarsi sotto i suggerimenti della letteratura? Cosa fare quando i sovrani di turno rivoltano le umane sorti con disegni fulminei e insindacabili, a sancire che nessun presente sarà per sempre futuro? Cosa fare quando perfino gli dèi sembrano lasciare il cielo in ipoteca all’imprendibile furore del Caso?
La risposta è in molti poeti raccolti della Palatina: scegliere una forma d’espressione che arresti e trattenga, in un qualche stringa di versi, il tempo che scivola via, perché in quel breve attimo di scrittura/lettura indietreggi l’imprevisto, la metamorfosi, l’inattingibile. La civiltà greca perde la polis, il governo del popolo, la letteratura che se ne faceva portavoce, si incontra e fonde con culture diverse e con il potere autarchico, ma sa mettere a frutto nell’epigramma una legge che salvi l’uomo dalla rovina del Caso, quella legge sovrana di moltiplicare poche parole in un eterno possibile, di plasmare un briciolo di vissuto nella chiave di volta di un’intera esistenza.
La Palatina non raccoglie solo epigrammi di età ellenistica, ma che la maggior parte degli scritti sia di quell’epoca è indiscutibile. Periodo di transizione. Genere congeniale al suo delirio.
Spoon River, cronaca americana di svolte epocali. L’epigramma ritorna. E non suona casuale la simmetria.
Ma congiungiamo i punti e torniamo in Italia. Quando arriverà da noi la suggestione di Edgar Lee Masters? Ovviamente, non nell’immediato primo Novecento. In quegli anni l’Italia sperimentava la nevrosi delle avanguardie, Futurismo, in primis, nella logica stringente di una comunicazione sempre più di rottura. Con questo non bisogna abbandonarsi all’idea di un’America ingenua rispetto ai nuovi fermenti del Vecchio Continente. Non a caso, Spoon River non figura come semplice trasposizione di un ottocentesco Realismo letterario, benché spesso questa tesi si sostenga da più parti. In quelle pagine, si saggia, sì, il dato fisico, ma altresì la presenza dell’analisi emotiva del reale e di una frantumazione della categoria di tempo, data la simultaneità di ciascuna epigrafe nell’unico tempo possibile in un cimitero, quello della memoria. Inferenze, queste, che di fatto dimostrano non una stretta adesione di Masters al manifesto del Realismo ottocentesco, bensì un riflesso di Espressionismo e Cubismo, che pur l’America stava imparando a conoscere dall’Europa. E, però, differente era l’intento comunicativo. Masters aspira alla ricerca di un sapere comune che imprima una direzione nel caos; Masters non tende all’antagonismo, all’anarchia, all’estremismo delle coeve avanguardie europee. Per tale ragione, l’Antologia sembra trovare in Italia una sua collocazione successiva al primo Novecento e in un momento anche qui decisivo nella storia del nostro Paese.
È il 1943, traduce Fernanda Pivano, dirige, nel senso più stretto del termine, Cesare Pavese, Professore di Italiano della stessa al D’Azeglio di Torino. Lee, benvenuto in Italia! Pavese, difatti, nel 1938 porta a “Nanda” ben quattro libri americani per spiegarle la differenza tra letteratura americana, appunto, e inglese, a seguito di una domanda dell’allieva in merito. La cosa suscitò sospetto nella Pivano. Perché non replicare direttamente a quell’interrogativo? Poi il prodigio. Prese un volume a caso, Antologia di Spoon River... “la aprii proprio alla metà, e trovai una poesia che finiva così «mentre la baciavo con l’anima sulle labbra, l’anima d’improvviso mi fuggì». Chissà perché questi versi mi mozzarono il fiato: è così difficile spiegare le reazioni degli adolescenti. Forse mi ricordavano un epigramma di Platone che avevo letto nell’Antologia Palatina; o forse mi piaceva che un poeta ricominciasse a preoccuparsi di quello che succede quando un uomo bacia una ragazza”. (Pivano, 1962). E traduzione fu. Quella stessa che poi Pavese si ritrovò nel cassetto in dono dall’allieva e volle assolutamente pubblicare, pur nel pieno del Fascismo, con un geniale artificio. Il Fascismo mal tollerava la letteratura americana per quelle “bizzarre” idee di libertà che essa insisteva nel legittimare. Allora, occorreva una scappatoia fantasiosa. Complice qualche santo di troppo, la pubblicazione avvenne sotto l’etichetta Antologia di S. River. E il Ministero della Cultura Popolare si affidò, senza farsi troppe domande, alla raccolta di pensieri di un santo, San River!, canonizzato al volo in una casa editrice torinese, Einaudi. Fu un successo immediato. L’Italia fascista aveva dei lettori sovversivi, bisognosi di sentirsi “rieducati” dalle storie ordinarie del country americano, dalla loro così luminosa promessa di vita, a partire dalla morte. Aveva bisogno dell’immediata risposta di un epigramma. La Pivano pagò, poi, con il carcere quella spregiudicata traduzione di un’opera contro ogni convenzionalismo. Ma esiste un eppure in ogni storia. Eppure, Fernanda Pivano si è sempre dichiarata orgogliosa di quel suo talismano. Di quel verso tradotto, a partire dal quale in Italia ci insegnò ad affidarci Non al denaro non all’amore né al cielo.
Un lettore attento imporrà un altolà! Questo è un titolo altro….è il titolo di un Altro…Eh, sì! Perché la fortuna più pop di questa antologia in Italia fu l’approdo tra le mani corpose di De André, colui che l’ha resa nota in un adattamento musicale pari all’imponenza dell’originale letterario. La sua forma un po’ beat. Il cantautore genovese lesse a diciott’anni Masters, “e l’anima d’improvviso prese il volo”! Il cerchio si chiude... lo abbiamo accennato all’inizio. 1971, esce questo concept album Non al denaro non all’amore né al cielo. Testi di De André e Giuseppe Bentivoglio, musica di De André e di un ventiduenne Nicola Piovani, allievo del nostro attualissimo premio Oscar, Ennio Morricone. Il consenso all’adattamento arriva dalla stessa Pivano, perché Spoon River valesse a uso e consumo di tutti, anche solo ad accensione di radio. E anche stavolta siamo a ridosso di anni di svolta, 1971 è filiazione diretta del terremoto sessantottino. Sebbene “Faber” mai abbia partecipato in lotta armata alla rivoluzione di quegli anni, fu pur sempre per definizione una risposta contro dogmi, pregiudizi e strapoteri. Ciò spiega il grande consenso di chi in anni ribelli non resistette alla tentazione di masticare a memoria quei nove testi che, rapidi, scivolano in musica. In più, De André si gioca la carta dell’universalità. Sfuma l’appartenenza alla provincia americana, perché i suoi personaggi siano dei tipi universali, identificabili in chiunque di noi sia alla ricerca di un’educazione del sé. Proponendo come modello soprattutto due di loro, da quanto potremmo evincere dall’intervista della Pivano al cantautore, registrata il 25 ottobre del 1971. Il suonatore Jones, che volle dedicare al violino (flauto in De André) i suoi novant’anni di vita, sfidando neve e pioggia, nel vino e nella ribellione, infischiandosene del denaro dell’amore e perfino del cielo, nella dischiusa meraviglia di vantare “ricordi tanti, e nemmeno un rimpianto”; probabilmente, l’unico personaggio che abbia saputo vivere il tempo di un ballo sotto la bianca luna. E il “malato di cuore” (Francis Turner in Spoon River), colui che vince i pregiudizi del villaggio con un gesto di coraggio, un bacio a Mary ad un battito di cuore stonato, “quando il cuore stordì e ora no, non ricordo, se fu troppo sgomento o troppo felice. E il cuore impazzì e ora no, non ricordo, da quale orizzonte sfumasse la luce”. A dimostrazione che a trionfare sulla vita sono sempre quelli capaci di amore.
Ed è con Francis Turner che siamo partiti per quest’avventura tra le metamorfosi di un epigramma, ed è con lui che ci piace concludere, ritornando all’edizione 2016 di Porta.
Antonio Porta, 2016, nuova edizione dell’Antologia. Non vogliamo forzare assolutamente l’intenzione della casa editrice, che avrà sicuramente inteso omaggiare così un centenario dalla pubblicazione integrale di Spoon River, ma diciamocelo pure, anche questi sono anni esigenti, in cui affidiamo la speranza di redenzione alla possibilità di trasformare in un verso breve e perfetto il pazzo geroglifico della contemporaneità. Non a caso, già nella sua traduzione del 1987 Porta faceva una precisazione, che torna utile soprattutto oggi: “Si è preferito tradurre «passeggero» invece che viandante o passante, per sottolineare il significato di soglia e di passaggio, oltre che di precarietà, fondamento di queste poesie. […] «Passeggero» è infatti parola colma di verità” (Porta, 1987).
Pertanto, se la soglia è da sempre luogo della scelta, che ciascun lettore scelga di non “farsi raccontare la vita dagli occhi” (De André, Un malato di cuore, 1971), piuttosto presti ascolto all’ultima invocazione con cui Masters saluta i propri versi e noi “passeggeri”:
“Com’è vano, o giovinezza, fuggire il richiamo di Apollo. Gettarsi nel fuoco, morire con un canto di primavera, se proprio devi morire in primavera. Nessuno può guardare in faccia Apollo e sopravvivere, e occorre scegliere tra morire nella fiamma o dopo anni di dolore, con le radici salde nella terra, sentendo la mano raggrinzirsi, non tanto nel tronco ma nella terribile insensibilità che si insinua nelle foglie del lauro, che continua a fiorire finché si cade. O foglie mie, troppo secche per farne ghirlande e buone soltanto per le urne alla memoria, pregiate, forse, come meditazioni per eroici cuori, che cantano e vivono senza paura”.
“… e l’anima d’improvviso prese il volo…”.
ASCOLTI
— Fabrizio De André, Non al denaro, non all’amore né al cielo, Sony Music Entertainment Italy, 2009.
LETTURE
— Colin Austin, Guido Bastianini, Posidippi Pellaei quae supersunt omnia, LED Edizioni Universitarie, Milano, 2002.
— H. Beckby, Anthologia Graeca. Edizione critica della Palatina, München 1966.
— Giovenale, Satires, edizione critica a cura di Pierre de Labriolle, François Villeneuve, Parigi, 1931.
— Thomas Gray, Elegy Written in a Country Churchyard, Londra, 1751.
— Edgar Lee Masters, The American Mercury, vol. XXVIII, n. 109, gennaio 1933.
— Fernanda Pivano, Corriere d’Informazione, 28 luglio 1962.
— Fernanda Pivano, Prefazione, in Edgar Lee Masters, Antologia di Spoon River, Einaudi, Torino, 2014.
— Antonio Porta, E. L. Masters, poeta della verità, Mondadori, Milano 1987.
