LETTURE / IL PRINCIPIO DEL PIACERE
di José Emilio Pacheco / Sur, Roma, 2015 / pp. 139, € 14,00
Ciò che l'acqua infera nasconde
di Livio Santoro
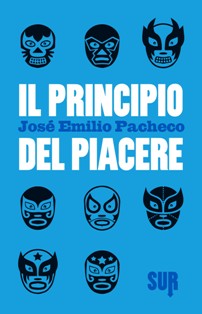
Per loro natura, i fiumi e le acque scorrono. Per loro natura, i fiumi e le acque nascondono. Ed esistono alcuni fiumi, reali o presunti non importa, che fanno di questa caratteristica la loro ragion d’essere. È il caso del Lete, corso d’acqua infero che Dante situa nel suo altro mondo, là dove le anime temporaneamente destinate al purgatorio, promosse alla più dignitosa strada ascensionale del paradiso, ne utilizzano le acque per un lavacro battesimale così da vestire con la necessaria purità la luce corrusca dell’eterna salvazione. Prima di Dante, il Lete, che dal canto suo serpeggia da millenni nelle storie dell’uomo occidentale, compare nelle classiche narrative della tradizione greco-romana, passando a ritroso dall’Eneide di Virgilio per giungere fino a La repubblica di Platone. Qui, nel X libro dell’opera, si racconta del mito germinale di Er, investigatore dell’altro mondo e della reincarnazione delle anime, costrette a bere le acque del fiume in modo da tornare alla vita dimenticando quella precedente.
È proprio la dimenticanza a caratterizzare il nostro fiume. Esso nasconde, porta nel suo letto, sottraendole al cielo e alla vista, le memorie delle vite passate, i loro residui. Del Lete, e di questa sua sensazionale caratteristica che aleggia nel mito, si è poi molto discusso nella filosofia occidentale, poiché il medesimo fiume, seguendo un corso piacevolmente anseatico, ha generato un concetto gustoso e piuttosto importante. Una delle parole greche che stanno per verità è infatti aletheia (αλήθεια), che al nome del fiume di cui stiamo parlando, il fiume dell’oblivione, antepone un’alfa dal valore privativo. La verità, questo particolare tipo di verità, può essere dunque letta come non-nascondimento, svelamento, emersione dalle acque che occultano e celano: vero è dunque ciò che viene alla luce affiorando dalle profondità per palesarsi qual è.
Prendendo spunto anche da Immanuel Kant, è stato Martin Heidegger, autore metafisico al modo di Dante e Platone, a dischiudere in epoca moderna le possibilità insite nella parola e nel concetto, traendone un significato fondo. In Essere e tempo, egli così descrive l’aletheia: “lasciar vedere l’ente nel suo non-essere-nascosto (esser-scoperto), facendolo uscire dal suo esser-nascosto” (Heidegger , 1971). La specifica verità di cui si parla è un processo di emersione, si configura come un metodo dinamico che sottrae l’ente al proprio atro e umido nascondiglio per portarlo infine alla luce.
Dunque apprendiamo (da questo e da molti altri indizi qui impossibili da elencare) che spesso i temi mitici, letterari e filosofici (posto che le tre cose non siano la stessa) sopravvivono al loro tempo e oltrepassano le collocazioni originarie. Così, l’abbiamo visto, fa il Lete; così fanno le acque infere che per loro gloria, per rimanere salde nella nostra memoria, s’insinuano in narrative anche piuttosto distanti da quelle succitate, seppure modificando per bene le loro sembianze e funzioni. Ci sembra questo il caso di parte dell’eterogenea raccolta di racconti del messicano José Emilio Pacheco, intitolata Il principio del piacere (tradotta da Raul Schenardi), le cui trame piacevolmente fantastiche di sparizioni e occultamenti sono inscindibili dal contesto che le ospita. Il Messico: un luogo denso di fantasmi e di misteri, un luogo di acque sotterranee e di faccende più o meno torbide celate alla luce del sole, il cui sottosuolo pullula di cadaveri dimenticati o da dimenticare, come ci raccontano anche delle brutte cronache piuttosto recenti.
Quando, qualche secolo fa, gli spagnoli arrivarono laggiù, trovarono un impero la cui capitale (che sorgeva sullo stesso territorio di quella che oggi è Città del Messico) era, per la fortuna del nostro ragionamento, un insediamento lacustre, circondato da corsi d’acqua e paludi, una città fatta di isole e isolette. Nel tempo, nel volgere degli anni che ha portato fino all’oggi, l’acqua che sosteneva la città è apparentemente scomparsa, occultandosi agli occhi ma restando viva e ramificata sotto o chissà dove (nell’immaginazione forse). E insieme a quell’acqua, come quell’acqua, il Messico degli ultimi decenni, lo stesso descritto da Pacheco nei suoi libri, nasconde e sottrae alla vista, coprendo con la terra umida prossima agli acquitrini o con quella secca del deserto non soltanto resti di civiltà andate via per sempre, ma anche quelli di molti dei suoi figli attuali, testimoni più o meno tardivi di una modernità che da quelle parti ha fatto del suo meglio per rendersi terribile, giocando il gioco del sangue e della prevaricazione, il gioco lungo della conquista, con il suo teorema centrale e una serie di tremendi corollari.
La storia recente del Paese nordamericano, così come quella che principia con Cristoforo Colombo e i suoi epigoni e successori, sembrerebbe allora in tutto e per tutto una storia di nascondimento che cerca in ogni modo di occultare il vero. E così quei corsi d’acqua che stanno sottoterra, come il Lete con cui abbiamo cominciato, trasportano ciò che dev’essere dimenticato, allo scopo ultimo di negare verità terrificanti. In questo caso, tuttavia, a differenza del Lete descritto dagli antichi, l’acqua infera non ha la nobile funzione di accompagnare le anime in paradiso o attraverso la metempsicosi: l’acqua sotterranea di Città del Messico fa al contrario il gioco dell’inferno, o di quello che così abbiamo imparato a chiamare dalle nostre parti.
È proprio di questo che (forse) ci parla Pacheco. È proprio questo (forse) il tema principale che sta alla base di un paio di racconti de Il principio del piacere, e parliamo in particolare di La festa selvaggia e Tenga, si distragga. Nel primo dei due leggiamo di un certo Adrés Quintana, scrittore, autore di un racconto in cui si narra la storia del capitano Keller, carnefice statunitense della guerra del Vietnam, giunto a Città del Messico per vivere una tranquilla pensione da civile. Improvvido turista, Keller sarà rapito dal sottosuolo della capitale come in un sogno, e ne verrà in un certo modo inghiottito, trasferito in classici luoghi sacrificali finché il suo corpo straziato scomparirà, trovando sorte simile a quella che toccherà al suo autore, svanito forse proprio per aver scritto male dei carnefici.
In Tenga, si distragga, invece, un investigatore privato, Ernesto Domínguez Puga, è chiamato a risolvere un caso misterioso che ha a che fare con una persona scomparsa. Si tratta del piccolo Rafael Andrade Martinez, bimbo di sei anni (figlio di un ingegnere politicamente piuttosto influente) che la madre incauta affida a uno sconosciuto gentile senza far caso all’“odore di umidità sprigionato dal suo corpo e dai suoi vestiti” d’altri tempi. Lo sconosciuto, emerso all’improvviso dal sottosuolo nei pressi del “letto asciutto di uno stagno, vicino al posto dove, a quanto si dice, si bagnava Montezuma”, e proveniente in tutta evidenza dal regno dei morti, porterà con sé il bimbo nel luogo dal quale era venuto, senza far più ritorno in superficie e lasciando il piccolo in balìa dell’umidità ctonia.
L’acqua sotterranea che aleggia in quest’umidità di vecchi canali e gallerie diventa allora, nei nostri due casi, cifra metaforica di una segmentazione nascosta del reale che genera luoghi terribili, quelli che i protagonisti dei racconti di Pacheco non conoscono, ignorano: luoghi della dimenticanza, sacche di ombra in cui nascondere il marcio di una società che della modernità ha acquisito soltanto il lato oscuro. È sottoterra che sembra vivere questo Messico di Pacheco, in un sistema venoso fatto di acque torbide che trascinano verso l’oceano corpi e immagini, affinché se ne perda la memoria e non se ne parli, in un’esiziale conca di nascondimento che stavolta non genera verità, ma che desidera invece soltanto occultarla.
“In questo mondo tutto è misterioso. Non ci sono fatti suscettibili di essere spiegati in modo soddisfacente. […] In Messico, ogni volta che si cerca un cadavere se ne trovano molti altri nel corso della ricerca”, dice Ernesto Domínguez Puga in Tenga, si distragga. E sono proprio questi cadaveri, queste persone scomparse, popolo silenzioso di sotterra, a fare in contumacia da protagonisti per buona parte della narrativa di Pacheco, una narrativa malinconica e disarmata certa del fatto che i cadaveri, una volta ricoperti dalla terra o trascinati via dalla acque, possono essere facilmente dimenticati, così come gli scomparsi. A loro, a entrambi, penseranno i vermi a tempo debito.
LETTURE
— Martin Heidegger, Essere e tempo, Milano, Longanesi, 1971.