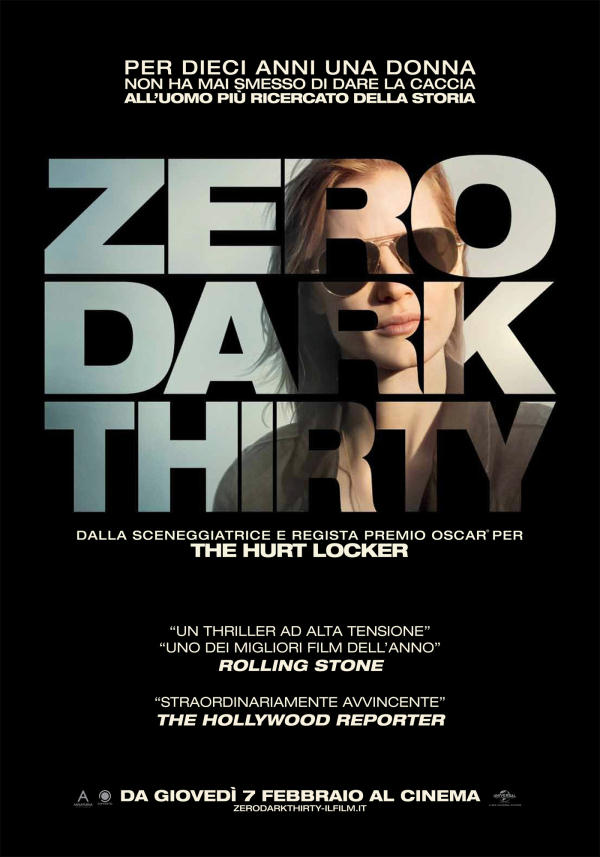VISIONI / ZERO DARK THIRTY
di Kathryn Bigelow / Universal Pictures, 2013
Caccia grossa per opere di bene
di Antonio Iannotta
Una donna, emblema di un’intera nazione, all’inseguimento disperato per dieci anni di Osama bin Laden, il most wanted, il ricercato numero uno. Ecco in estrema sintesi, quasi in un tweet, la sinossi dell’ultimo, straordinario film di Kathryn Bigelow, Zero Dark Thirty.
La prima domanda che non ci si può non porre è la seguente: e se Osama fosse stato una finzione? È quanto suggerisce indirettamente un altro recente film a stelle e strisce, di tutt’altro genere e tutt’altra sensibilità, Iron Man 3 di Shane Black. Il Mandarino, l’arcinemico che sta mettendo sotto scacco un’intera nazione – e alla berlina addirittura il supereroe più cool del momento – è solo un’astuta messa in scena mediatica, un attore interpretato da un divertente e stralunato Ben Kingsley. In combutta per giunta con un trust di cui fa parte anche il vicepresidente degli Stati Uniti…
Che sia davvero esistito Osama bin Laden, ad ogni buon conto, non sembrerebbero poterlo mettere in discussione nemmeno i dietrologi più accaniti. Su quali siano stati i suoi rapporti reali con gli Usa, da quelli che si suppone acclarati alle trame che mai vedremo disciolte, questo invece è un altro paio di maniche. Non c’entra la dietrologia, purtroppo. La storia è davvero più complicata, e opaca, di quello che sembra e che potremmo addirittura immaginarci. Osama in un certo senso configura il transito di come un alleato strategico si possa eclissare per diventare poi un acerrimo nemico della potenza che lo ha creato e riapparire infine come fantasma. E incarnazione del Male assoluto. In Zero Dark Thirty Kathryn Bigelow mette in scena, con straordinaria precisione chirurgica, la fatica fatta per riportare alla luce proprio questo fantasma creato e poi rimosso dallo stesso Occidente.
I quasi 160 minuti del film iniziano radiodrammaturgicamente al buio, con alcune registrazioni telefoniche delle persone intrappolate nel World Trade Center durante l’attacco dell’11 settembre 2001, e proseguono in un crescendo di tensione magistralmente orchestrato da Bigelow, come se si trattasse di un thriller dagli esiti incerti, fino alle 00:30 (zero dark thirty, in gergo militare, appunto) del 2 maggio 2011, quando Bin Laden viene giustiziato, in maniera sommaria e poco chiara, nel suo rifugio pakistano. Le scene terribili di coloro i quali preferirono gettarsi dalle Torri Gemelle, piuttosto che morire per il fuoco che divampava nelle strutture degli edifici collassanti, inevitabilmente popolano l’immaginazione di chi oggi si mette all’ascolto di quelle telefonate disperate. A questo orrore, Bigelow e Mark Boal, sceneggiatore e suo compagno nella vita, affiancano l’insieme delle sequenze delle sevizie a un prigioniero da parte di agenti della CIA. Il film asserisce poi subito la sua ambizione di essere un documento dell’esistente, ribadendo la veridicità delle proprie fonti: “The following motion picture is based on first hand accounts of factual events”. Come dice la regista, l’intenzione era quella di “fare un film moderno e rigoroso sull’antiterrorismo incentrato su una delle missioni più importanti e segrete della storia americana”. Un vero e proprio “reported film”, dunque, come l’hanno definito i due autori. Le polemiche non indifferenti suscitate dalla pellicola hanno probabilmente impedito al film di vincere premi davvero importanti. Agli Academy Awards il capolavoro della regista californiana ha vinto solo, a pari merito con Skyfall, l’Oscar per il miglior montaggio sonoro, mentre ai Golden Globe il film ha permesso alla bravissima Jessica Chastain di trionfare nei panni dell’agente speciale Maya come miglior attrice protagonista. In particolare il film ha suscitato un autentico vespaio nella maggiore agenzia di intelligence americana per una più che probabile fuga di notizie che avrebbe dato preziosissime informazioni di prima mano allo sceneggiatore (“first hand accounts of factual events”). Con una conferma abbastanza esplicita da parte di Michael Hayden, ex direttore della CIA dal 2006 al 2009: “Ogni riga di sceneggiatura ha una parte di verità. Gli interrogatori erano molto duri, ma grazie a questi l’agenzia ha ricavato informazioni rilevanti. E Maya è stata una vera eroina”. L’accusa mossa dagli attuali vertici della CIA, invece, amplificata dai senatori Dianne Feinstein, John McCain e Carl Levin, che hanno deciso di far luce sulla possibile cooperazione tra gli agenti di Langley e Boal, è di essere “grossolanamente inaccurato e fuorviante”, proprio nel trattare la liaison dangereuse tra i metodi d’interrogatorio della CIA e la scoperta del rifugio di Osama. Michael Morell, l’allora Acting Director dell’agenzia, ha commentato poi il film in due momenti, definendolo prima come “non realistico”, per poi aggiungere: “se furono in effetti decisive le tracce raccolte durante gli interrogatori, come suggerisce il film, è questione dibattuta che non può essere e non sarà mai appurata”. “La cosa realmente preoccupante”, conclude comunque Hayden, “è che alcuni legislatori e gli attuali vertici della CIA si siano sentiti in obbligo di intervenire in maniera così esplicita su un film”. Strano, vero?
Tutto ruota intorno al personaggio di Maya e al contrasto tra le sue caratteristiche (il suo essere donna, il suo essere diversa nei modi, anche piuttosto distanti dallo stereotipo dell’agente operativo o del burocrate di turno) e la sua determinazione implacabile che porterà a stringere il cappio intorno alla casa-fortezza di una cittadina pakistana dove si nasconde il fantasma. La costruzione del personaggio di Maya è estremamente interessante, a partire dal suo smarrimento iniziale, nel black site delle torture. In quella prigione nascosta in Medio Oriente, Maya assiste, prima inorridita poi accettando di fatto la situazione, alle sevizie su un uomo che viene picchiato, denudato, tirato al guinzaglio come fosse un cane, fatto rannicchiare in una scatola, privato del cibo e del sonno, e soprattutto sottoposto alla terribile pratica del waterboarding: immobilizzato a terra, gli viene appoggiato un asciugamano sulla faccia sul quale viene versato un flusso abbondante di acqua. La terribile sensazione inflitta parrebbe essere molto simile a quella dell’annegamento. Da una rapida ricerca, si apprende come il waterboarding sia stato usato dai tribunali dell’Inquisizione in Spagna e Olanda, dai francesi in Algeria, dai Khmer Rossi in Cambogia, in Cile da Pinochet, per rientrare poi nel portafoglio delle procedure di interrogatorio hard da parte della CIA. È insomma una tecnica da apparato poliziesco tipico delle dittature. Khalid Sheikh Mohammed, l’uomo in questione, vi sarebbe stato sottoposto per quasi duecento volte durante la sua detenzione.
La tesi proposta da Bigelow-Boal è di una chiarezza cristallina: le torture hanno raggiunto il loro scopo. Khalid Sheikh Mohammed avrebbe infatti fornito il nome del corriere di fiducia di bin Laden – Abu Ahmed al-Kuwaiti – che avrebbe consentito all’intelligence di scoprire il nascondiglio del capo di Al Qaeda. Se tutto questo fosse vero, e sembrerebbe esserlo, l’esecuzione di Bin Laden, avvenuta comunque in modo opaco, è conseguenza diretta di un abuso di potere atroce non su uno ma su molti esseri umani, oltre a essere una palese violazione delle convenzioni internazionali sulla prigionia. Ultimo atto e dimostrazione ultima di come sia ambiguo il presupposto etico delle nostre democrazie. O anche della formazione di ogni gruppo sociale. Ricordate Lost, la serie televisiva che a metà degli anni Zero ha riscritto le modalità ideativo-produttive della serialità? Anche lì, in alcuni momenti topici della lunga narrazione, si è fatto uso di tortura. Sempre giustificata da un presunto bene superiore. O ancora, per mettere in risonanza il film di Bigelow con altre due narrazioni audiovisive contemporanee, pensiamo a 24 e al recentissimo, e non ancora concluso, Homeland: in ognuna di queste serie tv ciò che è al centro della narrazione è ancora la tortura e quindi il corpo come campo biopolitico di battaglia primario, e quindi di investimento semiotico. Non c’è in Bigelow alcuna apologia dell’operato della CIA, né un’esaltazione della macchina bellica Usa. Anzi, quello che bisogna fare è cercare di guardare dietro le quinte. Non a caso l’agente speciale incaricato della caccia al pericolo pubblico n. 1 si chiama Maya: c’è un velo dietro il quale bisogna guardare per scoprire che ogni nome è un segno, segno di un corpo simbolico che agisce come una rete significante. Se spostiamo il discorso su questo piano, Zero Dark Thirty è un film sulla comunicazione, oltre che sulla biopolitica. E converrebbe leggerlo e guardarlo incrociando Marshall McLuhan con Michel Foucault. Il sistema di micropoteri incarnato dalla CIA appare nel film di Bigelow nient’altro che come una macchina tecnico-burocratica il cui unico scopo è preservare se stessa prima ancora di proteggere il Paese che dice di voler salvaguardare. Vengono allora in mente le parole di Theodor W. Adorno alla vigilia della conclusione del Secondo conflitto mondiale: “Il nemico funge da paziente e da cadavere: come gli ebrei sotto il fascismo, non costituisce che l’oggetto di misure tecnico-amministrative” (Adorno, 1994). In nome di questo principio regolatore non c’è danno collaterale o violazione di legge che tenga. L’altro nome che potrebbe aiutarci a capire meglio il film è allora quello di Giorgio Agamben. A partire dal suo concetto di stato di eccezione permanente, in cui gli Stati Uniti e in loro nome tutto l’Occidente dicono di (essere costretti a) trovarsi.
Un altro interessante film recente, Nella valle di Elah (2007) di Paul Haggis, ci ha mostrato le ferite insanabili sui corpi dei reduci della Seconda guerra del Golfo, iniziata proprio nel 2001. La velocità e capacità di reazione di una nazione consiste nel realizzare narrazioni che diano senso a eventi problematici o addirittura indecidibili. Questa missione storiografica delle arti narrative, attraverso media come il cinema, il fumetto o la letteratura, non appartiene più da molto tempo, con rarissime eccezioni, alla capacità complessiva dell’industria culturale italiana. Invece i prodotti culturali americani ci hanno abituato nell’ultimo periodo a una capacità autoriflessiva sulla propria storia e sulla propria mitografia di prim’ordine (pensiamo chiaramente anche all’ultimo film di Spielberg dedicato a Lincoln). Zero Dark Thirty, letto in questa prospettiva, non è un film sbagliato né giusto. Non prende posizione. Non cerca di spiegare. Da un certo punto di vista, è semplicemente un thriller girato magnificamente. Ma l’aspetto fondamentale è che ci pone delle domande sul nostro sociale. Senza la pretesa di fornirci delle risposte. E questo è il suo punto di forza straordinario. C’è chi crede, come Slavoj Žižek, che la narrazione di Bigelow, rifiutando di mostrare una presa di distanza da parte dei personaggi, ne favorirebbe la normalizzazione. Non credo che questa volta il filosofo sloveno abbia ragione. Non mi pare ci sia normalizzazione possibile nel discorso svolto dalla regista. Non c’è nessuna catarsi, nessuna epifania possibile.
In questi dieci anni il terrorismo ha continuato a colpire con attacchi e attentati gravissimi: a Madrid (11 marzo 2004), a Londra (7 luglio 2005), all’hotel Marriott di Islamabad (20 settembre 2008). Diversamente da quanto accaduto per il Vietnam, su cui il cinema intervenne solo con una certa distanza temporale, Bigelow (e non è la sola) interviene con grande rapidità e intelligenza su materie ancora non decifrabili. E lo fa, come già in The Hurt Locker (2008), con uno stile originale che cerca l’impressione documentaristica attraverso la finzione. Durante la scena finale dell’incursione dei Navy Seals, nell’appartamento di Abbottabad, uno dei soldati speciali, avvicinandosi alla stanza in cui è nascosto Bin Laden, sussurra il suo nome, “Osama”, e dopo averlo ripetuto alcune volte il tasso di tensione di un film già di per sé costruito su livelli di drammaticità assai elevati raggiunge il suo climax. I fantasmi, si sa, non hanno contorni ben definiti. Ma sanno sussurrare assai bene. Una volta eliminato per il Bene maggiore il nemico n.1, l’immagine finale del film ritrae Maya distrutta e in lacrime, sola nell’elicottero che la riporta a casa. L’anticlimax è devastante. Maya non è solo stravolta per la conclusione di una caccia durata dieci anni. Quel volto a pezzi rappresenta ben altro. L’identità Usa dell’ultimo decennio era stata edificata in contrapposizione al Male e al Pericolo incarnati da Osama: ora che lui non c’è più, va forse ripensata daccapo.
LETTURE
— Adorno Theodor W., Minima Moralia. Meditazioni della vita offesa, Einaudi, Torino, 1994.
— Agamben Giorgio, Lo stato di eccezione, Bollati Boringhieri, Torino, 2003.
— Bandirali Luca, Terrone Enrico, Filosofia delle serie tv. Dalla scena del crimine al trono di spade, Mimesis, Milano, 2013.
— Foucault Michel, Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979), Feltrinelli, Milano, 2005.
— McLuhan Marshall, Gli strumenti del comunicare, il Saggiatore, Milano, 1995.
— Žižek Slavoj, Zero Dark Thirty: Hollywood’s Gift to American Power, The Guardian, 25 febbraio 2013, http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2013/jan/25/zero-dark-thirty-normalises-torture-unjustifiable.