|
Io, Robot (I, Robot 1939) di Eando Binder
Quando nel 1939 questo racconto dal curioso titolo apparve sulla principale rivista americana di fantascienza di allora, Amazing, subito colpì l’attenzione di un giovane diciannovenne, Isaac Asimov. Era la prima storia di fantascienza che presentasse in luce positiva un robot, attraverso una geniale inversione di ruoli chiaramente ispirata al Frankenstein di Mary Shelley. Eando Binder, l’autore, era in realtà il nome d’arte dei fratelli Otto ed Earl Binder che conquistarono una certa notorietà con queste storie poi raccolte in un volume intitolato “Adam Link, robot”. Sarà poi Asimov a trasformare il tema del robot al servizio dell’uomo in soggetto centrale delle sue storie sui “robot positronici”, che verranno per la prima volta raccolte in un’antologia dal titolo Io, Robot. Quando Asimov fece notare al suo editore che il titolo era già stato usato nel ’39 per questo racconto e da un altro autore, la risposta fu: «’Fanculo Eando Binder!» e così Io, Robot divenne noto al grande pubblico insieme al nome di Asimov. Adam Link, il cui nome è certo indicativo, è un robot antropomorfo creato dal dottor Link, un geniale scienziato che, come vuole la tradizione, lavora isolato nel suo laboratorio assistito solo dal cagnolino Terry. Il robot impara lentamente a comportarsi come un uomo, istruito dal suo creatore che tenta di nasconderlo alla vista del pubblico temendone l’incontrollata reazione. Ma Adam Link è incapace di compiere cattive azioni, avendo imparato attraverso l’esperienza le nozioni di bene e male. Quando il suo creatore decide di farlo “debuttare” nel mondo e gli chiede cosa desidera fare di più, la risposta del robot è: “Sono stato creato dall’uomo e servirò l’uomo”. I suoi propositi devono però fare i conti con un tragico incidente: il dottor Link muore nel suo laboratorio per un banale incidente e Adam, che si trovava lì per assisterlo, viene considerato l’autore del misfatto. Si scatena una brutale caccia all’uomo – pardon, al robot – tra i boschi e le campagne, mentre Adam assistito solo dal cagnolino Terry (scene che Spielberg riprende esplicitamente nel suo A.I. Intelligenza Artificiale) tenta senza successo di far capire le sue buone intenzioni. Al termine del racconto Adam trova nel cassetto del dottor Link un libro che questi non aveva mai voluto fargli leggere: è “Frankenstein”. “E allora finalmente capii!”, esclama Adam che racconta in prima persona. “Ma è la premessa più stupida che sia mai stata fatta: che una creatura debba rivoltarsi contro il suo creatore, contro l’umanità, per il fatto di essere priva d’anima. Il libro è tutto sbagliato”. Il “complesso di Frankenstein”, come lo chiamerà poi Asimov nei suoi racconti sui robot, diventerà simbolo della reazione anti-scientista e irrazionale dell’umanità verso il progresso tecnologico. Stridente è l’immagine degli uomini che sparano su Adam senza pietà con l’intento di distruggerlo e Adam che indifeso tenta, senza successo, di spiegarsi facendo ricorso alle armi della logica e del buon senso. Il puritanesimo di Mary Shelley viene qui completamente rovesciato: anche un robot, pur privo di quell’anima che gli uomini si vantano di possedere unici nell’universo, è capace di amare e distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato sulla base dell’esperienza e del linguaggio della scienza. Earl Andrew Binder (1904-1965) e Otto Binder (1911-1974) ottennero grande celebrità nella fantascienza tra il 1939 e l’anno successivo con la serie di racconti dedicati al robot Adam Link. Ad Io, robot seguirono altri racconti che proseguirono la storia di Adam, accettato infine dalla gente comune e gradualmente divenuto un cittadino a tutti gli effetti. In realtà la maggior parte delle storie successive, più deboli, furono scritte solo da Otto, avendo il fratello Earl abbandonato la narrativa.
|
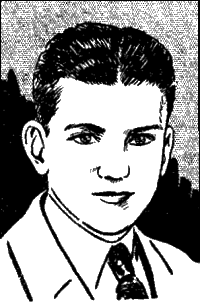 In Le grandi
storie della fantascienza n. 1, prima apparizione su Amazing
Stories gennaio 1939.
In Le grandi
storie della fantascienza n. 1, prima apparizione su Amazing
Stories gennaio 1939.