BUSSOLE | QDAT 63 | 2016
LETTURE / LE SERIE TV
di Gianluigi Rossini / Il Mulino, Bologna, 2016 / pp. 185, € 14,00
Fabbricanti di universi seriali
di Simone Vittorini
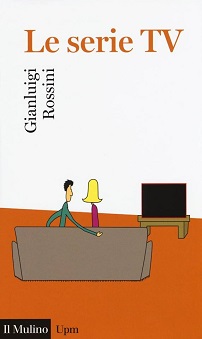
Come si mangia un elefante? La risposta è: un pezzetto alla volta.
Ed è un pezzetto alla volta che Gianluigi Rossini nel suo libro edito questo anno da Il Mulino, Le serie TV, spiega nel dettaglio come la televisione sia cambiata, mutando volto, ossa e cuore. Lo spiega in maniera didattica, essenziale, scevra da passioni, con un interesse accademico che sembra permettergli, con un sospiro di sollievo, di poter affermare che anche la serialità televisiva merita di essere studiata e che la televisione non è più quella che si credeva. O almeno non tutta.
“Fino a non molto tempo fa – scrive Rossini – un libro come questo avrebbe dovuto giustificare la propria esistenza: perché è necessario o rilevante occuparsi di serie TV?”; fino a non molto tempo fa la stessa serialità televisiva avrebbe dovuto giustificare la propria esistenza. Additata come spettacolo di basso impatto intellettuale, di scarsa qualità, raffazzonata nei dialoghi, nelle sceneggiature e negli ambienti, non aveva nulla dell’epicità del cinema e della poesia della letteratura. Al contrario la serie tv veniva trasmessa e accolta nel medium generalista per eccellenza: la televisione, il nazionalpopolare formato salotto.
Tuttavia qualcosa è cambiato, poiché negli ultimi venti anni un’altra domanda è sorta: si può parlare ancora di televisione quando, il venerdì sera ritrovandosi con gli amici, si commenta l’ultima puntata di Narcos o The Walking Dead?
Il concetto di televisione e di serie tv diventa un concetto riduttivo e talvolta erroneo, piattaforme come Netflix permettono una libera fruizione ovunque e comunque, l’oggetto feticcio dei salotti diventa veramente solo più un medium per usufruire di un servizio e non più un apparato creato e pensato per intrattenere, eppure la serialità televisiva è, per l’appunto, televisiva, poiché figlia bastarda (e talvolta misconosciuta) della Regina della casa e del Re degli appuntamenti extra-casalinghi, il cinema.
Nell’interessante e preciso volume di Rossini viene esaustivamente raccontato come e perché la cultura e la società occidentale stia subendo una vera e propria invasione di prodotti seriali: l’industria dei telefilm, la lotta tra network, le grandi sorprese, il potere degli inserzionisti, la stagnazione delle tv generaliste, l’arrivo dei canali via cavo e la rivoluzione HBO sono tutti avvenimenti che spiegano come un’attrice di una comedy riesca a guadagnare 43 milioni di dollari (dati stilati dalla rivista Forbes) e frasi come “Sta’ senza pensier” (Gomorra, 2014) o “I am the Danger!” (Breaking Bad, 2008) siano ormai diventati tormentoni.
Un salto nel passato e nella storia della televisione è doveroso certo, ma assai noioso, quasi (troppo) accademico e di sicuro privo di quel fascino mitopoietico che invece è la parte interessante e cospicua di tutta una serie di studi, articoli e volumi che coinvolgono l’idea di televisione di qualità. I così detti television studies sono la dimostrazione del prestigio culturale che la serialità televisiva ha assunto negli ultimi anni, la possibilità di sdoganare e nobilitare un prodotto che sempre più alza l’asticella di qualità e pregevole manifattura, che talvolta e spesso coinvolge grandi nomi del cinema e del teatro. I television studies aprono la porta ad una nuova generazione di studiosi che si domandano: perché le serie tv no? Perché Twin Peaks non dovrebbe essere studiato e analizzato al pari del La corazzata Potëmkin? Di sicuro sarebbe più divertente scoprire chi ha ucciso Laura Palmer che veder massacrare una folla inerme sulle scale di Odessa. Questo non vuol dire che, unendosi al grido fantozziano, bisogna scardinare grandi classici e importanti studi della cultura alta, per carità, si rischierebbe un inasprimento nella lotta tra cinefili e seriali, ma, come spiega Rossini nel suo libro, di creare (o meglio di rafforzare, poiché già esistente) un percorso di studi verso questa nuova tipologia di intrattenimento che, così giustamente, risponde al nome di quality television, poiché è di qualità che si parla.
Ma cos’è la quality tv? E cosa vuole dimostrare?
“La TV di qualità non è TV normale”, sostiene Rossini. La prima definizione è un assioma per negazione. La qualità è diventata misurabile in termini di target, il pubblico appetibile è un pubblico colto, benestante, con un profilo, un’istruzione e un portafoglio medio alto. La qualità non si riconosce più in termini di educazione, impegno civile o etico, o portatrice di valori religiosi (ovvero cristiano-occidentali), sono invece la cifra estetica, il coraggio con cui si trattano gli argomenti, spesso scottanti, i nuovi personaggi e protagonisti, i nuovi gradini della nuova scala di valore su cui si basano i critici. Eppure, grandi serie televisive come Mad Men o Breaking Bad, entrambe opere prime di un’emittente privata ai tempi quasi sconosciuta come AMC, all’inizio non furono dei grandi successi commerciali: scrive Rossini “addirittura, il loro bilancio è stato spesso in perdita: a fronte di una spesa di circa tre milioni di dollari, a episodio, le entrate dirette generate da Mad Men nella terza stagione erano scese sotto i due milioni”. Semplificando il gergo commerciale e riprendendo una definizione di J. T. Caldwell, questi prodotti sono dei loss leaders televisivi, dove per loss leaders si intende degli articoli di alto valore venduti ad un prezzo inferiore per attirare acquirenti che si suppone e si spera comprino anche altri beni. Insomma, Breaking Bad potrebbe non essere stato pensato come una rivoluzione dell’apparato mitico ed etico, ma innanzitutto come una sirena dal canto ammaliatrice pronta ad attirare itacési verso gli scogli di un palinsesto più basic.
La lotta a partire dagli anni Novanta tra emittenti, network, canali privati e generalisti, che coinvolse anche autori, sceneggiatori, produttori, fu principalmente basata sulla libertà creativa. L’HBO aveva fatto da apripista e con l’arrivo della seconda metà degli anni Zero un sempre più folto numero di emittenti televisive private si erano sedute alla grande tavola dell’abbuffata seriale portando grasse e succose pietanze. Le generaliste provarono a rispondere a tono, cercando di mostrarsi ancora loro le padroni di casa, sfornando e mantenendo grandi successi di forte impatto mediatico come Friends o ER (entrambi NBC), rimpinzando e ingrassando un goloso spettatore, che vedeva in questa nuova serialità qualcosa di innovativo e gustoso, che ben sembrava titillare la gola.
Tuttavia, nessuno era pronto alla trasformazione da grande tavola a banchetto nuziale in cui Cinema e Televisione, seduti l’uno accanto all’altro, si sarebbero promessi amore eterno (almeno finché share non li separi) dando decisamente una sferzata all’idea di serie televisiva. Adesso il pantagruelico spettatore non può far altro che chiudersi in casa, tirare giù le serrande, tirare su la copertina e ingozzarsi di innumerevoli portate che con piattaforme, quali Netflix o Amazon Prime Video, permettono di continuare a guardare nel più completo e asociale binge watching intere stagioni senza che nemmeno ci si accorga di doversi alzare per andare in bagno.
La rivoluzione artistica dell’HBO fu l’ospite a sorpresa, quello che porta l’antipasto esotico che nessuno ha mai assaggiato e di cui ci si rimpinza. Con la sua esigenza di realismo “contro l’ipocrisia della televisione normale” l’emittente via cavo ha affrontato gli argomenti più scottanti senza censure o tabù, ha permesso una libertà fino ad allora immaginabile per sceneggiatori e autori che hanno potuto investire il medium televisivo di una potenza creativa totipotente. I protagonisti delle serie tv non sono più quegli eroi positivi senza macchia e senza paura degli anni Cinquanta, non sono più i Lone Ranger del tubo catodico, ma sono spaccati di una società scomoda e reale, talvolta brutta, sporca e puzzolente, a tratti mirabolante e luccicante, ma sempre in bilico sull’orlo di una caduta o, peggio, di un baratro. La televisione si popola di difficult men (cfr. Brett Martin, 2013): ritratti psicologici di uomini pronti a tutti per i loro cari e i loro affetti, uomini sofferenti, consapevoli di essere peccatori in un mondo di peccatori, che attuano un percorso introspettivo e di auto-definizione che, proprio per questo, li pone al di sopra del cattivo letterario e cinematografico. Sono il ventre della società moderna, non sono buoni, ma come dice Walter White: “I can’t be the bad guy” (Checcaglini, 2014). Sono la sfida autoriale della nuova televisione a provare empatia per dei criminali o, ancor peggio forse, per degli uomini e donne normali.
Negli anni Novanta andava in onda in televisione (e dove se no) la pubblicità de La Fabbrica dei Mostri, la versione orrorifica del Dolce Forno, dove con un piccolo fornelletto, degli stampini e un liquido speciale si potevano creare delle sagome di orripilanti mostriciattoli il cui fine probabilmente finiva là, ma che facevano impazzire tutti i bambini. Ecco, la serialità degli ultimi dieci anni è una Fabbrica dei Mostri più grande e che fa impazzire molte più persone: è un forno mitopoietico che crea vere e proprie mitologie a Bassa Intensità (da una definizione di Peppino Ortoleva: sono tutti quei miti in cui nessuno pensa di avere fede, ma che rimbalzano da un testo a un altro, creando una fitta rete di rimandi verso cui l’uomo e la società sono portati a credere in maniera scettica e distaccata, come per esempio i vampiri o gli zombie). I personaggi delle serie televisive moderne, ancora in corso o no, non sono più solo espedienti narrativi o caratteri ben definiti: sono veri e proprio agitatori culturali che rivolgono domande extradiegetiche, che fomentano dibattiti etici pubblici e privati, che alimentano stereotipi o annichiliscono luoghi comuni. Walter White, Tony Soprano, Jax Teller, Daenerys Targaryen, Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage sono icone culturali e, da non dimenticare, prodotti commerciali con un fortissimo seguito economico. Magliette, tazze, portachiavi, poster, addirittura timbri postali e carta intestata, sono esempi lampanti di come il merchandising delle serie tv sia diventato un forte introito commerciale e di come sia entrato nelle case e nelle vite della gente non solo tramite uno schermo.
Cult o non cult si può solo constatare come gli ultimi trent’anni siano riusciti a sdoganare una visione vetusta e generalista della televisione e come bisogna rendersi conto che la serialità fa parte ormai della cultura pop e non. Se si pensa che un club di motociclisti criminali non possa rappresentare un moderno Amleto o che un professore malato di cancro inizi a produrre metanfetamina sia un’idea folle, allora non si può comprendere uno spaccato importante della cultura e della società attuale.
Gianluigi Rossini nel suo libro riporta che il “big bang della serialità contemporanea è partito dalla riscoperta televisiva dello stile serio”, una riscoperta avvenuta quando la serie serializzata è riuscita a liberarsi dal legame del broadcasting, spostando, scrive sempre Rossini, “l’interesse dagli eventi ai riempitivi, creando una frattura tra le agenzie narranti che equivale a una scomparsa della voce autorevole del narratore abbandonando ogni pedagogismo”. Insomma, la televisione si allontana dalla cattedra per scendere tra i banchi, scoprendosi più interessante, più affascinante e più, al fine, istruttiva.
LETTURE
— Martin Brett, Difficult Men. Behind the scenes of creative revolution: from the Sopranos and The Wire to Mad Men and Breaking Bad, The Penguin, New York, Usa, 2013.
— Chiara Checcaglini, Breaking Bad. La chimica del male: storia, temi, stile, Mimesis, Milano-Udine, 2014.
— Matteo Marino e Claudio Gotti, Il mio primo dizionario delle serie TV cult. da Twin Peaks a Big Bang Theory, Becco Giallo, Sommacampagna, 2016.
— Peppino Ortoleva, Il secolo dei media. Riti, abitudini, mitologie, Il Saggiatore, Milano, 2009.
