
Sul finire del 1968, Robert Wyatt, giovane musicista, batterista e cantante, in condominio con Kevin Ayers, del trio Soft Machine (con il tastierista Mike Ratledge), rientra in Inghilterra dopo un anno trascorso in gran parte suonando negli Usa. Il gruppo ha ancora un contratto discografico grazie al quale i tre hanno registrato il loro primo album, che però non ha ancora visto la luce. Gli altri due sono rientrati in Europa prima di lui e la band di fatto non esiste più, ma l’idea riparte: Wyatt riaggancia Ratledge e insieme tirano dentro il compagno di scuola Hugh Hopper, che intanto ha affinato tecnica compositiva e perizia strumentale (al basso elettrico). I Soft Machine si ricostituiscono. Il cambio di formazione non è una novità e non sarà l’ultima volta, come si vedrà in questa parte della storia di Robert Wyatt, la più cospicua della sua carriera di batterista bipede, come lui stesso si definì qualche anno dopo.
La storia inizia in una grande casa del Settecento a Canterbury, nel sonnacchioso Kent, dove si incontrano, all’inizio degli anni Sessanta, un gruppo di ragazzotti per suonare insieme. Sono dei dilettanti che cercano di andare a tempo con le loro passioni musicali, che vanno dal jazz al blues e al beat che inizia a tuonare ovunque. Pasticciano più che altro. La casa è della signora Honor Wyatt che affitta le camere a gente proveniente da ogni dove. La grande dimora si chiama Wellington House.
Suo marito, George Ellidge è stato sventuratamente colpito nel 1955 da sclerosi multipla e condannato per il resto dei suoi anni (morirà nel 1963) a vivere su una sedia a rotelle.
I coniugi Ellidge/Wyatt arrivano da Bristol e sono due fini intellettuali, amici di gente come Robert Graves, menti aperte, appassionati di musica, ascoltano Béla Bartók e Claudio Monteverdi, ma anche jazz.
Hanno avuto altri figli da coniugi precedenti. Insieme ne avranno uno: Robert Wyatt Ellidge, nato a Bristol il 28 gennaio 1945. È uno di quei musicanti in erba che, quasi giocassero ancora al piccolo chimico, provano e riprovano a legare insieme elementi instabili per natura. Lui si cimenta alla batteria e a far confusione non è da meno degli altri. La sua storia musicale per diversi anni si intreccia con quella degli altri teen ager della zona e altri ospiti della grande casa.
I personaggi fissi dentro questo laboratorio sono i già citati Hopper e Ratledge, gente della zona e compagni di scuola e il chitarrista e cantante Kevin Ayers, che non è proprio di lì, perché arriva da Herne Bay, distante un dieci miglia da Canterbury. A questi va aggiunto uno strambo chitarrista di qualche anno più grande, il vero straniero con passaporto australiano: David Allen. Il giovane Ellidge lo elegge subito a proprio mentore. Sarà Allen ad aprire le porte della percezione, tra fumo, sbronze, poesie della beat generation e il minimalismo di Terry Riley. Tra le pareti della Wellington House i composti chimici interagiscono. “Il centro era praticamente la casa di Wyatt perché era lì che si creavano il maggior numero di situazioni: sesso, droga, musica”, ricorderà poi Ayers nelle note di un triplo vinile antologico dedicato ai Soft Machine, Triple Echo.
La storia musicale della combriccola comincia a farsi chiara nel 1963, quando Allen, Hopper e Ellidge/Wyatt (allora portava ancora il cognome paterno) creano un trio di jazz e poesia e c’è Ratledge che dà una mano. Se ne vanno in giro, Parigi, Tangeri, Palma di Maiorca, conoscono Graves e poi tornano a Canterbury senza Allen. È la fine del 1964 e prende forma una band più consistente: i Wilde Flowers (la vocale e fu aggiunta da Ayres per omaggiare Oscar Wilde).

photo Collezione Richard Coughlan
Ne fanno parte Ellidge/Wyatt, Ayers, Hopper, suo fratello Brian (un sassofonista) e un altro amico del giro, Richard Sinclair (chitarrista). Il repertorio è zeppo di cover, suonano qualsiasi cosa, ma fondamentalmente sono blues oriented, ma costruiscono anche un proprio repertorio. Molte composizioni le firma Hugh Hopper, qualcuna suo fratello e diverse sono di Ayers. Ellidge/Wyatt per ora ascolta e rulla. La formazione è instabile anche per impegni scolastici e per l’altro tasso di mercurio della formula. Sinclair non c’è sempre e anche Ayers, che ha già iniziato a esplorare la via per una carriera solistica. Tra i vari tentativi, contatta anche il management degli Animals, di cui si occupa Chas Chandler, che di lì a breve avrà in portafoglio anche Jimi Hendrix.
Sarà un incontro decisivo.
Rispunta Allen e forma un quartetto, i Mister Head, con lui ci sono Ayers, Ellidge (da ora Wyatt) e Larry Nolan alla chitarra. Il gioco del piccolo chimico appassiona tutti. Nell’estate del 1966, Wyatt sente che i Wilde Flowers stanno appassendo, c’è bisogno di fare un passo avanti, in alto, di lato, insomma di uscire dallo stallo. L’alambicco si agita e spunta fuori un nuovo quintetto. Ci sono Allen, Ayers, Nolan, Wyatt e un amico ritrovato, un frequentatore della Wellington House: Mike Ratledge. Devono ribattezzarsi, ci sono in lizza denominazioni strambe come capitava a tutti i complessini dell’epoca: Dingo Virgin and The Fours Skins, ad esempio, o The Bishops of Canterbury. Tra le proposte c’è anche l’idea di riprendere il titolo di un romanzo di William Burroughs, Nova Express, ma non se ne fa nulla. Si restò però tra le pagine visionarie di Burroughs e la scelta definitiva venne fatta: il gruppo si sarebbe chiamato Soft Machine, titolo di un altro suo romanzo e vennero autorizzati dallo stesso autore.
Nolan regge poco, è l’elemento debole, così nell’autunno del 1966 i Soft Machine si ritrovano a essere un quartetto. Hanno già una carta da giocarsi, un brano scritto da Ayers, Love Makes Sweet Music e riescono a registrarlo nel febbraio del 1967 negli studi della Cbs. Il mese prima hanno registrato Feelin’ Reelin’ Squeelin’. Il primo 45 giri è pronto e la storia dei Soft Machine è iniziata. All’epoca Wyatt si alternava con Ayers al canto, il suo tremolante falsetto iniziava a incidersi su qualsiasi cosa cantasse, ma musicalmente tutto era ancora in pieno divenire. I Soft Machine all’epoca sfoggiavano un bel po’ di riferimenti colti, ma l’animo fanciullesco, divertito, curioso e confuso continua a far loro da guida. Nelle loro canzoni cuciono insieme bislacche filastrocche e primi esperimenti con i nastri, manipolando anche le voci. Nell’aprile del 1967 provano a registrare un intero album, una manciata di canzoni, molte delle quali rispunteranno in momenti decisivi della carriera di Wyatt, in particolare: Memories, I Should’ve Known e When I Don’t Want You, scritte da Hugh Hopper ai tempi dei Wilde Flowers, That’s How Much I Need You Now dello stesso Wyatt così come You Don’t Remember co-firmata con Allen. Quelle sedute vedranno la luce solo anni dopo, nel 1971, quando la francese Byg (senza il loro consenso) pubblicherà i volumi 7 e 8 della serie Rock Generation e poi in seguito ci saranno altre edizioni (sempre non autorizzate).

| photo by Mike Ellidge | photo by Jochen Mô̈nch |
Intanto Wyatt e i Soft Machine cominciano a farsi un nome tra gli ambienti più avantgarde di qua e al di là della Manica, diventando protagonisti della prima stagione underground londinese, insieme agli allora altrettanto sconosciuti Pink Floyd. Con loro partecipano, sempre in aprile, a un evento rimasto poi nella storia: il 14 Hour Technicolor Dream all’Alexandra Palace di Londra. Un viaggio memorabile in compagnia di Allen Ginsberg, Yoko Ono, Andy Warhol, i Velvet Underground, le Mothers of Invention e Pete Townshend degli Who, giusto per citarne alcuni.
Anche in Francia li apprezzano e si ritrovano sulla spiaggia di Saint- Aygulf a suonare nella discoteca Interplay per la Festa della birra e si inoltrano nell’estate restando sul mare, a Saint Tropez.
A fine agosto, quando si fa ora di tornare a casa però, accade l’imprevisto e la storia della musica, quella rock, almeno, cambiò per sempre. Il passaporto di Allen è scaduto e un ignoto doganiere lo respinge alla frontiera. Allen resta in Francia e in seguito fonderà i Gong. Ora la morbida macchina è un trio: Wyatt, Ayers e Ratledge e suonano in un altro tempietto underground londinese, il Middle Earth. Il sound è decisamente sporco, ruvido, appare evidente l’attività di laboratorio per la messa a punta di suoni e soluzioni come si addice a degli autentici sperimentatori. Eloquenti le due versioni di I Should’ve Known (brano che con altro testo venne ribattezzato So Boot If At All e pubblicato nel primo album) giocate sul fitto e imprevedibile dialogo tra basso e batteria e sul funambolico scorrazzare dell’organo. In due tracce, in particolare, si dispiega tutta la forza creatrice della band, Hope for Happines, che rispetto alla versione in studio ha una durata quasi tripla, trasformandosi in una lunga improvvisazione, prima per voce (quella di Wyatt) e poi per organo che viene lanciato a mille da Ratledge. L’analisi chimica della tastiera è ancora più radicale in un brano di quest’ultimo: Disorganization. Dissonanze, rumore, timbri sconvolti: un’eruzione di suoni che abolisce distanze tra generi allora distanti. Il miracoloso collante accosta e sovrappone il John Lord dei primi Deep Purple (quelli di Hush, per intenderci) e le escursioni solitarie all’organo di Sun Ra. Miracoli dell’epoca, anzi soluzione patafisica. Infatti, perso Allen, i tre trovano un nuovo punto cardinale nel passato: Alfred Jarry. Il primo incontro con la patafisica risale al festival di Edimburgo. Il 3 settembre c’è in cartellone Ubu enchaîné e i Soft Machine si occupano delle musiche di scena. Il mese successivo sono a Parigi per partecipare a un festival dedicato al dadaismo e alle avanguardie tout court. Vengono insigniti dell’Ordre de la Grande Gidouille dalla Società patafisica francese. Intanto le buone relazioni con Chandler, il manager di Hendrix fruttano l’ingaggio per un tour negli Usa. Più o meno nove settimane e mezzo, eccitanti e sfibranti.
La preistoria di Robert Wyatt e dei Soft machine termina qui. Prima di tornare in patria si fermano negli studi Record Plant di New York e registrano il primo ellepì. “Produttore dell’esordio ufficiale era Tom Wilson (già con Sun Ra, Cecil Taylor, Dylan, Velvet Underground...) che, come con Freak Out! di Zappa, non seguì granché le registrazioni: «buona la prima», invece, e il minimo di sovraincisioni. Il gruppo ne uscì insoddisfatto, anche se la sua bizzarra grandezza già emanava da quelle canzoni pop piene di pertur-bazioni psichedeliche e improvvisazioni jazz, dolcezze & dissonanze, batterie swinganti (Robert Wyatt), voci soul (idem) e assoli d’organo (un Lowrey Holiday Deluxe con distorsore e wha wha che costringevano felicemente Mike Ratledge a un legato stretto per evitare i feedback nei silenzi tra le note)” (Achilli, 2007). Stanchi e insoddisfatti della riuscita del disco, tornano in patria, poi ripartono per una seconda tournee negli Stati Uniti. Ayers però si defila e al suo posto entra Andy Summers, anni dopo rockstar con i Police. A settembre i Soft Machine – come si è accennato in apertura – si sciolgono, corrosi da una discreta frustrazione. La sensazione comune è che in studio non si riesca a esprimere bene la fantasia e la creatività che animano le esibizioni dal vivo. Summers, Ratledge e Hugh Hopper, all’epoca semplice roadie della band, tornano a casa. Wyatt no. Lui si ferma e per qualche mese tra una sbronza e l’altra si aggira negli studi newyorkesi e in quelli di Hollywood, i T.T.G. Studios. Il giro è quello degli artisti di Chandler. C’è Eric Burdon & The Animals, c’è Hendrix con gli Experience. Wyatt ogni tanto infila anche la sua vocina dentro alcune registrazioni, ma soprattutto è lui a registrare, o meglio a disegnare il suo futuro. In diversa misura, per anni non si saprà granché di questi appunti, note, bozzetti, schizzi, scarabocchi, studi, prove e deliri. Pratica che non sorprende, in fondo, da ragazzino voleva fare il pittore.

photo by Henie Onstad
Gli archeologi della Cuneiform Records, tra i più attrezzati in circolazione, li hanno recuperati per intero e realizzato un disco emblematicamente intitolato ’68, che comprende quattro brani di cui uno sfuggito anche alla bibbia wyattiana scritta da Michael King: Chelsa. È sempre il piccolo chimico all’opera e qui si sbizzarrisce non poco, portandosi a casa un discreto bagaglio di composti e soluzioni che riverserà in dosi diverse e in tempi differenti negli anni a venire. A iniziare da Chelsa, dal motivetto sbilenco che tornerà utile, quando un’altra morbida macchina più su misura per Wyatt inciderà nel 1972 il suo primo disco: Matching Mole. Cambierà veste, fragranze e titolo, diventando Signed Curtain, ma la canzone è quella. Nel quaderno d’appunti, o meglio nel taccuino denso di annotazioni e intuizioni che Wyatt realizzò in quei mesi spicca l’altro inedito assoluto, la spettacolare scorribanda vocale di Rivmic Melodies. Wyatt onorò qui come mai più l’autore del romanzo The Soft Machine, William Burroughs, le sue tecniche compositive (cut-up, permutazioni, fold-in), incollando su una struttura quanto mai friabile due “vecchie” composizioni dell’amico Hopper, When I Don't Want You e Have You Ever Bean Green (quest’ultima a sua volta rielaborazione di una precedente originaria Have You Ever Been Blue), che arrivavano dai tempi dei Wilde Flowers. Anche sulla reale paternità di questi materiali, però, Wyatt con la complicità di Hopper mescola le carte: il primo sostiene di essersi preso cura di creature non sue e di averle fatte maturare, ma l’amico e compagno di tante avventure musicali dice di aver messo la firma solo per questioni di diritti. Cortesie tra gentiluomini o buchi nella memoria, fatto sta che Wyatt, patafisico di fresca nomina, si ingegnò a musicare l’impossibile, anche l’alfabeto inglese e a cucire insieme il tutto lungo circa diciotto minuti di autentico cimento della follia e dell’invenzione.

photo by Henie Onstad
La logica sottesa a questa performance vocale, alle sue ripetizioni e sovraincisioni, la riprenderà al momento di incidere per la prima volta qualcosa di ufficiale a suo nome, l’album End Of An Ear (1970), ma l’idea della presentazione dell’alfabeto avrà subito una collocazione ufficiale, quando nel 1969 i Soft Machine registreranno Volume Two, un collage a incastri reso stabile da una maggiore vicinanza al jazz; uno spostamento dovuto soprattutto al lavoro di Hopper. Sarà qui che con il titolo Rivmic Melodies la prima facciata ospiterà una stramba suite composta da una successione di miniature ritagliate dall’originale registrazione di Wyatt. L’alfabeto musicato nel Volume Two dura un lampo, ma viene esposto con maggiore linearietà che nella seduta newyorchese, un’ennesima mutazione cellulare che rende bene l’idea di quante pozioni ci fossero a bollire in quella stagione, così come accade per le altre tranche della performance originaria rispetto al suo doppio, incluse le due introduzioni patafisiche, anzi una divisa in due parti, con cui si chiuderanno gli omaggi espliciti ad Alfred Jarry.
Anche l’altro brano più breve di ’68, Slow Walkin' Talk è di casa Hopper, ma in questo caso del fratello Brian (risalente sempre ai tempi dei Wilde Flowers), musicista di cui i Soft Machine si avvarranno per il secondo album, sovraincidendo alcuni suoi interventi ai sassofoni. Anche qui passato, presente (di allora) e futuro si distendono su una linee temporale obliqua. Il brano finirà per assumere movenze swinganti più disinvolte diversi anni dopo, nel terzo album solista di Wyatt, Ruth Is Stranger Than Richard (pubblicato nel 1975), cambiando anche qui testo e titolo. Diventerà Soup Song. In questa versione (già nota perché uscita in precedenza sulla raccolta Flotsam Jetsam) schizza veloce, supportata dall’ultrabasso suonato da Hendrix, che trovandosi a passare negli studi imbracciò lo strumento di Noel Redding e, pur essendo mancino, non fece una piega, suonandolo da primo della classe. Wyatt, lo ricorderà come un momento in cui gli sembrò di essere in paradiso. Il quarto brano incluso in ’68, è il più famoso del mazzo: Moon In June. Anche in questo caso il piccolo chimico si trastullò con provette e alambicchi, dissolvendo in un composto surreale due precedenti brani registrati l’anno prima per l’album zero dei Soft Machine, cui si è accennato: That’s How Much I Need You Now e I Don’t Remember, due composizioni nate dalla penna dello stesso Wyatt. Anche in questo caso non si tratta di un inedito assoluto, poiché la stessa Cuneiform Records l’aveva inclusa in una raccolta di materiali d’archivio dei Soft Machine una decina d’anni fa: Backwards.
Diversamente da Rivmic Melodies, qui Wyatt rese gli elementi originari più solubili, ottenendo un risultato più omogeneo, cioè, fuor di metafora chimica, un unico brano, quella gemma che tuttora rifulge di cristallina luce lunare, anche se prima di trovare sistemazione definitiva nello storico Third dei Soft Machine, passò ancora per affinamenti progressivi. Wyatt registrò solo la prima parte, mentre il seguito strumentale venne inciso a metà dell’anno successivo (1969) con Hopper e Ratledge. Sarà la sezione che capiterà di sentire anche in concerto, perché per canzoni del genere nei Soft Machine presto non ci sarà spazio.
Wyatt modificherà anche il testo, due volte, quando la infilerà in una seduta di giugno ’69 alla BBC (alla trasmissione Top Gear, come farà anche in novembre con Istant Pussy, poi finita nel repertorio dei Matching Mole) e di nuovo registrando Third con la versione definitiva della stessa Moon In June.
Quando nel giugno del 1970 uscirà Third, Wyatt e i Soft Machine avevano già macinato un altro bel po’ di concerti che, come per quelli tenuti nel resto dei Settanta con e senza Wyatt, verranno ripescati decenni dopo in gran numero, finendo per surclassare il numero delle uscite ufficiali.
Il nuovo spuntava ovunque in quella stagione e in particolare, nel Regno Unito, si stava facendo largo una generazione di jazzisti proprietaria di una personale visione del genere. L’anno si era inaugurato con l’uscita di un disco che agiva in sintonia e in parallelo con le scelte elettriche di Miles Davis: Elastic Rock ad opera di un gruppo chiamato Nucleus. Anche dei musicisti sudafricani esuli in Uk raccolti sotto il nome Brotherhood of Breath si erano affacciati sulla scena con un fulgido esordio e altrettanto dicasi per compositori e direttori d’orchestra come Mike Gibbs, Mike Westbrook, Graham Collier e Neil Ardley. Si facevano valere solisti di grande talento come John Surman, Mike Osborne, Alan Skidmore, Harry Beckett e Keith Tippett, Elton Dean e improvvisatori radicali come Derek Bailey, Evan Parker, Paul Rutherford, John Stevens e Trevor Watts. Non tutti inglesi, ma tutti in azione soprattutto nella capitale. Il vento del jazz investì i Soft Machine che aprono definitivamente al jazz e per farlo ricambiano formazione: entra in pianta stabile il sassofonista Elton Dean e a turno, in concerto e in studio si avvicendano altri musicisti. Alle registrazioni di Third partecipano Nick Evans (trombone), Lyn Dobson (flauto e soprano) e Jimmy Hastings (flauto e clarinetto basso).

photo by Henie Onstad
Il quarto brano, si è detto, è Moon In June, il free pop minimal/malinconico firmato e “swingato” da Wyatt. Un capolavoro dove per un attimo si sorvola sullo stridente contrasto tra la musica secondo Wyatt e quella secondo Ratledge. Questi è orientato a soluzioni algide, astratte, altrettanto visionarie ma piuttosto gelide. Wyatt è umorale, più solare, gioca e ama fare e disfare canzoni nel segno di una lucida e colta strampalaggine.
Per un anno i Soft Machine suonano in giro per l’Europa, Norvegia, Olanda, Francia, Germania, oltre che a casa propria, ma per la relazione tra Wyatt e i vecchi compagni si può ormai parlare di finale di partita. Nel gennaio del 1971 esce Fourth e l’esito finale del conflitto appare già chiaro. L’album è nel segno di Ratledge: un algido jazz elettrico, tutti i brani sono strumentali, non c’è traccia di canzoni e Wyatt non firma alcun brano. Anche Fourth presenta a tratti una formazione allargata, come nel brano di apertura firmato da Ratledge, Teeth. Gli ospiti sono tutti validi esponenti di quel jazz made in Britain a cui si è fatto cenno, da Marc Charig (tromba) a Alan Skidmore (ance) e Roy Babbington (contrabbasso). Wyatt aveva già avvertito qualcosa di sbagliato nell’aria, un’attenuazione spinta delle good vibrations e prima di registrare Fourth in novembre, aveva pensato bene di mettersi a fare la sua musica in proprio e di guardarsi in giro, frequentando vecchi e nuovi amici. Suona con Ayers e il suo Whole World, ai margini di Shooting At The Moon, frequenta il Keith Tippett Group e poi è nel colossale progetto Centipede. A lui il jazz piace e come, gioca la sua parte in un progetto mai approdato a nulla, salvo registrare qualcosa nel solito Top Gear: i Symbiosis con Mongezi Feza e Gary Windo, tra gli altri, due membri della confraternita del respiro anglosudafricana. Soprattutto fa tutto da se registrando prima di Fourth, il suo primo album solista: End of An Ear, dove si supera mandando tutto in cortocircuito, il suo passato musicale, il jazz, l’avanguardia, la psichedelia, in una manciata di brani realizzati perlopiù in solitudine (come negli studi statunitensi nel ’68), salvo qualche aiutino da amici come Elton Dean e Marc Charig, e quasi tutti dedicati ad amici e conoscenti del mondo dello spettacolo soprattutto. E poi c’è la grande eccezione: Las Vegas Tango.
Né una dedica, né una propria composizione.
Las Vegas Tango sulla carta è stata scritta di Gil Evans, geniale arrangiatore, direttore d’orchestra e compositore jazz. Ciò che accade in End Of An Ear però è una radicale decostruzione, al punto da poter affermare che quella Las Vegas Tango è di Robert Wyatt, che ne deforma la struttura originaria, la obbliga a procedere per storture letteralmente inaudite, la affoga in un flusso di vocine, rumori, capricci sonori, vocalizzi, parole in libertà, sovraincisioni su sovraincisioni, un flusso di nonsense, di storpiature, erigendo un vero manifesto della sua arte vocale e un inno all’anarchia che lo muoveva da sempre intensamente.

photo by Henie Onstad
Il brano è diviso in due parti, occupando nell’insieme metà dell’album, altri venti minuti di pura discesa nel Maelström. Las Vegas Tango dilaga ovunque nell’album e lungo tutto il tempo che ci separa da quel lavoro, mantenendo tuttora intatta la sua forza eversiva e la sua poesia al tempo stesso. Giù in profondità, su verso altezze impossibili, così Wyatt concepiva la musica, avendo sempre in mente l’invito beckettiano a continuare a fallire, fallendo meglio. Lo avrebbe continuato a fare e le cose non potevano che peggiorare con i Soft Machine. Nell’ultima stagione concertistica con la sua storica band, Wyatt si trovò confinato al ruolo di semplice batterista. Tra le tante registrazioni postume della band, è eloquente il concerto tenuto nell’ottobre 1970 al Concertgebouw di Amsterdam e ora proposto su Grides, altro titolo della Cuneiform. La performance è anche qui interamente strumentale, anche in composizioni come Esther’s Nose Job (originariamente su Volume Two), epurata dalle originali e inconfondibili variazioni scat che facevano da contrappunto all’organo di Ratledge, qui rimpiazzate dal basso. Una situazione precipitata mese dopo mese, se si pensa che proprio Grides offre anche una registrazione video del marzo 1971, effettuata negli studi di Radio Brema, il cui climax è l’improvvisazione vocale di Wyatt, incorniciata da effetti speciali psichedelici, che prende quota sulle liriche di Hope for Happiness, pezzo del primo omonimo album. Un canto del cigno. “È chiaro che stavo immaginando una vita artistica mia e non di gruppo, una musica che potessi realizzare da solo, come il pittore che avrei sempre voluto essere”, ricorda nelle note di ’68.
Per la prima volta, ma non sarebbe stata l’ultima, si chiudeva un’era. End Of An Era, Part One si potrebbe dire.
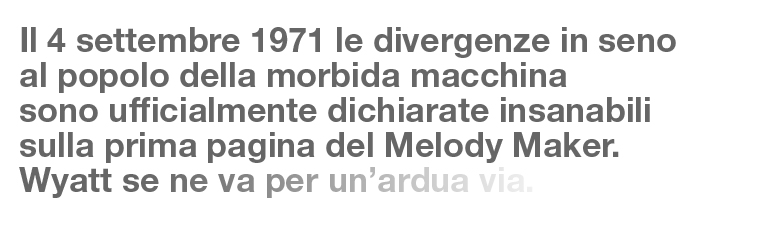
LETTURE
— Achilli Alessandro, In sette tappe gli anni fervidi dei Soft Machine, Musica Jazz, luglio 2007.
— King Michael, Falsi movimenti, una storia di Robert Wyatt, Arcana Editrice, Milano, 1994.

