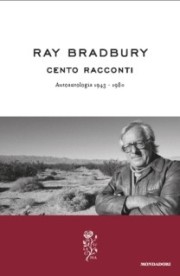LETTURE / CENTO RACCONTI. AUTOANTOLOGIA 1943-1980
di Ray Bradbury / Mondadori, Milano, 2013 / pp. 1.342, € 29, 00
Se i marziani siamo noi
di Roberto Paura
Un vizio comune negli ambienti della critica letteraria è di sostenere che un’opera di fantascienza non sia in realtà “fantascienza” quando il suo valore artistico supera la media del genere, ponendosi sullo stesso piano delle vette del mainstream. Capita così che 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, i romanzi di James G. Ballard o le Cronache marziane di Ray Bradbury vengano comunemente definite “più che semplice fantascienza”, sottintendendo un’accezione innegabilmente negativa per lo stesso termine che designa questo genere letterario (o cinematografico). Nel caso di Bradbury, si può dire che egli stesso non sapesse definire con precisione la sua produzione letteraria. “Io ho scritto solo un libro di fantascienza, Fahrenheit 451”, disse recentemente. “Il resto, i miei romanzi, i miei racconti, sono fantasy. La fantasy racconta cose che non possono accadere. La fantascienza racconta cose che possono, invece, accadere” (cit. in Assante, 2012). Ma nella sua intervista perduta e recuperata dieci anni fa rilasciata alla Paris Review nel 1976, pubblicata in Italia per la prima volta in apertura alla sua monumentale autoantologia Cento racconti, Bradbury sostiene tutt’altro: “La fantascienza è narrativa di idee. Le idee mi eccitano, e appena mi eccito comincia a scorrere l’adrenalina e di lì a poco mi ritrovo a trarre energia dalle idee stesse… Appena ti viene un’idea che cambia una qualche piccola parte del mondo, stai scrivendo fantascienza. È sempre l’arte del possibile, mai dell’impossibile” (Bradbury, 2013). Una contraddizione? Forse. Leggendo i cento racconti inclusi in questa monumentale antologia, che raccoglie pressoché tutta la narrativa breve di Bradbury che valga la pena di essere letta, è difficile in effetti decidere quale delle due affermazioni dell’autore sia vera. Alcuni racconti sono fantascienza, altri sono fantastici (non “fantasy” nell’accezione che oggi diamo a questa parola), altri ancora sono del tutto realistici. Alla fine della lettura, non si può che concordare con la definizione data dallo stesso Bradbury alla sua narrativa – verrebbe da dire alla sua poetica – ossia: letteratura di idee. E il comune denominatore della sua opera è una sola, singola idea, che si può riassumere così: i veri marziani siamo noi.
Che, scritta così, è un’idea certamente fantascientifica. Se non addirittura scientifica, come spiegava l’astrofisico Giovanni Bignami nel suo libro I marziani siamo noi (2010), proponendo tesi sull’origine della vita sulla Terra rilanciate da recentissime scoperte che sostengono che la vita sia nata per la prima volta su Marte prima di giungere sul nostro pianeta. Ma non è la plausibilità scientifica delle argomentazioni a interessare Bradbury, quanto il concetto. Quando le prime spedizioni terrestri sbarcano sul Pianeta Rosso, s’imbattono in una civiltà apparentemente identica a quella del midwest americano nella metà del XX secolo. Non ci sono omini verdi ad accogliere i protagonisti dei racconti La terza spedizione e I terrestri, ma massaie indaffarate e pensionati smemorati, che non hanno tempo da perdere con le fantasie di quei giovanotti che dichiarano di essere venuti lì da un altro pianeta. Eppure quegli esseri così identici ai terrestri sono proprio marziani! Non hanno antenne che gli spuntano dal cranio a forma di pera, né tre occhi o due bocche. Sono, sotto tutti i punti di vista, identici agli umani.
Ma, sembra chiedere Bradbury al lettore, cosa ci assicura che i veri alieni non siamo, in fondo, noi stessi? Una riflessione non nuova nella fantascienza: basti pensare al famosissimo racconto La sentinella di Fredric Brown del 1954 (in Brown, 2013), in cui il protagonista descrive con orrendi aggettivi la creatura mostruosa e aliena contro cui sta combattendo in un altro sistema stellare, e che si rivela essere un essere umano. Uno spunto che non può non condividere anche Bradbury, appassionato lettore di storie gotiche cresciuto, oltre che con i racconti di Marte di Edgar Rice Burroughs, con le novelle di Edgar Allan Poe.
Si prenda ad esempio L’uomo del primo piano. Nell’oziosa routine di una pensione irrompe un uomo misterioso, il signor Koberman, che affitta una camera per qualche mese, lavorando di notte e dormendo di giorno. Il protagonista, un bambino un po’ impiccione, cerca di scoprire il suo segreto. Alla fine giunge a ucciderlo con una lama affilata, convinto che si tratti di un mostro. Ed è proprio così. “Un vampiro”, “un mostro”, comunque “qualcosa di non umano”, come lo definisce il medico accorso poco dopo di fronte a una scena raccapricciante, in cui le interiora dell’essere continuano a contorcersi aggrappandosi all’ultima speranza di vita. Eppure, il signor Koberman non aveva destato alcun sospetto negli altri ospiti della pensione, né nell’affittacamere. È un uomo un po’ scorbutico, dai modi rudi, ma non più di un lavoratore scapolo incattivito dalla fatica, dalla solitudine e magari dall’alcolismo. Un tipico essere umano medio. E invece no, è un mostro. Esattamente come nel classico del 1955 L’invasione degli ultracorpi di Jack Finney (2003), otto anni dopo la prima pubblicazione di questo racconto.
L’alieno è tra noi, o forse addirittura dentro di noi, senza che nemmeno siamo in grado di accorgercene. È così, per esempio, in un indimenticabile racconto, Lo scheletro, in cui il protagonista prende d’un tratto consapevolezza del fatto che dentro di lui alberghi uno scheletro con tanto di teschio ghignante. Benché sia parte integrante del suo corpo, il signor Harris percepisce lo scheletro come un estraneo, un nemico da distruggere. Si autoconvince che lo scheletro, ora che è stato scoperto, cerchi di ucciderlo, facendogli perdere peso di modo che le ossa escano allo scoperto sotto lo strato di pelle e di grasso che le ricoprono. In un tentativo disperato, il signor Harris si rivolge a uno specialista, il dottor Burleigh, che conosce il problema e realizza uno spaventoso intervento che divide per sempre i due esseri: lo scheletro da un lato, l’essere fatto di carne e muscoli flaccidi dall’altro, trasformato in una specie di medusa informe che striscia sul pavimento di casa.
Ne Il bambino del futuro Bradbury immagina che, per un incidente alle complesse tecnologie ospedaliere per il parto, il figlio dei protagonisti nasca in una dimensione superiore. Il risultato è che, nella nostra dimensione, il bambino appare un alieno: una sorta di piccola piramide azzurra con tre occhi e sei piedini. Tutti i suoi sistemi percettivi sono distorti poiché, pur trovandosi fisicamente in questa dimensione, il bambino fa parte di un’altra. Gli esseri umani gli appaiono come cubi e poliedri. La madre si sforza in tutti i modi di trattarlo come un bambino normale, ma deve tenerlo nascosto. Alla fine, insieme al marito, si convince a tentare un esperimento per spostarsi a propria volta nella dimensione in cui è nato il bambino. Solo in questo modo i genitori lo potranno vedere finalmente come un essere umano, anche se a loro volta saranno costretti a percepire gli altri loro simili come forme geometriche tridimensionali.
L’alienità è, insomma, dietro l’angolo. Basta cambiare un punto di vista per scoprire di vivere in un altro mondo, in un’altra dimensione. Alieni, nemici, possono essere anche le creature più innocenti: i bambini. I bambini sono i protagonisti di alcuni dei più riusciti racconti di Bradbury. Se è a loro che affidiamo la speranza di un domani migliore – sembra suggerire lo scrittore – allora il nostro domani assomiglia a un incubo. I bambini seguono una loro logica implacabile, un’etica distorta, un desiderio continuo di arrecare il male, che li trasforma in esseri crudeli e disumani, una volta che si è disposti ad andare oltre il filtro con cui la società guarda ai più piccoli. Ne Il piccolo assassino, la moglie del protagonista si convince che il figlio appena nato voglia ucciderla. Una convinzione liquidata come fantasia frutto di stress post-parto dal medico e dal marito, ma che ben presto assume contorni reali: il neonato inventa numerosi trucchetti per attentare prima alla vita della madre, poi anche a quella del padre, finché non riesce a ucciderli entrambi. Il medico alla fine prende coscienza della verità e va a caccia del piccolo assassino armato di bisturi, perché ormai gli è chiaro che non ha a che fare con un bambino, ma con un mostro, un abominio che dispone di coscienza e quindi di insaziabile malvagità. È così anche nel racconto forse più celebre di Bradbury, Il veldt. Anche qui i genitori si trovano a scontrarsi con i loro figli, che passano le giornate in una futuristica camera dei giochi che è una specie di stanza ologrammi in grado di ricreare diversi ambienti della Terra, tra cui la savana africana. Quando i genitori decidono di strappar via i bambini da quella camera dove ormai passano tutte le loro giornate (come i cittadini alienati di Fahrenheit 451, di solo un anno successivo), ecco che scatta un piano crudele: rinchiudere i genitori nella stanza trasformata in savana e lasciarli sbranare dai leoni. È fantasia? È realtà? È difficile dirlo quando si ha a che fare con i bambini. Per loro i leoni sono reali, per i genitori no. Ma quando si entra nella stanza dei giochi, sono solo le regole dei bambini quelle che contano, e per i più grandi non c’è scampo. L’atroce progetto è architettato con cura e non risparmierà nemmeno lo psichiatra che segue la famiglia, che nelle ultime righe giunge in casa e, non trovando nessuno, entra a sua volta nella stanza dei giochi, dove i bambini aspettano che i leoni lo maciullino. Il racconto, tra l’altro, sarà diretta ispirazione per un romanzo posteriore di James Ballard, Un gioco da bambini del 1988 (Ballard, 2007).
L’idea alla base di questi racconti, il “messaggio” che Bradbury vuol trasmettere al lettore, è che la crudeltà è l’essenza stessa dell’essere umano, ciò che ci distingue dagli animali, i quali invece uccidono o fanno del male solo per istinto di sopravvivenza. Nel racconto Il parco giochi, la malvagità dei bambini raggiunge il suo apice. Il signor Underhill passa ogni giorno davanti al parco giochi del quartiere e si rende conto che, lungi dall’essere un luogo di divertimento e spensieratezza, il parco giochi è un autentico girone infernale, in cui i bulletti passano il tempo a martoriare i più deboli, che a loro volta scaricano la loro frustrazione su quelli più indifesi e così via, in una grottesca rivisitazione dei campi di concentramento nazisti. Underhill vuole a tutti i costi impedire che il figlio frequenti quel posto, ma la sorella non vuole sentire ragioni e, dopo la scuola, porta il piccolo Jim al parco giochi. L’unico modo per salvare il bambino da un orrore senza fine è sostituirsi a lui, come propone il piccolo Marshall, che in realtà non è il figlio del suo collega, come Underhill inizialmente crede, ma proprio il suo collega che ha preso il posto del figlio per sottrarlo alla malvagità del parco giochi. Un autentico patto col diavolo, insomma, che il protagonista accetta a sua volta, sperimentando così di persona i pugni, le cadute, le ginocchia rotte, il naso sanguinante, gli sberleffi di tutti i tipi: “Questo è l’inferno! Questo è l’inferno!”, ripete Underhill mentre viene spinto giù dallo scivolo in una calca di bambini pronti a torturarlo.
In confronto a questo mondo malvagio, Marte appare come la Terra Promessa, esattamente come doveva apparire il Nord America “vergine” ai primi coloni puritani. Lo stesso Bradbury ha ammesso a più riprese che il suo Marte non è altro che la riproposizione in chiave futuristica del mito della frontiera. Non c’è niente di fantascientifico nelle storie marziane, se non al massimo i razzi con cui i terrestri giungono sul Pianeta Rosso (ma anche il razzo stesso è un semplice strumento funzionale alla storia, tant’è vero che in più di un racconto i coloni cercano di costruirne uno nel garage di casa, nel perfetto spirito del self-made-man). Marte è il Far West, una terra sottratta ai nativi, ai pellerossa, colonizzata dai fuggitivi di un mondo vecchio e morente, com’è nelle storie di Bradbury la Terra, costantemente descritta come squassata da un immane conflitto atomico (siamo sempre negli anni della Guerra fredda). I nativi marziani, come i pellerossa, sono gli ultimi residui di una gloriosa civiltà. Ne restano pochi, nascosti, apparentemente indifesi. Ma sono comunque più civili. I marziani sono il vero metro di paragone del nostro essere “umani”. Nel confronto con l’alterità, Bradbury rovescia il gioco delle parti e ci fa apparire come i crudeli invasori alieni che popolavano le storie della fantascienza classica.
In Erano bruni con gli occhi d’oro, una colonia terrestre su Marte viene silenziosamente “trasformata”: le verdure terrestri diventano aliene, le mucche portate dalla Terra hanno tre corna, e man mano anche gli esseri umani cambiano. Diventano più affusolati, cambiano il colore degli occhi, poi quello dei capelli. Iniziano a pronunciare parole di antico marziano, a loro sconosciuto. E dopo un po’ decidono di abbandonare la colonia e trasferirsi nelle antiche residenze abbandonate dei nativi marziani. Quando, dopo la fine della guerra, un gruppo di terrestri scende sul pianeta per scoprire il destino della colonia, non trova nessuno, se non un insediamento di marziani sulle montagne. Sono i terrestri, trasformatisi, che non hanno più alcuna voglia di avere contatti con coloro che un tempo erano loro simili. Nel racconto La gita da un milione di anni, una famiglia scampata alla guerra giunge su Marte. I genitori raccontano ai figli di essere lì per una gita e che presto torneranno a casa. I bambini vogliono vedere i marziani, e il padre assicura loro che presto li incontreranno. A un tratto giunge notizia che la Terra è stata distrutta dall’olocausto atomico. Non si può più tornare indietro. Così, il padre porta la famiglia sulla riva di un lago marziano e, specchiandosi nelle acque, spiega ai figli: “Eccoli i marziani”, rivolto ai loro riflessi nell’acqua. Meglio marziani che umani.
LETTURE
— Assante Ernesto, Addio a Ray Bradbury maestro di sogni, “La Repubblica”, 6 giugno 2012.
— Ballard James Graham, Un gioco da bambini, Feltrinelli, 2007.
— Bradbury Ray, Fahrenheit 451, Mondadori, Milano, 2000.
— Bradbury Ray, L’intervista perduta della “Paris Review”, in Cento racconti, Milano, Mondadori, 2013.
— Brown Frederic, La sentinella, in Cosmolinea B-2, Mondadori, Milano, 2013.
— Finney Jack, L'invasione degli ultracorpi, Milano, Mondadori, 2003.