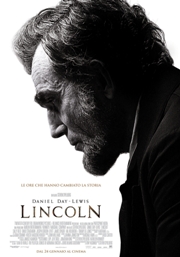VISIONI / LINCOLN
di Steven Spielberg / 20th Century Fox, 2013
Rinascita di una na(rra)zione
di Antonio Iannotta
“Che noi qui solennemente si prometta che questi morti non sono morti invano; che questa nazione, guidata da Dio, abbia una rinascita di libertà; e che l’idea di un governo di popolo, dal popolo, per il popolo, non abbia a perire dalla terra”.
Steven Spielberg fa del suo ultimo grande film, Lincoln, una scelta precisa, di natura etica ed estetica, e quindi politica, ritraendo Abraham Lincoln non solo come potente comandante in capo, quanto prima di tutto come uomo della parola. Abile e scafato retore politico. È così che il regista di tanti blockbuster di successo dipinge uno dei presidenti più amati dal popolo americano. E lo fa ponendo il celebre discorso di Gettysburg come centro non diegetico, ma di grande pregnanza di significato. Non è una coincidenza che il regista abbia deciso di promuovere il lungometraggio partendo da questa sequenza. Quello di Gettysburg è infatti il famoso discorso pronunciato da Lincoln il 19 novembre 1863 alla cerimonia di inaugurazione dell’omonimo cimitero militare, pochi mesi dopo quella che verrà ricordata come una delle battaglie più sanguinose della guerra di secessione e che si concluse con una netta vittoria delle forze dell’Unione. “L’idea di un governo di popolo, dal popolo, per il popolo” che rilanci una nazione verso la libertà: con queste parole cariche di retorica Lincoln costruì di fatto la futura nazione americana.
Il film è uscito il 16 novembre scorso negli Stati Uniti, ovvero solo dieci giorni dopo le elezioni presidenziali (per le pressioni degli ambienti repubblicani, condividendo lo stesso destino toccato a Zero Dark Thirty di Kathryn Bigelow) e racconta gli ultimi mesi di vita del Presidente, periodo in cui venne abolita la schiavitù e gli Stati dell’Unione vinsero la guerra civile. La sceneggiatura del premio Pulitzer Tony Kushner, che aveva già collaborato con Spielberg per lo straordinario Munich (2005) è basata sul bestseller Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln di Doris Kerns Goodwin, da noi (ancora) inedito.
Il Tredicesimo Emendamento (“La schiavitù o altra forma di costrizione personale non potranno essere ammesse negli Stati Uniti”) era di importanza fondamentale perché il presidente aveva la convinzione che se la guerra si fosse conclusa prima che l’emendamento passasse, la legge non sarebbe stata approvata. Mai. Lincoln sapeva di dover riuscire nel suo intento, ma non disponeva della maggioranza necessaria alla Casa dei Rappresentanti. Al centro della vicenda narrata nel film c’è proprio la sua battaglia politica fatta di pressioni anche poco edificanti, di piccole promesse, di sotterfugi di ogni genere per ottenere i voti necessari. Per fare, detto in altri termini, la cosa (che riteneva) giusta.
Spielberg decide di aprire il suo film con un furente corpo a corpo militare fra nordisti e sudisti. In Lincoln si entra attraverso la porta del massacro ma solo per stabilire una metafora che agisca come principio regolatore e funzionale del film. La politica è la guerra condotta con altri mezzi e per essere efficace deve essere combattuta con tutta la forza di cui si è capaci. Lincoln dichiara subito di voler essere anche un film iconico e monumentale: un lungo carrello all’indietro ci mostra la figura del presidente inquadrato di spalle con le mani saldamente posizionate sulle ginocchia, prima che un controcampo preso dal basso lo inquadri in tutta la sua grandezza. Come se fosse già in vita una sorta di patriarca.
In parallelo assistiamo anche alla vita privata del Presidente, ai suoi rapporti con la moglie (la straordinaria Sally Field) e con i due figli. Lincoln come presidente dunque, ma anche come marito e padre. Due anni prima, i coniugi avevano perso l’undicenne Willie a causa di una febbre tifoidea. Il rapporto del presidente con gli altri due figli è ambivalente: con il piccolo Tad è padre quanto mai amorevole; con il giovane Robert il contrasto matura per la presa di posizione del ragazzo di arruolarsi a tutti i costi e compiere, sull’esempio dell’amato quanto odiato padre, ciò che è giusto per il Paese. Contro il parere della madre.
A dare corpo, volto, prossemica e soprattutto voce al sedicesimo Presidente degli Stati Uniti d’America, ecco Daniel Day-Lewis, indubitabilmente uno dei più importanti attori della sua generazione, che qui incarna la metà splendente di quanto non avesse fatto ne Il petroliere (2007) di Paul Thomas Anderson, o nel precedente Gangs of New York (2002) di Martin Scorsese.
In questi due film l’attore anglo-irlandese aveva rivestito infatti i panni di due autentici fondatori oscuri della nazione americana. Nel film di Spielberg la performance di Daniel Day-Lewis mette in valore in maniera formidabile sia gli aspetti del personaggio pubblico sia il dietro le quinte. Al monumento, Daniel Day-Lewis e Spielberg restituiscono l’altrettanto importante spessore umano.
Gli interni del film e il modo in cui il regista organizza gli spazi intorno al suo protagonista, il dettaglio degli arredi, le luci sottolineano la precisione documentale di una ricostruzione storica rivolta al presente. Il personaggio del presidente è stato infatti portato sullo schermo molte volte, ma in nessun caso Lincoln era stato rappresentato interamente nel ruolo del presidente. Chi scrive nutre pochi dubbi riguardo al destino del film di Spielberg, che, nonostante la débacle al Golden Globe e agli Oscar, crediamo verrà guardato per i decenni a venire come il punto di riferimento ineludibile per l’iconografia del Presidente. Spielberg e Daniel Day-Lewis descrivono pazientemente la Storia, quella con la maiuscola, operando attraverso un’accurata anatomia del corpo del protagonista.
Il regista statunitense poi non vuole solo raccontare la Storia del proprio Paese. Come fa nei suoi film più consapevoli, Spielberg desidera ingaggiare un rapporto con la Storia del cinema. In particolare con Nascita di una nazione (1915) con il quale, quasi un secolo fa, David W. Griffith volle fotografare l’unità degli Stati Uniti sotto il segno del fuoco giustiziere e purificatore del Ku Klux Klan. Il messaggio di Spielberg è chiaro: bisogna mettere da parte la furia vendicatrice e razzista del vecchio Sud perché l’America va fondata piuttosto su un sogno egualitario. Si metta in triangolazione allora la scena del Ku Klux Klan di Django Unchained, la più esilarante dello straordinario film di Quentin Tarantino. Tenga bene a mente il lettore che il Ku Klux Klan è ancora oggi una realtà attiva e più che presente nel Paese di Obama. Per cui si riderà pure, e di gusto, nel film di Tarantino, ma il sapore che resta in bocca è quello amaro della storia che si ripete ineluttabile.
Dunque, si diceva, si parla molto in Lincoln. In un’epoca in cui la sfera pubblica italiana e occidentale non fa altro che banalizzare la complessità dei fenomeni politici, Lincoln ribadisce il primato retorico della parola e della politica. Di una parola che sappia agire. E lo fa attraverso un’importante lezione di cinema oltre che di storia. Spielberg non vuole tacere nulla del percorso legislativo che portò all’abolizione della schiavitù. Vedere Lincoln significa anche imparare e molto su una vicenda storica di cui sappiamo poco. E vederlo in originale poi consente di apprezzare, oltre alla performance indimenticabile del protagonista (non a caso l’attore anglo-irlandese ha vinto sia il Golden Globe che l’Oscar), la dizione di William Seward (David Strathairn), il rivale del Presidente per la nomination del 1860 che divenne il suo Segretario di Stato nonché intimo partner politico, così come il sarcasmo al vetriolo di Thaddeus Stevens (un sommo Tommy Lee Jones), il vero leader abolizionista, intransigente e senza mezze misure. Accanto a loro una costellazione di interessanti personaggi politici tratteggiati mai in maniera eccessivamente aneddotica. Il film riesce a restituire molte delle sfaccettature del discorso politico di quei giorni che segnò di fatto la nascita della storia moderna degli Stati Uniti.
Questo ci conduce ad un’ultima considerazione. La capacità di penetrazione nei meccanismi della politica del cinema a stelle e strisce è davvero straordinaria. Negli ultimi mesi abbiamo avuto conferme a ripetizione che al cinema politico americano bisogna prestare massima attenzione. Poter confrontare a breve distanza film pur diversi tra loro come Argo di Ben Affleck sulla crisi iraniana (una vicenda vera trattata in maniera narrativamente accattivante), Django Unchained di Tarantino sulla schiavitù (una ricostruzione iperrealistica a partire dallo stesso momento storico di Lincoln) e Zero Dark Thirty di Kathryn Bigelow sulla caccia a Osama Bin Laden (altra storia “vera” abilmente romanzata), offre la possibilità di osservare come il cinema sappia trattare in modi diversi la materia storica, in specie quella a forte valenza mitopoietica. La politica e la storia nel cinema americano sono una questione di mitologia da reinventare continuamente.
Lincoln infine non è solo un incontro con la Storia ma anche un messaggio per Barack Obama, il primo presidente a beneficiare nella maniera più autorevole possibile dei vantaggi conseguenti al Tredicesimo emendamento. Spielberg sembra parlare direttamente al “suo” presidente per dirgli che i bei discorsi servono a poco se non si combatte fino alla fine, insieme all’altra parte politica, per realizzare il bene superiore. Elogio della capacità di mediazione. Anche utilizzando i sistemi più meschini come dimostra l’astuzia politica del vecchio Lincoln. Obama è avvisato: se vuole davvero passare alla Storia, non solo per il dato inconfutabile di essere stato il primo presidente afro-americano di quel grande paese che, nonostante tutto, sono gli Stati Uniti d’America, deve fare qualcosa di più.