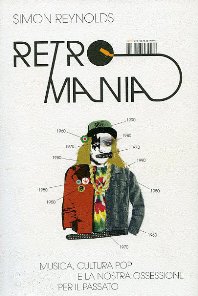LETTURE / RETROMANIA
di Simon Reynolds / ISBN, Milano, 2011 / pp. 480, € 26,90
Appunti sullo stato
delle cose presenti
di
Marco Maiocco
Consentiteci questo fantaragionamento, gioco letterario o meglio speculativo; diciamo fanta perchè prende spunto dalla non lettura di un saggio dell’ottimo giornalista musicale Simon Reynolds Retromania, volume del quale si è parlato molto ultimamente, e che comunque invitiamo a leggere. Non lo abbiamo ancora letto, perché, forse erroneamente e presuntuosamente, abbiamo avuto la subitanea sensazione che tratti in modo non appropriato un problema da tempo decisamente all’ordine del giorno: quello di un continuo troppo facile ritorno al passato e di un’assoluta mancanza di novità nell’odierna popular music.
Permetteteci quindi questo ragionamento “assurdo” che parte da una lettura possibile, ma non effettuata: Jorge Luis Borges e il Giorgio Manganelli delle Interviste impossibili (Manganelli, 2006), probabilmente ne sarebbero lieti. Qualcun altro poi che avrà letto il libro smentirà (a partire da noi stessi) questa sorta di pregiudizio epistemologico, che però ha sortito riflessioni immediate, impossibili da tenere a bada. Tanto (si sa) si procede a tentoni, per tentativi di leggere un presente che solo la storia potrà definire e connotare, e certo non in modo apodittico. Altra storia, altre teorie storiche e (potremmo dire) scientifiche falsificheranno quelle precedenti, nell’illusione di poter guardare ciò che non possiamo vedere.
José Saramago raccontava di una cecità umana, Immanuel Kant distingueva tra noumeno e fenomeno, Arthur Schopenhauer disquisiva a proposito di un velo di Maya da disvelare, Karl Popper di paradigmi, che inevitabilmente si succedono, eludendosi, e spesso a partire da semplici sbagli. Di questi tempi, però, non ricordiamolo troppo ai ricercatori del Gran Sasso, che hanno appena scoperto di aver mal calcolato la misurazione dell’ipotetica “iperfotonica” velocità dei neutrini, a causa di apparecchiature banalmente mal “registrate”.
Ma cominciamo da più lontano. Uno dei problemi odierni (tra i più decisivi e capitali) è l'eterno presente a-storico in cui siamo o ci hanno immersi, e che la virtualità informatica dei nostri giorni contribuisce a creare. La nostra è diventata una società non più in grado di regalare prospettive, percorsi di vita, a partire dalla mancanza di lavoro, che va soprattutto creato, attraverso una seria politica industriale, e non semplicemente riorganizzato. Tutto si esaurisce nel diritto alla soddisfazione immanente e immediata di ogni bisogno, quando si può ovviamente. Sembra che i giovani crescano come su un piano euclideo da riempire ex novo eternamente.
Non si è più abituati all’idea di costruire un'etica individuale o (meglio) collettiva che permetta di attraversare il tempo. Siamo eternamente fermi, come vivessimo all'infinito in sempiterne medesime condizioni: è l'illusione di un'immortalità felice, o meglio infelice. Forse solo un evento terrificante e drammatico, come può esserlo solamente la guerra (che chissà, è probabile purtroppo si stia avvicinando a grandi passi), potrebbe restituire l'idea di un prima e un dopo, come cercava di spiegare Beppe Fenoglio nel suo capolavoro Una questione privata (Fenoglio, 2011).
A proposito della realtà virtuale da cui siamo circondati, l’antropologo radicale Marc Augé nel suo ultimo libro La guerra dei sogni (Augé, 2012) ci spiega (appunto) che è cominciata la guerra dei sogni, ovvero, trascriviamo direttamente dalla quarta di copertina, “quasi senza accorgercene, stiamo passando a un tutto fittizio in cui le mediazioni che consentono lo sviluppo dell'identità, dunque la presa di coscienza dell'alterità e dei legami sociali, sono rimpiazzate dai media della solitudine. Quella fondamentale circolazione tra i tre poli dell'immaginario – immaginario individuale (il sogno), immaginario collettivo (i miti, i riti, i simboli) e finzione narrativa – viene così alterata, sfaldando le frontiere che ogni cultura istituisce tra sogno, realtà e finzione.” La rete (quella telematica ovviamente, che Marc Augè sottointende nel suo ragionamento quando parla di “media della solitudine”) è senz'altro una grande opportunità, ma bisogna avere i necessari strumenti per poterla utilizzare al meglio, altrimenti è solo l'infernale mezzo con cui si coltiva la piatta tavola temporale, vera e propria finzione, di cui abbiamo parlato poco sopra. Un contenitore illimitato dove tutto accade all'infinito e soprattutto contemporaneamente: Reynolds nel suo libro, con una suggestiva intuizione, lo definisce l'anarchivio, un archivio infinito nel tempo e nello spazio, dalle proprietà anarchiche, perchè non più in grado di garantire un ordine prospettico e sistematico, in sostanza un’adeguata storicizzazione.
Chi vive scavando, però, allenandosi ad essere il minatore del proprio campo e possibilmente di molteplici campi tra di loro in connessione nel senso più olistico possibile, può (lo sappiamo, e per fortuna) trovare in rete l'eterna biblioteca da cui attingere, quella sognata anche da Jorhe Louis Borges e da successivi bibliomani – ci vengono in mente a questo proposito i racconti surreali dello scrittore serbo Zoran Zivkovic – nel senso che i libri sugli scaffali, nell'ordine dovuto, ce li mettiamo noi, come in una certosina opera amanuense di ricostruzione (Zivkovic, 2011). Un’operazione che non può che essere preceduta e supportata da un continuo studio fuori dalle connessioni elettroniche.
Attenzione, quindi, a non demonizzare la rete, bisogna solo saperla usare con intelligenza, anche perchè forse rappresenta davvero finalmente e paradossalmente quel noumeno possibile che cerchiamo, la sostanza delle cose. Se non altro è forse la fotografia più plastica del continuum spazio temporale einsteiniano (ma questo in realtà è davvero un altro discorso e decisamente azzardato), perchè probabilmente anche la visione prospettica è un altra illusione, come sono convenzioni illusorie la storia e le narrazioni. Ma noi esseri umani, lo sappiamo, non possiamo che vivere di illusioni, perché non percepiamo la realtà come è, ma come la vediamo, rappresentiamo, sentiamo, immaginiamo, ciascuno a modo suo: il mondo è brutto perchè è vario, direbbe qualcuno. Ma anche se la storia è finita (o forse no) l’esercizio della memoria, o meglio della storia, è l'unico che può garantirci un futuro. La memoria – quella storica soprattutto, che poggia sull’oggettiva documentazione e ricerca scientifica, e meno quella personale, particolaristica e individuale, che riguarda le sacrosante intime vicende e ricerche di ognuno di noi, che (però) poco hanno a che fare con la necessaria costruzione di un’ampia e condivisa visione collettiva (De Luna, 2011) – è il primo dei valori da coltivare e conseguire, perchè serve a edificare l'ethos indispensabile ad una compiuta lungimiranza, altrimenti si torna alla voragine dell'eterno presente.
Voragine nella quale soprattutto le giovani generazioni rischiano di rimanere sprofondate irrimediabilmente, perchè frastornate fin dalla culla (pensiamo agli odierni ventenni) da media corrotti e collusi (internet compreso, ovviamente) con una criminale politica del potere in eterna combutta o asservita al più forte potere del capitale, che per rigenerarsi deve cinicamente permeare di sé l'intera società nei modi più spietati, fino ad allontanarsi totalmente dalla realtà, diventando etere finanziario moltiplicatore di sé stesso all'infinito. Il grande utilizzo della rete ad opera di una foltissima ed agguerrita comunità giovanile (e non solo) – come spiega in un puntuale saggio intitolato Se questa è democrazia il giornalista, teorico delle culture di rete Carlo Formenti (2009) – se impolitico, nel senso che pensa di poter fare a meno della politica, rende quel potere politico cinico e avverso che intende combattere paradossalmente ancora più arrogante, forte e intoccabile. Non si può fare a meno, aggiungiamo noi, della politica, di una cultura della politica, che si costruisce edificando una compiuta visione prospettica, come avviene in tutti i grandi processi di acculturazione.
Attenzione però a non avere fiducia nei giovani, sarebbe come credere che gli esseri umani non sono più in grado di pensare, articolare idee e ragionamenti ponderati, qualcosa che tutto sommato sembra ancora impensabile, almeno prima che la tecnologia faccia ulteriori passi decisivi in avanti (o indietro). In questo senso negli ultimi anni siamo stati testimoni di molte prove confortanti, assistendo ad una serie di movimenti della giovanile società civile, che hanno senz'altro espresso vitalità, consapevolezza, sapere acquisito, nonostante i tagli all’istruzione pubblica. I percorsi di coscienza e conoscenza sono sempre possibili, in ogni condizione, e sono i più personali e imperscrutabili. Ovviamente a questo proposito la Scuola con la esse maiuscola, pubblica e a tutti accessibile, svolge un ruolo fondamentale e imprescindibile: prosciugarla significa eliminare le capacità di studio, pensiero, approfondimento e connessione che albergano in ciascuno di noi. E più la Scuola forma, insegna a pensare – questo il suo fine supremo inalienabile, non contrattabile –, meno è (paradossalmente) collegata alla rapida interattività di questi tempi (che però non bisogna demonizzare: l'equilibrio come vedete è molto precario) più sarà possibile garantire l'esistenza della cittadinanza in contrapposizione alla schiavitù.
Una premessa doverosa, ma adesso proviamo a parlare di musica, di popular music. Molti, come Simon Reynolds – e non a torto –, sostengono che da tempo non vi avvenga nulla di sostanzialmente innovativo per colpa (o anche) del cosiddetto anarchivio, di cui abbiamo parlato sopra. Tutta una serie di elementi si mescolerebbero di continuo, senza mai una vera e propria rotta di collisione con il passato (ma questo è un valore in assoluto? Forse sì, forse no). Ciascun attore musicale in circolazione – questa la tesi – oggi ha la costante possibilità di rifarsi ad un’archivio infinito, nel quale tutto è presente contemporaneamente e da cui può attingere estetiche e stilemi, che decontestualizza, a seconda delle proprie contingenti esigenze espressive. Da qui la possibile spiegazione del perché si comprerebbero più dischi di quarant'anni fa, piuttosto che lavori pubblicati la settimana scorsa, paradossalmente meno freschi e innovativi. Spiegazione suggestiva ma crediamo tutto sommato riduttiva.
Proviamo a mettere ordine. Il ritorno al passato – assolutamente necessario sul piano prettamente culturale – che (per fortuna) caratterizza in parte questo nostro tempo, non crediamo sia favorito dai media distorti (tra cui internet, ricordiamolo) di cui abbiamo detto sopra, perchè non è nel loro Dna garantire una visione prospettica: devono obnubilare, negligere la memoria, che è tutta un'altra faccenda; ed il famoso principio di articolazione che Richard Middleton enuclea nel suo celebre Studiare la popular music (Middleton, 2001) – secondo il quale sostanzialmente ad ogni epoca corrisponderebbero sacche di resistenza al potere costituito, in eterna dialettica e quindi anche trasformazione, come per successive cristallizzazioni frazionate, con uno status quo che, attraverso il mercato e le sue leggi o deregolamentazioni, è sempre o quasi in grado di utilizzare a proprio vantaggio anche le forze d’opposizione più radicali –, agisce soprattutto sul presente più che sul passato e comunque sempre su un piano maggiormente macroscopico. In altre parole, per fare qualche esempio, si strumentalizza più facilmente Jimi Hendrix che non i Nucleus di Ian Carr, ed è più agevole strumentalizzare i contemporanei Rage Against The Machine piuttosto che il Neil Young di On The Beach. I new media, invece, sono senz'altro in grado di favorire e condizionare lo sviluppo delle mode, in termini di superficiali e vuote manie, come appunto può esserlo l’acritica ricerca di un modernariato vintage tutto da collezionare, un atteggiamento (questo sì) che, lungi dall’essere un consapevole viaggio in un passato da sgranare, conoscere, conservare, per cercare di capire il presente (dal quale va costantemente distinto) e immaginare un futuro, ci sentiremmo di definire con il termine retromania – perché il problema sta proprio nella definizione usata da Reynolds – pratica senz’altro molto diffusa ai giorni nostri. Un aspetto ovviamente non trascurabile e forse decisivo, ma certo non dipende dall’odierno sistema mediatico se si comprano più dischi dei Ten Years After che dei Coldplay (cosa per altro tutta da dimostrare), per fare un esempio qualunque: sono percorsi culturali (nei quali riconoscersi o meno) compiuti – speriamo, crediamo – da tutti quegli individui che abbiano compreso che senza il senso della propria storia è ben difficile preparare un mondo avvenire.
Perché se ci imbattiamo nell'ultimo cd dei Fleet Foxes (anche se è vero che questo è indiscutibilmente popular colto), è con piacere che vi riconosciamo una sorta di versione contemporanea del classico Pet Sound dei Beach Boys; o allo stesso modo, se ascoltiamo un disco dei Megafaun, ci si allarga il cuore a sentire la mescolanza tra certo math-rock, venature ayleriane, pop sofisticato, melodiose armonie alla David Crosby e Graham Nash, e quant’altro; e ancora, se mettiamo sul “piatto” il nuovo folk-rock degli scozzesi Trembling Bells, con quel suono post-moderno, come se i Mogwai suonassero folk, interfacciandolo ai più disparati elementi – tardo beat, incursioni jazzistiche (anche qui) alla Albert Ayler, echi di Basement Tapes dylaniani, “chicanismi” alla Calexico, e molto altro ancora – ne riscontriamo con soddisfazione l’ottimo risultato d’insieme. In questi casi non c'è vuota decontestualizzazione, ma autentica, consapevole riarticolazione, se non reinvenzione.
Questi stilemi purtroppo non sono così universalmente diffusi, altrimenti saremmo circondati da un ben più alto grado di consapevolezza, e da una musica dalla qualità media molto più elevata. Questa consapevolezza non è favorita dai poteri mediatici che ci circondano, ma viene al contrario ostacolata: i giovani che oggi fanno musica spesso sanno poco o niente purtroppo (ecco la causa del vuoto di idee) e semmai la missione è quella di renderli il più edotti possibile, attraverso un’adeguata opera di divulgazione. Ma, come abbiamo lasciato intendere in precedenza, il genio può scaturire in ogni momento, anche dal nulla.
I dischi, poi, sono, per ragioni storiche, inevitabilmente comperati da una fascia di appassionati, la cui età oscilla tra i 35 ed i 65 anni; i giovani, che peraltro hanno altri interessi musicali (meno datati per l’appunto), non comprano dischi o ne acquistano molto pochi, perché per ascoltare musica sono ovviamente portati ad utilizzare le odierne tecnologie di fruizione (non potrebbe essere diversamente, per quanto molto rischioso sul piano culturale), e perché spesso non hanno quel minimo di indipendenza economica che può permettere loro di acquistare anche solo che un semplice cd. Tornando alla nostra riflessione sul passato, non possiamo, seppur brevemente, non parlare di tradizione, cultura artistica, sedimentazione di linguaggi. Nella musica eurocolta, il periodo barocco è durato a spanne circa 150 anni, quello classico altrettanti, e via discorrendo. Ci siamo accorti in questi anni che, nell’epoca caratterizzata dal più alto tasso di “mediazione” mai registrato nella storia dell’umanità, una tradizione – che è poi una selezione conscia ed inconscia di elementi – riesce a sedimentare adeguatamente in circa quarant’anni o forse meno (a questo punto), vedi i jazzisti che oggi lavorano sul repertorio del rock classico. Ma tutto questo ce lo spiegava bene anche il trombettista jazz Bunk Johnson, quando negli anni Quaranta riproponeva con successo il sound collettivo di New Orleans dei primi del Novecento.
La popular music, compreso il jazz con il suo rutilante percorso artistico, si è evoluta moltissimo in un tempo brevissimo. Occorreranno forse (esagerando, vista la velocità con la quale tutto avviene) un altro paio di secoli (oppure no) prima di assorbire questo complesso articolato variegato “canone”, che poi poggia su una matrice di elementi pressochè inesauribile. La cultura italiana si è costruita sul canone trecentesco, alcuni straordinari intellettuali, Dante Alighieri in primis (inutile sottolinearlo), hanno elaborato un edificio culturale impressionante, nel quale abitiamo tutt'oggi, senza nemmeno avere la particolare sensazione che la casa sia nel frattempo diventata troppo piccola.
La domanda su quanto tempo occorrerà ancora per assimilare i molteplici processi musicali novecenteschi, e i continui scambi e confronti tra culture musicali differenti che hanno caratterizzato il secolo scorso nasce davvero spontanea. È inevitabile porsela se pensiamo all’intera storia del jazz (popular o accademia afroamericana) e a quella del rock, a John Coltrane e Ravi Shankar, alla “rivolta” elettrica di Miles Davis, a Karlheinz Stockausen in rapporto ai Beatles e ai Grateful Dead, agli scambi tra jazz-rock, jazz, musica creativa afroamericana e musica creativa “contemporanea”, alle continue interconnessioni tra musiche etniche, folkloriche e popolari (nel senso british del termine); e poi alle grandi rivoluzioni in ambito colto, non così completamente disgiunte dai vorticosi fermenti del mondo popular, la profondità prospettica mahleriana, la serialità minimale di Arnold Schönberg e Anton Webern, la tavolozza timbrica di Igor Stravinskij, la “concretezza” ritmica di Edgard Varèse, la visionarietà elettronica di Bruno Maderna, le folk song di Luciano Berio, la rivisitazione della musica popolare ungherese (e non solo) nelle composizioni di Béla Bartók.
Nella popular music, inutile negare, si è assistito, diciamo tra il 1965 e il 1979, ad uno straordinario momento di splendore creativo, un’epoca aurea che ci ha lasciato in eredità un magma sonoro ancora da comprendere, decifrare, oltre che custodire. È un po' come se tutta questa ricchezza ci abbia fatto tornare indietro nel tempo, ad un’epoca nella quale di nuovo ci ritroviamo ad avere a che fare con una sorta di materia primigenia ancora tutta da plasmare. È probabilmente normale che oggi non ci siano rivoluzioni, ce n'è già stata una (o più d’una), anche se questo non può in alcun modo costituire una giustificazione all’odierna stasi. Bisogna però sapere che forse siamo come tornati all'epoca degli amanuensi, della certosina ricostruzione culturale. Tra un po’, chissà quando, assisteremo ad un nuovo rinascimento. Luogo comune anche questo, per altro: il medioevo non è certo stato così buio, e il rinascimento, con tutto il suo classicismo, non è forse l’esempio più paradigmatico di indipendenza nella creazione artistica. Attenzione (però), siamo tornati ad una sorta di “epoca benedettina” con tutti i rischi di una tragica e irrimediabile dispersione che questo comporta, e che si tradurrebbe in una specie di nefasto millenaristico analfabetismo di ritorno. Ma proprio per questo crediamo che i giovani più avveduti, in musica come nella società, stiano tentando di ricostruire lo spazio vitale e simbolico (pensiamo, per esempio, alla recente occupazione del Teatro Valle a Roma), ridefinendone regole e dinamiche, in un modo tutto sommato nuovo e imprevedibile, sempre che ne abbiano il tempo e un minimo di spazio. Di fronte, infatti, c'è sempre un potere spietato e cinico, che ha osteggiato la rivoluzione o le rivoluzioni di un tempo – in qualche modo ponendovi fine con le politiche liberiste, che dalla fine degli anni Settanta ci hanno portato alla crisi attuale, che certo nessuno pensa di superare immaginando un altro modello di sviluppo, perché ovviamente il problema risiede solo nell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori – e si oppone alle possibili riorganizzazioni – economiche, politiche, sociali (rivoluzionarie?) di oggi. Ma dobbiamo sapere però, e (chissà…!) forse è proprio questo che dimentica Simon Reynolds nel suo Retromania (ma in realtà non lo sappiamo, perché non abbiamo letto il libro), che una sorta di rivoluzione c'è già stata e che siamo ancora qui a cercare di annunciarla.
ASCOLTI
— Fleet Foxes, Helplessness Blues, Bella Union, 2011.
— Megafaun, Megafaun, Cramned Discs, 2011.
— Trembling Bells, The Constant Pageant, Honest Jon's, 2011.
LETTURE
— Augé Marc, La guerra dei sogni, Eleuthera, Milano, 2012.
— De Luna Giovanni, La repubblica del dolore, Feltrinelli, Milano, 2011.
— Fenoglio Beppe, Una questione privata, Einaudi, Torino, 2011.
— Formenti Carlo, Se questa è democrazia, Manni, San Cesario (Le), 2009.
— Manganelli Giorgio, Le interviste impossibili, Donzelli, Roma, 2006.
— Middleton Richard, Studiare la popular music, Feltrinelli, Milano, 2001.
— Zivkovic Zoran, Sei biblioteche, TEA, Milano, 2011.