

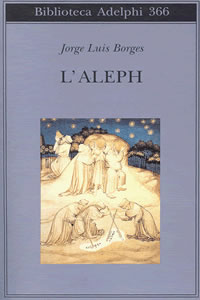


letture / di Livio Santoro
e di tutti i Borges
Jorge Luis Borges, quando intorno ai vent’anni (perché anche Borges è stato giovane) inondava di manifesti e brevi dimostrazioni della sua spocchia ultraista riviste e pamphlet letterari non era ancora quel Borges che sarebbe venuto qualche anno più tardi, pur essendolo già da prima. Quest’altro Borges rigoroso e famelico assaggiatore del fantastico e del prospettico, avrebbe rigettato quell’ipertrofia, quella furia adolescenziale, avrebbe fatto carta straccia del giovane Borges. D’altronde l’uno e l’altro ci hanno abituato a sentir parlare di loro stessi come di uno o più loro personaggi, e come uno o più dei loro autori. Uno dei tanti. E ci hanno abituato anche a fare altro, per esempio ad immaginare le parole in sequenza come una striscia continua, senza principio né fine, in cui tutto può essere detto e tutto può essere negato, nello stesso momento, come a Babele. La contemporaneità borgesiana delle rifrazioni, come verrebbe da chiamare questo motivo classico dello speculare (ai più arditi la scelta su come leggere questa parola) del poeta argentino, è alla base di tutto quello che Borges ha scritto. Un prospettivismo dalle sfaccettature quasi nietzscheane, in cui un posto privilegiato occupano le rifrazioni interne, quelle della memoria. Perché un bizzarro gioco biografico ha scelto per il narratore di renderlo realmente protagonista della sua storia, come un carattere sfuggito dalle sue stesse pagine infinite, come una delle due mani che in Escher si disegnano. Proprio così. Paradossalmente, in questo gioco di rilanci e di ritrazioni, una dichiarazione assume il suo carattere predittivo, spaventosamente predittivo (a meno di rifuggire, è ovvio, l’epiteto spaventoso per quanto riguarda la realtà). Questa dichiarazione, questa terribile anticipazione, sta in tre versi di Evaristo Carriego, citati da Borges (1996, p. 36) in un frammento del 1921 (ora raccolto nel volume Il Prisma e lo specchio), programmaticamente intitolato Buenos Aires:
Il cieco
Evoca memorie di cose
Di quando i suoi occhi avevano mattine …
È lo stesso Evaristo Carriego della prima grande apologia borgesiana (1955). Il Carriego che rappresenta la tensione dell’Argentina dei criolli e dei gauchos, l’Argentina in cui il tango è un duello, e in cui i coltelli muovono le braccia degli uomini. Il cieco, dice Carriego, che evoca nella memoria quello che accadeva quando c’era luce, quando c’era mattino. Borges, in fin dei conti, il Borges delle biblioteche, quello che dice:
Mancano i giorni ai miei occhi … (1969, p. 67)
Il guardiano dei libri, quel personaggio che, senza cercare un limite tra la storia e le storie tra la realtà e una realtà, decide (non ha senso a questo punto dire se consapevolmente o meno) di chiudere gli occhi e di tenere tutto nella memoria, perché altrimenti l’infinito cercherebbe uno spazio in cui nascondersi, cercherebbe un Aleph (1952, pp. 150-170), ed andrebbe fuori dall’uomo. Allora quello stesso personaggio non è solo il Borges di Borges, ma è anche Ireneo Funes (1956, pp. 97-106), è anche Tzinacàn (1952, pp. 114-120), sono tutti.
Ecco, si prenda Funes, Funes il memorioso, che semplicemente gettando uno sguardo alla passiflora, la vedrebbe come nessuno mai l’ha vista, dall’inizio fino al crepuscolo dei tempi. Funes che chiude le finestre di casa, che s’impone d’essere cieco perché ha il dono terribile della memoria. Ricorda tutto Funes, è deietto nella dimensione asfissiante della sua memoria. E così Tzinacàn, che non riesce ad ordinare i suoi ricordi ed a trovare la scrittura del Dio in quello che ha visto nel passato, in ciò che immagina di aver visto in quello stesso o in un altro passato ed in ciò che si palesa nell’attimo in cui il Sole ed i suoi aguzzini gli concedono ogni giorno in un istante di luce, sul fondo di quel pozzo dove stagnano le sue memorie. Il Dio di Tzinacàn è quello che si nasconde nella pelliccia di un leopardo, nel disegno fatto di macchie che sono alfabeto, che sono storia. Il Dio di Funes è la sua propria memoria. Ma è un Dio ingombrante, un Dio che spezza le gambe dei suoi fedeli, che li inchioda a un letto, che li rende ciechi. Entrambi questi dei, quello di Funes e quello di Tzinacàn, condividono una confessione incommensurabile, che diventa terribile solo se messa a paragone con la realtà. Entrambi questi dei, semplicemente, non possono essere raccontati. Sono entrambi Undr, sono entrambi meraviglia. La memoria allora, e la cecità (che sia organica o che non lo sia) stanno al di sotto di tutte le altre cose, in silenzio ma fattivamente.
In una poesia intitolata in maniera inequivocabile On his Blindness (1986, p. 60, 61), Borges costruisce contemporaneamente l’epitaffio dei suoi occhi, e l’apologia della sua memoria:
Sul finire degli anni mi circonda
un’ostinata nebbia luminosa
che riduce le cose a una cosa
informe e stinta.
Quasi un’idea.
E quando tutte le cose sono una sola cosa, va da sé, esse appartengono ad uno scenario che ne moltiplica gli accenti. Se tutte le cose possono essere una sola cosa, al contrario anche una sola cosa può essere tutte le cose. È la storia di una gerarchia che si specchia. Così una moneta da venti centesimi può essere tutte le monete (Zaihr, 1952, pp. 101-113). Così un uccello può essere tutti gli uccelli (Simurg, 1957, pp. 129-130). Così un libro può essere tutti i libri (Il Libro di sabbia, 1975, pp. 98-103). Una tigre fuori dal tempo può essere tutte le tigri (L’altra tigre, 1960, pp. 130-133). Così tutte le parole possono essere una sola, impronunciabile parola (Undr, 1975, pp. 68-73). Così un oggetto o un luogo possono essere tutti gli altri oggetti o luoghi (L’Aleph, 1952, pp. 150-170).
Ogni cosa, in questo modo, rimane nella memoria di un cieco, di un uomo che si rifiuta di vedere in quanto basta soltanto immaginare, nonostante l’oscurità, nonostante l’ombra. Proprio l’ombra, quella a cui Borges dice grazie nel suo Elogio (1969, p. 119):
Nella mia vita sono sempre state troppe le cose;
Democrito di Abdera si strappò gli occhi per pensare;
il tempo è stato il mio Democrito.
Questa penombra è lenta e non fa male;
scorre per un mite pendio
e somiglia all’eterno.
Troppe sono le cose del ricordo, meglio ridurle ad una, meglio ridurle ad un’idea. Ma allo stesso tempo sono troppo poche, se viste da una sola parte. Ed allora la gerarchia si capovolge, e ritornano a giocare le rifrazioni degli specchi. Ma, dato che tutto (e proprio tutto) è anche e banalmente il suo contrario, l’essenza della memoria, la reale portata del ricordo e di tutte quelle cose che sono una, o di quella cosa che è tutte le cose, è costituita nel profondo anche dall’oblio.
Borges amava dire che gli sarebbe piaciuto, una volta morto, essere dimenticato. Dimenticato e basta. Tuttavia questo progetto, per un motivo o per un altro, è risultato essere impossibile, improponibile forse. Ed allora dimenticare tutto ciò che si porta dentro, almeno da parte propria, può essere un buon rimedio per il poeta. Così, come quelle cose che ritornano sempre a se stesse, Borges conclude il suo accorato Elogio dell’ombra dicendo finalmente:
Posso infine scordare. Giungo al centro,
alla mia chiave, all’algebra,
al mio specchio.
Presto saprò chi sono.
:: letture ::
— Borges J,L., El Aleph, 1952, trad. it. L’Aleph, Feltrinelli, Milano, 2005.
— Borges J,L., Evaristo Carriego, 1955, trad. it. Evaristo Carriego, Einaudi, Torino, 1972.
— Borges J,L., Ficciones, 1956, trad. it. Finzioni, Einaudi, Torino, 1955.
— Borges J,L., El hacedor, 1960, trad. it. L’artefice, Adelphi, Milano, 1999.
— Borges J,L., Elogio de la sombra, 1969, trad. it. Elogio dell’ombra, Einaudi, Torino, 1971.
— Borges J,L., El libro de arena, 1975, trad. it. Il libro di sabbia, Adelphi, Milano, 2004.
— Borges J,L., Los conjurados, 1986, trad. it. I congiurati, Mondatori, Milano, 1996.
— Borges J,L., Textos recobrados (1919-1929), 1996, trad. it.
Il prisma e lo specchio.
Testi ritrovati (1919-1929), Adelphi, Milano, 2009.
— Borges J,L. e Guerriero M., Manual de zoologia fantastica, 1957, trad. it.
Manuale di zoologia fantastica,
Einaudi, Torino, 1998.