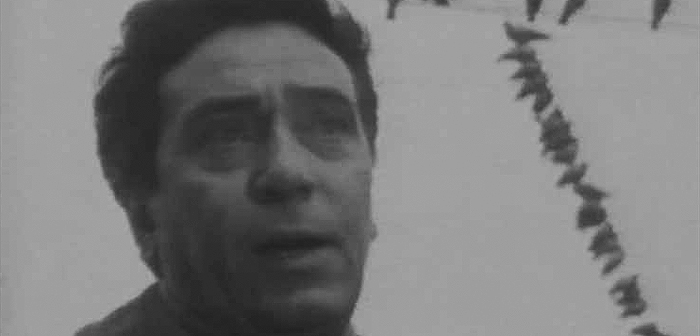
| ||
|
The dark side of the boom: Luciano Bianciardi di Gino Pagliuca |
||
|
L’incipit de La Vita Agra di
Luciano Bianciardi (1963) è di quelli che spiazzano.
È arzigogolato quanto quello famoso dell’Uomo
senza qualità, ma qui, appunto, sembra
senza qualità. Uno sfoggio di erudizione filologica
apparentemente fine a se stessa che costringe anche il lettore
milanese, dopo essersi sciroppato una terribile dissertazione
sull’origine del termine Braida, dove sia una misteriosa via
Adelantemi a snebbiare ricordi ginnasiali se vuol capire qualcosa.
Siamo a Brera e precisamente in via Fiori oscuri, perché
questo è il significato di adeloi
anthemoi. Risolto il rebus il sospetto a questo punto
è che si tratta dell’ennesimo nipotino
dell’Ingegnere di cui non si sentiva il bisogno e la
tentazione sarebbe quella di chiudere e passare al sudoku. Ma sarebbe
un errore, perché basta andare avanti di poche pagine per
addentrarsi in un romanzo non solo di rara sapienza di scrittura ma
che, soprattutto, pare scritto oggi per la feroce critica al
consumismo, con una lucidità sui guasti del
“miracolo italiano” che all’epoca della
pubblicazione, a sinistra aveva solo Pier Paolo Pasolini. E che aveva
come precedente, anche se si tratta di un affresco meno ideologico, la Dolce
vita di Federico Fellini, a cui il romanzo di Bianciardi
evidentemente deve il titolo. Il nome di Luciano Bianciardi
è legato a La vita Agra, nonostante
qualche sporadica ripubblicazione di lavori singoli e una recente
apparizione delle opere complete per i tipi di Isbn in due volumi, con
il titolo polemico di Antimeridiano, per
sottolineare senza giri di parole l’incredibile esclusione
dalla collana mondadoriana dei Meridiani (peccato
che il prezzo di 69 euro a tomo sia più alto di quelli dei Meridiani
e costituisca un ostacolo decisivo all’acquisto).
Il romanzo ha continuato a ottenere una buona fortuna editoriale (un
anno dopo la pubblicazione, Carlo Lizzani ne trasse un film –
interpretato da Ugo Tognazzi – da cui provengono i fotogrammi
che illustrano questa riflessione), anche se ha costituito
una maledizione per il suo autore, rimasto spiazzato dal fatto che non
solo il testo si vendeva bene, ma anche che gli garantiva l'ingresso in
quei salotti borghesi e benpensanti che l’autore odiava per
formazione ideologica e carattere. Milano, come ebbe e dichiarare lo
stesso Bianciardi, doveva cacciarlo a calci nel sedere per come era
stata descritta e invece lo accoglieva a braccia aperte. Come fosse un
giullare; e così la forza dirompente della denuncia veniva
disinnescata. | ||
|
|
(1) [2] [3] [4] | |