|
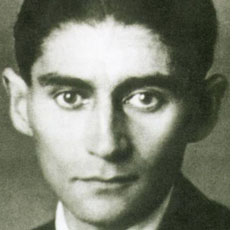 La
forza visionaria con cui uno scrittore come Franz Kafka ha creato un
mondo fantastico allucinante non è molto diversa dal lavoro
introspettivo della costruzione dell’io da parte della
coscienza. Ma la
consapevolezza di sé si esaurisce nella coscienza del
cervello di se
stesso e del corpo in cui è ospitato, o non rimanda
piuttosto a
un’istanza superiore, quella che di solito si indica con la
parola
anima? È evidente che tale quesito è uno degli
interrogativi più
impegnativi dell’umanità. E al quale nemmeno
l’ipotizzata identità tra
mente e cervello della scienza odierna riesce a rispondere. Nondimeno
deve essere stato alla base delle domande che si facevano due autori
distanti nel tempo e nei generi narrativi, ma non nello spirito,
appunto, come Kafka e Philip K. Dick. Il potere della loro fantasia
è
utile a capire la realtà non solo nel senso generale che
accomuna tutti
i grandi artisti, ma anche in quello di una sensibilità
niente affatto
comune che li fa guardare più in là. E che li
rende capaci non solo di
vedere oltre la vita di tutti i giorni e i sacrifici che le persone
sono costrette a fare per sopravvivere costruendosi una
verità
risarcitoria e consolatoria. Ma anche di trasfigurare gli accadimenti,
e i rapporti che questi accadimenti determinano tra gli
individui-personaggi, per cogliere in modo simbolico
“ciò che non si
sapeva, credeva o ammetteva di essere”. Parafrasando un
articolo del Corriere della Sera sul Don
Chisciotte
di Carlo Sini, docente di filosofia teoretica alla Statale di Milano,
potremmo osservare che “quanta saggia consapevolezza sta al
fondo delle
nostre idealizzate fantasie”, tanta è la
capacità dell’arte di Franz
Kafka di “rendere visibile l’oscura trama e la
nascosta realtà delle
nostre vite” (Sini, 2008). La
forza visionaria con cui uno scrittore come Franz Kafka ha creato un
mondo fantastico allucinante non è molto diversa dal lavoro
introspettivo della costruzione dell’io da parte della
coscienza. Ma la
consapevolezza di sé si esaurisce nella coscienza del
cervello di se
stesso e del corpo in cui è ospitato, o non rimanda
piuttosto a
un’istanza superiore, quella che di solito si indica con la
parola
anima? È evidente che tale quesito è uno degli
interrogativi più
impegnativi dell’umanità. E al quale nemmeno
l’ipotizzata identità tra
mente e cervello della scienza odierna riesce a rispondere. Nondimeno
deve essere stato alla base delle domande che si facevano due autori
distanti nel tempo e nei generi narrativi, ma non nello spirito,
appunto, come Kafka e Philip K. Dick. Il potere della loro fantasia
è
utile a capire la realtà non solo nel senso generale che
accomuna tutti
i grandi artisti, ma anche in quello di una sensibilità
niente affatto
comune che li fa guardare più in là. E che li
rende capaci non solo di
vedere oltre la vita di tutti i giorni e i sacrifici che le persone
sono costrette a fare per sopravvivere costruendosi una
verità
risarcitoria e consolatoria. Ma anche di trasfigurare gli accadimenti,
e i rapporti che questi accadimenti determinano tra gli
individui-personaggi, per cogliere in modo simbolico
“ciò che non si
sapeva, credeva o ammetteva di essere”. Parafrasando un
articolo del Corriere della Sera sul Don
Chisciotte
di Carlo Sini, docente di filosofia teoretica alla Statale di Milano,
potremmo osservare che “quanta saggia consapevolezza sta al
fondo delle
nostre idealizzate fantasie”, tanta è la
capacità dell’arte di Franz
Kafka di “rendere visibile l’oscura trama e la
nascosta realtà delle
nostre vite” (Sini, 2008).
E se
“una grande immaginazione genera
l’evento”, questo vecchio adagio reso famoso da
Montaigne è vero anche
per Kafka e per l’inquietante apparente immobilismo privo di
eventi
delle lunghe attese dei suoi romanzi, dove, anche se accade
più di una
cosa, come ne Il castello, si tratta evidentemente
di pretesti
per ragionarci sopra. E per argomentarci su, rendendo assurda la
normalità, con una chiaroveggenza ai limiti della paranoia.
Qualità, o
difetto, ma solo in quanto rese tormentata la sua vita, dello
scrittore, che carica l’atmosfera di inquietudine e paura per
il
pericolo incombente. Un’inquietudine sottile e angosciante
circa il
proprio destino: la più alta espressione della nostra
modernità cinica
e spaventata.
Con una fantasia direttamente proporzionale
all’impegno di sfiorare i confini ultimi
dell’immaginazione, diventare
quello che non si è, oltre i limiti biologici, anagrafici e
sociali,
senza scadere nella banalità dello sliding doors,
Kafka esplora
i territori di pensiero ed esperienza con una sensibilità
particolarmente acuta. Che punta le antenne dritto al cuore del
problema: il rapporto con gli altri. Le vite degli altri sono
inesorabilmente intrecciate alla nostra.
L’identità di ciascuno si
definisce a partire dal dialogo con parenti, insegnanti, amici,
colleghi. Senza di ciò sarebbe impossibile avere proprie
opinioni né
una definita personalità. E, apparentemente, queste
relazioni si
svolgono nella più completa normalità. Ma
l’incapacità di essere
accettati per se stessi è una brutta bestia, quasi come lo
scarafaggio
della Metamorfosi (1916). Che difatti fa odiare a
Gregor Samsa,
svegliatosi una mattina trasformato in insetto, se stesso talmente
tanto, da accettare di essere perseguitato da genitori, sorella e
perfino donna di servizio, fino a lasciarsi morire in seguito alla
ferita provocata sulla corazza dal lancio di una mela da parte del
padre.
In effetti, non occorre trasformarsi in un insetto,
s’intende
metaforicamente, e nemmeno essere coinvolti in un processo che non ha
capi di imputazione, come avverrà per un altro immortale
personaggio
dello scrittore praghese, Joseph K. de Il processo,
per vivere
simili situazioni senza via di scampo. Nella società
attuale, ma non
solo, è proprio questo tipo di evento eccezionale generato
dall’immaginazione kafkiana ad angosciare la maggior parte
delle
persone. Kafka concepì le sue fantasie agli albori
dell’età
contemporanea. Nacque a Praga nel 1883, figlio di una coppia di ebrei
di lingua tedesca, più umile figlio di macellaio lui,
più agiata erede
di commercianti lei, che insieme aprirono un negozio di
“galanterie”,
guanti, bigiotterie, cappelli, attività capace di renderli
sufficientemente benestanti da sognare per Franz quella laurea in
giurisprudenza che apriva le porte ai funzionari
dell’Impero.
Gli
studi, sgraditissimi a Kafka, lo portarono ad assumere un impiego
presso la compagnia di assicurazioni triestina delle Generali (nel 1908
Trieste era ancora parte dell’Impero austro-ungarico) e poi,
nel 1917,
in un istituto di assicurazioni per infortuni sul lavoro, costituito
anche per dissuadere gli operai dal votare per la socialdemocrazia. Fu
proprio per questa sua attività - che in seguito dovette
lasciare per i
sanatori dove curare una tubercolosi che lo stroncò nel 1924
a Kirling,
presso Vienna - che lo scrittore, caso quasi unico all’epoca,
conobbe
la realtà delle prime fabbriche, visitate per catalogare i
rischi di
invalidità che correva la manodopera nello svolgere le
proprie mansioni.
Gran parte della sua produzione
letteraria, costituita soprattutto da racconti, tra cui La
metamorfosi,
fu scritta proprio tra il 1910 e il 1922, e pubblicata postuma
dall’amico Max Brod che fortunatamente ignorò le
disposizioni
dell’autore di distruggere i manoscritti. La
metamorfosi, scritta nel 1915, uscì nel 1916,
insieme a La condanna e prima di Nella
colonia penale (1919), Il medico di campagna
(1919, ed. it. 1981), e dell’autobiografica Lettera
al padre (1919, ed. it. 1959). I tre romanzi, Il
processo (1914-1915), Il castello
(1921-1922) e America,
(iniziato nel 1910 e più volte ripreso), non furono invece
mai
definitivamente licenziati dall’autore e uscirono tutti e tre
postumi.
Kafka,
che aveva anche visitato Parigi e viaggiato in Germania e
nell’Italia
settentrionale, pur essendo, anche da questo punto di vista, un
intellettuale completo, non provò mai a rendere la sua prosa
in lingua
tedesca molto più ricca lessicalmente del tedesco parlato in
Boemia. Ma
fu proprio il suo linguaggio conciso e freddo, e per certi versi anche
spietatamente umoristico, e a volte anche cinico, a rendere
così bene
l’idea dello spaesamento psichico della vittima innocente:
una
condizione esistenziale prima ancora che storica in cui molti
però
hanno visto una profezia dell’Olocausto. Morire senza sapere
perché, ma
anche senza che i carnefici lo sappiano, è infatti quanto
accadde a sei
milioni di ebrei appena vent’anni dopo, durante la Seconda
guerra
mondiale. Capitolare e non difendersi, ma divenendo anzi complici dei
persecutori, e annullando la propria identità, è
il destino dei tanti
Joseph K. che, anche senza essere le vittime di un odio razziale eretto
a sistema di governo come quello della Germania hitleriana, subiscono
intolleranze e ingiustizie oggi come ieri. Interpretazione in cui molti
hanno visto la rappresentazione della parabola
dell’alienazione
dell’individuo nell’epoca dell’ascesa del
capitalismo. Ma tra le righe
di Kafka si legge anche un’originale messa in scena
dell’ eterna
tensione verso la libertà: sono altro da me e quindi posso
inventarmi
una vita diversa; Gregor immaginava infatti di poter lasciare
l’odiato
impiego una volta pagati i debiti del padre. L’agrimensore
protagonista
del Castello cercava la promozione sociale
attraverso
l’incarico presso il conte. Peccato che la vita immaginata si
riveli un
incubo peggiore della realtà, e da cui si esce unicamente
morendo, o
con un esaurimento nervoso.
Lost in time,
in space and meaning, come recita in chiusura The
Rocky Horror Picture Show.
I personaggi di Kafka sono infatti perseguitati da istituzioni
immateriali, senza luogo e senza date, o da persone che agiscono senza
senso, emblemi di un disagio esistenziale universale. I meccanismi
oppressivi che Kafka aveva immaginato profeticamente rispetto ai lager
nazisti e al “tutti contro tutti” del mondo post 11
settembre sono
figli della paura e dell’odio. Una paura del nemico, un odio
del
diverso che, come ha osservato recentemente Zygmunt Bauman, e non solo
lui, sono i principali marcatori dell’identità.
Odiando qualcuno, ha
affermato il sociologo in Paura liquida (Bauman,
2007) il
penultimo suo lavoro, l’uomo si sente legittimato a sostenere
con forza
la causa per cui odia, convincendosi sempre più che sia una
causa più
che giusta. L’odio diventa allora per così dire
neutro rispetto al suo
significato originale, ma assume l’ennesima faccia con cui il
potere
maschera la sua volontà di rendere inermi gli
individui coscienti.
Facendone così uno strumento per la sua
perpetuazione.
Scienza e
coscienza, e sicuramente anche fantascienza come capacità
immaginativa
e visionaria di costruirsi un io indipendente a partire dal
fantasticare sulla società futura, sono gli unici strumenti
per opporsi
a questo stato di cose. Ma si arriva a servirsene solo prendendo le
distanze una volta per tutte proprio dai pregiudizi di cui si alimenta
l’odio per il diverso da sé. Cosa che si
può fare più facilmente
acquisendo “la consapevolezza di quanta folle e ignorante
presunzione”,
come ha scritto Carlo Sini, “abita le opinioni e i costumi
del
cosiddetto vivere civile” (Sini, ibidem). Un vivere civile
che nelle
farneticazioni delle trame e dei personaggi di Kafka si identifica con
la mostruosa macchina dell’apparato burocratico: un insieme
di regole
senza significato che però hanno l’arrogante
pretesa di regolare la
vita sociale. Per quanto giudizio critico e disincanto della nostra
modernità possano combattere questa ipocrisia, il livello di
ignoranza
e intolleranza in cui è ricaduta larga parte della
società oggi non fa
presagire nulla di buono circa l’esito di questa guerra. La
parte
sbagliata del fronte è anche presidiata da un cattivissimo e
mal
compreso concetto di comunicazione che si spaccia, in malafede, per
dialogo, mentre con questo non ha niente a che fare. Con il dialogo ci
si spiega e ci si capisce. La comunicazione parla per slogan al solo
scopo convincere. Come ci hanno insegnato e ci hanno abituati la
pubblicità e il marketing. E gli slogan attuali
più utilizzati fanno
presa su sentimenti identitari deteriori. Disvalori che si nutrono
più
di convenzioni che di convinzioni. Così si fanno strada la
scomparsa
del senso di appartenenza - a una comunità, a una lingua, a
una civiltà
- e l’assenza del desiderio di conoscere l’altro e
di mettersi in
relazione con il diverso da sé.
Ma se,
come aveva ben capito e
raccontato nei suoi romanzi Kafka, non per niente contemporaneo di
Sigmund Freud, le colpe imputate agli altri dimorano nel nostro
inconscio, vale per tutti, e rievoca il suo insegnamento,
l’inquietudine prodotta dal racconto in una riga di Thomas
Bailey
Aldrich, Sola con la sua anima: “Una
donna sta seduta sola in
casa. Sa che nel mondo non c’è più
nessuno: tutti gli altri esseri
umani sono morti. Bussano alla porta” (Aldrich
T.B, 2007).
:: letture ::
Aldrich T.B. Sola con la sua anima, in A.A.V.V., Antologia della letteratura fantastica, (a cura di) Jorge L. Borges, Silvina Ocampo e Adolfo Bioy Casares, Einaudi, Torino, 2007.
Bauman Z., Paura liquida, Laterza, Bari, 2007.
Kafka F., Il processo, (a cura e con un saggio di Giorgio Zampa), Adelphi, Milano, 1973.
Kafka F., Lettera al padre, Il Saggiatore, Milano, 1959.
Kafka F., Un medico di campagna, (a cura di Giuliano Baioni), Mondadori, Milano, 1981.
Kafka F., Racconti, (a cura di Ervino Pocar), Mondadori, Milano, 1970.
Kafka F., La metamorfosi e altri racconti, Garzanti, Milano, 1966.
Kafka F., Il castello, Oscar Mondadori, Milano, 1979.
Sini C., E Don Chisciotte incontrò Paul Klee, “Corriere della Sera”, 11 ottobre 2008. |

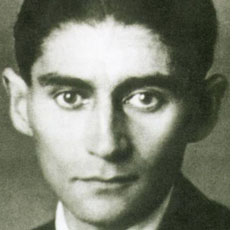 La
forza visionaria con cui uno scrittore come Franz Kafka ha creato un
mondo fantastico allucinante non è molto diversa dal lavoro
introspettivo della costruzione dell’io da parte della
coscienza. Ma la
consapevolezza di sé si esaurisce nella coscienza del
cervello di se
stesso e del corpo in cui è ospitato, o non rimanda
piuttosto a
un’istanza superiore, quella che di solito si indica con la
parola
anima? È evidente che tale quesito è uno degli
interrogativi più
impegnativi dell’umanità. E al quale nemmeno
l’ipotizzata identità tra
mente e cervello della scienza odierna riesce a rispondere. Nondimeno
deve essere stato alla base delle domande che si facevano due autori
distanti nel tempo e nei generi narrativi, ma non nello spirito,
appunto, come Kafka e Philip K. Dick. Il potere della loro fantasia
è
utile a capire la realtà non solo nel senso generale che
accomuna tutti
i grandi artisti, ma anche in quello di una sensibilità
niente affatto
comune che li fa guardare più in là. E che li
rende capaci non solo di
vedere oltre la vita di tutti i giorni e i sacrifici che le persone
sono costrette a fare per sopravvivere costruendosi una
verità
risarcitoria e consolatoria. Ma anche di trasfigurare gli accadimenti,
e i rapporti che questi accadimenti determinano tra gli
individui-personaggi, per cogliere in modo simbolico
“ciò che non si
sapeva, credeva o ammetteva di essere”. Parafrasando un
articolo del Corriere della Sera sul Don
Chisciotte
di Carlo Sini, docente di filosofia teoretica alla Statale di Milano,
potremmo osservare che “quanta saggia consapevolezza sta al
fondo delle
nostre idealizzate fantasie”, tanta è la
capacità dell’arte di Franz
Kafka di “rendere visibile l’oscura trama e la
nascosta realtà delle
nostre vite” (Sini, 2008).
La
forza visionaria con cui uno scrittore come Franz Kafka ha creato un
mondo fantastico allucinante non è molto diversa dal lavoro
introspettivo della costruzione dell’io da parte della
coscienza. Ma la
consapevolezza di sé si esaurisce nella coscienza del
cervello di se
stesso e del corpo in cui è ospitato, o non rimanda
piuttosto a
un’istanza superiore, quella che di solito si indica con la
parola
anima? È evidente che tale quesito è uno degli
interrogativi più
impegnativi dell’umanità. E al quale nemmeno
l’ipotizzata identità tra
mente e cervello della scienza odierna riesce a rispondere. Nondimeno
deve essere stato alla base delle domande che si facevano due autori
distanti nel tempo e nei generi narrativi, ma non nello spirito,
appunto, come Kafka e Philip K. Dick. Il potere della loro fantasia
è
utile a capire la realtà non solo nel senso generale che
accomuna tutti
i grandi artisti, ma anche in quello di una sensibilità
niente affatto
comune che li fa guardare più in là. E che li
rende capaci non solo di
vedere oltre la vita di tutti i giorni e i sacrifici che le persone
sono costrette a fare per sopravvivere costruendosi una
verità
risarcitoria e consolatoria. Ma anche di trasfigurare gli accadimenti,
e i rapporti che questi accadimenti determinano tra gli
individui-personaggi, per cogliere in modo simbolico
“ciò che non si
sapeva, credeva o ammetteva di essere”. Parafrasando un
articolo del Corriere della Sera sul Don
Chisciotte
di Carlo Sini, docente di filosofia teoretica alla Statale di Milano,
potremmo osservare che “quanta saggia consapevolezza sta al
fondo delle
nostre idealizzate fantasie”, tanta è la
capacità dell’arte di Franz
Kafka di “rendere visibile l’oscura trama e la
nascosta realtà delle
nostre vite” (Sini, 2008).