|
Casablanca
di Marc Augé
Ci sono momenti nella vita di ognuno in cui sembra essenziale fermarsi per recuperare “il tempo perduto”, per riannodare alcuni ricordi – selezionati secondo logiche imperscrutabili e non predefinite – e costruire molteplici trame di senso della propria biografia. Le vie della Recherche possono essere le più disparate. Marc Augé compie un viaggio nella sua memoria involontaria innescato da un film, Casablanca, le cui atmosfere, i cui personaggi, le cui immagini in qualche misura si intersecano con le esperienze della sua infanzia e della Seconda guerra mondiale, creando un intreccio unitario, un amalgama significativo di ricordi, riappropriazione identitaria, emozioni. È il cinema stesso in qualche misura – come suggerisce velatamente lo stesso Augé – ad avere un rapporto particolare con il tempo e la memoria: per la sua capacità di creare immaginari duraturi e capaci di interloquire con i percorsi della memoria collettiva ed individuale, per il suo carattere di testimonianza, ma anche per il suo stesso principio tecnico-linguistico. La magia del montaggio è quella della selezione, del gioco incantato tra visibile e non visibile, tra detto e non detto, simile a quello tra memoria ed oblio. Le sequenze possibili sono infinite, così come i percorsi narrativi, i raccordi, gli accostamenti potenziali. Lo stesso è per il ricordo, che alimenta sempre di senso vivificante e magico la riscoperta costante della nostra identità. Luca Bifulco |
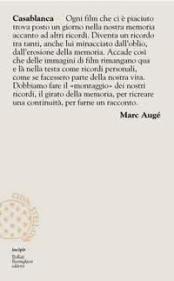 di Marc Augé
titolo Casablanca
editore Bollati Boringhieri, Torino, 2008
pagine 85
prezzo € 9,00
|
|
|
[ torna a letture ] |
||
|
|
|
L’era post-americana
di Fareed Zakaria
Allievo di Samuel Huntington ad Harvard, Fareed Zakaria tenta con L’era post-americana l’operazione che era riuscita al suo maestro: mettere in guardia la potenza dell’America dalle future minacce alla sua sopravvivenza. Se Huntington era profetico nel 1993 con Lo scontro delle civiltà in cui paventava la minaccia islamica, Zakaria non lo è perché alla politologia preferisce il giornalismo alla moda. Riesce tuttavia a non trasformarsi in una delle tante Cassandre che affliggono l’Occidente sui rischi dell’egemonia cinese, tratteggiando punti di forza e anche di debolezza dei nuovi giganti asiatici. Liquidato l’Islam come “roba del VII secolo”, il rampante giornalista indiano naturalizzato americano comincia a snocciolare cifre da capogiro sulla forza di quella che Rampini ha chiamato “l’Impero di Cindia”, indicando i punti su cui gli Usa devono fare di più e quelli di cui non devono preoccuparsi più di tanto. La Cina non costituirà mai, verosimilmente, una minaccia militare; l’India non raggiungerà mai la forza della Cina; gli Usa non perderanno la loro posizione di potenza, almeno non in questo secolo. Al termine dell’opera presenta sei intelligenti consigli che i diplomatici americani dovrebbero seguire per evitare che gli Usa seguano lo stesso declino dell’Impero britannico, che Zakaria agita come uno spauracchio per tutta l’opera. Equilibrata e assennata, l’analisi di Zakaria pecca tuttavia di semplicismo in molti punti. L’era post-americana è infatti un libro che, come del resto sostiene la postfazione, è scritto a uso e consumo dei dirigenti americani. Un utile spaccato di come pensa l’Impero. Roberto Paura |
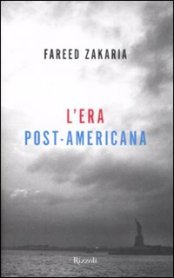 di Fareed Zakaria
titolo L’era post-americana
editore Rizzoli, Milano, 2008
pagine 285
prezzo € 19,00
|
|
|
[ torna a letture ] |
||
|
|
|
La lingua che verrà
di Hélenè Cixous, Jacques Derrida
Jacques Derrida è considerato il padre del decostruzionismo, oltre che uno dei più influenti pensatori degli ultimi anni, in virtù dell’impatto che il suo pensiero ha avuto su gran parte del dibattito contemporaneo, con la messa in crisi dei monoliti logico/sistemici a favore dei molteplici margini di senso, delle difformità o frammenti semantici finanche aporetici, che ogni realtà o ragionamento possiede in sé. Hélène Cixous è una delle più rinomate intellettuali francesi, autrice di numerose opere di saggistica o letterarie. Il libro riporta i momenti salienti del dialogo che ha avuto luogo tra questi due intellettuali in occasione del primo “Seminario di Barcellona” tenutosi all’Università di Barcellona nel 2002. I temi trattati, e ben riportati nell’esile volume, sono i più svariati. Buona parte della discussione, dal tono spesso tenuemente evocativo, verte sulla lingua e sull’intrinseca accoglienza dell’altro e della sua differenza, che può risiedere nella lingua stessa, e che rimane implicita nella singolarità di ogni complesso linguistico e nella magica ricchezza e molteplicità semantica che lo caratterizza. Ciò mette in moto una richiesta di rispetto dell’alterità che nasce dalla relativizzazione di quel carattere quasi sacrale che spesso si associa all’identità. È questa la base per i due intellettuali per riflettere, con tono ispirato e densissimo, di questioni anche sociopolitiche fondamentali, che vanno dal multiculturalismo al colonialismo, e ancora oltre. Luca Bifulco |
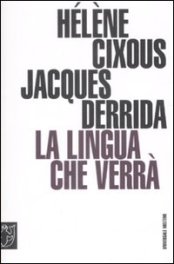 di Hélenè Cixous, Jacques Derrida
titolo La lingua che verrà
editore Meltemi, Roma, 2008
pagine 116
prezzo € 14,00
|
|
|
[ torna a letture ] |
||