| | prima parte | | ||
|
Il giudizio dei mostri. Il fantastico italiano e i suoi lettori
| seconda parte |
di Vittorio Frigerio
|
||
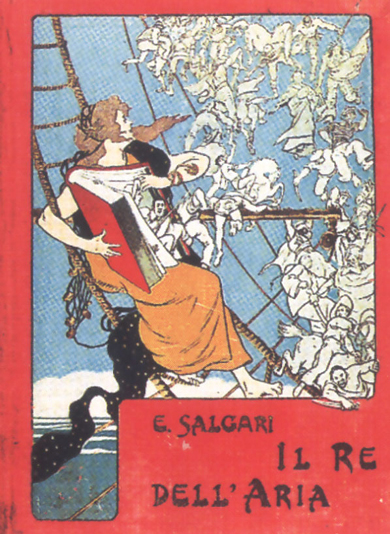
|
I
l lavoro recentemente pubblicato da Fabrizio Foni, Alla fiera dei mostri. Racconti pulp, orrori e arcane
fantasticherie nelle riviste italiane 1899-1932, di cui abbiamo già scritto nel numero precedente di Quaderni
d’Altri Tempi non può non occuparsi della dimensione del Grand Guignol e quindi di tutto
l’armamentario truculento e feroce che lo caratterizzava e che spesso ruotava intorno al patibolo.
È lo spettacolo del patibolo che, per Zolla1, fa che “il pubblico dei paesi fortemente industriali è giunto a misure assai violente come norma, e un dosaggio minore lo irrita invece di affascinarlo, produce noia e impazienza” (Zolla, 20). L’eccesso sistematico, la spinta perpetua ad andare oltre, a sorpassare quanto si offre come estremo e dunque finalmente insorpassabile, diventa la condizione sine qua non per la scrittura di testi marcati dal punto di vista generico, e che si sforzano di portare il lettore sempre un gradino più in alto, su di una scala di sensazioni ipoteticamente interminabile. O per dirla ancora con Foni, “la grande bolgia di divertimenti vuole divertimenti sempre più grandi, in senso letterale ed emozionale” (Foni, 278). |
|
|
Foni fa notare giustamente come temi, soggetti, personaggi, situazioni, emozioni, transitino irresistibilmente da un media all’altro a mano a mano che gli sviluppi tecnici offrono all’industria culturale, e al pubblico di massa che essa serve, nuovi sbocchi per mettere in scena diversamente situazioni simili. La cinematografia internazionale attingeva al Grand Guignol francese e viceversa faceva il Grand Guignol; i due media prendevano dalla narrativa popolare, e quest’ultima pescava da entrambi, con la conseguente creazione di una pressoché infinita serie di varianti e di stereotipi (Foni, 269). Rimane forse da determinare se la transizione da un genere nell’altro sia o meno “rapporto di degradazione, d’avvilimento” (Zolla, 29). Un numero sufficiente di studi pare aver mostrato negli ultimi decenni come tali mutamenti non possano arbitrariamente ridursi a degenerazioni, ma rappresentino invece sistemi complessi di passaggio di senso e d’immagine tra media dotati di qualità e di capacità particolari, non equivalenti, ma neppure riducibili a gerarchie rudimentali dettate da preconcetti tradizionali2. Fatto sta che non si dà in generale evoluzione al livello dei
contenuti, se non in misura spesso minima o grazie
all’apporto eccezionale di un autore particolarmente dotato e
capace d’imporre una certa personalità attraverso
schemi conosciuti, ma piuttosto reiterazione di dati
essenziali.
È forse a questo punto che deve situarsi
un esame della natura di codesto “fantastico”,
così onnipresente, così universalmente letto, e
così totalmente dimenticato. Chi è questa
“gente”? Perchè dunque ama queste cose?
Cosa può giustificare la distanziazione sorridente, il second
degré presente perfino nell’opera di
massa stessa, come qui in Leroux, peraltro maestro di questo tipo di
discorso e capace d’infarcire i suoi romanzi di riflessioni
esperte sulla sue stessa pratica3?
Zolla, situandosi sulla scia di una
tradizione critica già da lungo tempo consolidata al momento
della pubblicazione dei suoi lavori sulla cultura di massa4, oppone al rapporto schietto che unisce il lettore all’opera di
qualità, che porta a conoscenza di sè e del
mondo, quella lettura succube che caratterizzerebbe il consumatore di
finzioni massificate. La sua tesi si basa sul concetto di
“fantasticheria”, riassumibile come immaginazione
povera, che si concentra su alcuni elementi stereotipi impossibili da
volgere in realtà articolata, in quanto privi di
autenticità e di conseguenze. Proprio della fantasticheria
sembra quel girovagare al contempo affascinato e superficiale del
lettore di storie fantastiche, simile al pubblico delle fiere.
|
||
| (1) [2] | ||
|
|
||||||
|
1.
Elémire Zolla,
Volgarità
e dolore, Bompiani, Milano, 1962, pag. 141. |
2.
Si vedano a riguardo
lavori di Marc Lits sul concetto di “cultura mediatica”, in particolare in La Culture médiatique au XIX et XX siècles, Les dossiers de l'ORM COMU No 6, Novembre 1999 (disponibile a: http://etc.dal.ca/belphegor/ vol7_no1/fr/bibbel_fr.html) |
3.
Su questo autore si
veda
in particolare il numero 7 (autunno 1996) della rivista Tapis-franc, “Leroux, la modernité dans les ombres”, diretto da Charles Grivel. |
4.
Cioè a partire
dall’articolo di Sainte-Beuve “De la littérature industrielle”, pubblicato sulla Revue des Deux Mondes il primo settembre 1839. |
|||
|
|
||||||
|
|
|
|